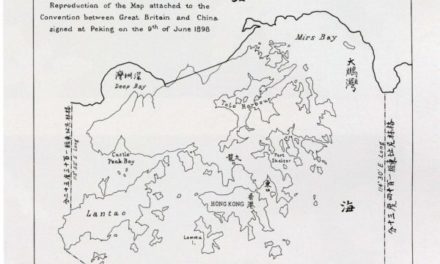In copertina un murales di Bansky a Dover, Inghilterra
Di BRUNO MONTESANO
Boris Johnson incarna al meglio l’attuale spirito del tempo. Nazionalista, misogino e classista, l’ex sindaco di Londra formato a Eton guiderà il paese fuori dalla UE, forse con un accordo “Canada plus” che azzeri tariffe e quote ma senza libertà di movimento per le persone. Secondo il premier inglese, fuori dalla Corte Europea di Giustizia, sarà possibile riacquisire sovranità, e, lasciando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si potrà finalmente rivedere la legislazione sui diritti umani. L’autoritarismo neoliberale inaugurato da Thatcher torna alla ribalta sotto le sembianze di Johnson all’insegna del “free market, strong state”. Si tratta di una versione incattivita del populismo autoritario di cui parlava Stuart Hall negli anni ‘80: uno slittamento verso la coercizione nel rapporto tra consenso e dominio necessari alla stabilizzazione dell’egemonia. Certo Johnson vive in una fase storica diversa da quella di Thatcher e quindi anche lo spazio accordato alla spesa pubblica è maggiore. La gestione securitaria dei problemi sociali, l’accentuarsi della retorica e della pratica nazionalista e patriarcale, il panico morale contro i migranti, la privatizzazione e la riduzione del welfare, la retorica dell’imprenditorialità e del successo, la deregolamentazione finanziaria, sono tutte caratteristiche comuni ai due politici conservatori. Il nazionalismo era già uno degli elementi che costituirono la strategia di Thatcher, dall’attacco alle Falkland fino all’opposizione all’integrazione europea. Da un punto di vista più generale, se l’individualismo proprietario recise i legami di cittadinanza e solidarietà, la comunità poteva esser tenuta insieme solo sotto la bandiera della nazione e dei valori tradizionali della responsabilità individuale e della “moralità”. La mancata elaborazione della fine dell’impero nel secondo dopoguerra fu la base del nuovo razzismo inglese, poi fattosi senso comune dalla fine degli anni ’60 con il Powellismo, l’insieme di discorsi e pratiche razziste contro i migranti delle ex colonie inaugurato dal politico conservatore Enoch Powell, vero padre spirituale dello UKIP (UK Independence Party) di Farage. Elementi di questa visione si sono sviluppati sotto Thatcher nella lotta contro il nemico interno – sempre più identificato con le minoranze, in particolare nere – e contro gli scrocconi del welfare, identificati come prevalentemente neri. Queste tesi vennero poi “civilizzate” da parte del New Labour di Blair e Brown con una più ampia legislazione antidiscriminazione e una retorica multiculturalista, poi soppiantata dopo la War on terror, e con politiche migratorie maggiormente restrittive, la cui durezza veniva rivendicata. Ieri come oggi il razzismo risponde alla volontà di trovare delle spiegazioni immediate al proprio disagio e nel preservare il privilegio acquisito. Parte del mondo economico e politico possono così frammentare la popolazione e assegnare i mestieri più sgradevoli e meno retribuiti a una sua frazione, spostando il rancore verso chi viene rappresentato come straniero e inferiore. Spinte dall’alto e dal basso convergono in tal modo nella stabilizzazione di un sistema indebolito dalla polarizzazione della ricchezza.
Il nazionalismo era già uno degli elementi che costituirono la strategia di Thatcher, dall’attacco alle Falkland fino all’opposizione all’integrazione europea.
Quaranta anni dopo, nel 2016, dopo diversi anni di austerità e aumento delle disuguaglianze, la campagna referendaria per uscire dalla UE fu incentrata così sulla paura di file di migranti intenzionati ad assalire welfare e lavori degli inglesi. La campagna elettorale fu molto “bianca” e inglese (English), cancellando la complessità della composizione sociale della popolazione britannica (British, ossia comprensiva della popolazione parte dell’Impero britannico) e vagheggiando un ritorno alla potenza dell’impero. Come suggerisce Gurminder K.Bhambra (2017), la percezione del declino relativo della propria posizione rispetto alle minoranze è stata uno dei fattori che hanno determinato la Brexit. Secondo Robbie Shilliam (2018), sin dalla Thatcher, deindustrializzazione, austerità e precarizzazione del lavoro avrebbero ridotto il vantaggio tra la classe media e operaia bianche rispetto ai migranti e ai cittadini delle ex colonie, “tradizionalmente” socialmente svantaggiati rispetto ai cittadini bianchi inglesi. Come argomenta Shilliam, nella Brexit la classe ha funzionato da razza: l’astrazione di una classe operaia bianca inglese impoverita nei salari e nell’accesso al welfare da migranti europei e non, è stata mobilitata per ripristinare il “salario” economico e psicologico derivante dall’essere inglesi bianchi e creare un Regno Unito più deregolamentato. Non a caso, secondo gli autorevoli sondaggi di Lord Ashcroft – già membro dei Tories -, le minoranze del paese (circa il 12% della popolazione) hanno votato in maggioranza per il remain, mentre gli inglesi bianchi hanno votato per lasciare la UE. Le ragioni del leave, sempre secondo Ashcroft, sono da individuare in primo luogo nella ripresa del controllo sulle decisioni del Regno Unito – che nella classe media potrebbe rappresentare un’astrazione della volontà di tenere fuori gli stranieri-, e in secondo luogo per limitare l’immigrazione. Ed è nel relativamente più ricco Sud che il leave ha prevalso con maggior misura, con un determinante ruolo della classe media – non a caso vera base elettorale dello Ukip– più che della working class. Come negli USA e in Italia, chi vota contro i migranti è anche chi vive in aree dove il loro numero è più basso: così le regioni dove ha prevalso il leave sono anche quelle dove sono arrivati meno migranti. Così, in queste elezioni, sorta di “secondo referendum” sulla Brexit, il popolo ha deciso che un fervente xenofobo dovrà guidarlo fuori dall’Europa per proiettarlo sul mondo. Infatti, secondo Johnson – che ha definito chi indossa il velo rapinatore e simile a una cassetta della posta-, gli europei devono smetterla di sentire il Regno Unito come casa propria. Si tratta di 3 milioni e mezzo di cittadini, di cui 1,5 dai paesi A8 (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Slovenia). Tra questi, i cittadini nati in Polonia rappresentano la seconda comunità più numerosa (827.000 persone), dopo quella indiana (1.412.958, il 2,5% della popolazione). Assieme alle altre comunità dell’Est Europa, dal referendum del 2016 molti polacchi hanno visto gli attacchi razzisti nei loro confronti crescere esponenzialmente. La volontà del popolo espressa con il referendum del 2016 si scarica così su ampi segmenti di lavoratori con l’unica colpa di non esser nati nel luogo giusto. E se non avranno fatto domanda per il farraginoso EU settlement scheme potranno esser deportati. Le possibilità di mobilità – e ricerca di migliori condizioni di vita – dentro la UE così si restringono irrimediabilmente.
La volontà del popolo espressa con il referendum del 2016 si scarica così su ampi segmenti di lavoratori con l’unica colpa di non esser nati nel luogo giusto
Johnson, con la sua intenzione di riprendere il controllo delle frontiere, contro “armi, droga, criminali e terroristi” provenienti dalla UE, vuole ridurre l’accesso al welfare per gli immigrati e aumentare la selettività nella politica migratoria. L’idea è quella di seguire il sistema australiano a punti, ove la forza lavoro che può accedere nel paese è solo quella più qualificata. Una scelta coerente con le indicazioni dell’Economist del 14 Novembre 2019 e di ampia fascia del mondo liberale, politico e accademico. Accanto a ciò, Johnson intende lasciare l’unione doganale e stringere accordi commerciali con paesi terzi, in particolare con Trump e, attraverso i paesi ancora parte del Commonwealth, muoversi sul mercato globale secondo una rinnovata logica imperiale. La Scozia però, che votò per rimanere durante il referendum, ha appoggiato in massa l’europeista Scottish National Party (SNP) e reclama ancora una volta l’indipendenza, mettendo a rischio – assieme alla diatriba intorno al confine tra Regno Unito e Repubblica di Irlanda – l’unità della Gran Bretagna.
Il programma dei Tories propone di abbassare le tasse, incrementare la repressione, introdurre l’identificazione per votare – con effetti di massa per il voto della comunità nera e delle minoranze del paese- e ampliare la spesa per sanità e scuola. Aumenti di spesa ovviamente risibili se confrontati con il decennio di austerità che ha determinato l’enorme diseguaglianza tra le classi, a cui si accompagnano la stagnazione dei salari, l’incremento del numero dei senza casa e il declino dei servizi pubblici – problemi largamente riconosciuti anche da quotidiani come il Financial Times (FT) e che solo il programma del Labour avrebbe potuto affrontare. Secondo gli studi dell’autorevole Institute for Fiscal Studies (IFS), il manifesto di Johnson è comunque ispirato da un approccio rigorista.
Contro il programma laburista da “socialismo in un solo paese” attaccato dal FT – che ha appoggiato i Lib-Dem-, Johnson ha cementato un blocco sociale a colpi di promesse di maggiori fondi alla National Health Service (NHS) grazie ai guadagni della Brexit, severità contro gli stranieri che rubano il welfare e aumentano la criminalità, e rassicurazioni a operatori finanziari e imprenditori contro il socialismo laburista e sul fatto che con la Brexit realizzata il Regno Unito diventerà un paese ancora più vantaggioso per chi investe. Probabilmente questo significherà creare una sorta di paradiso fiscale che affaccia sul continente europeo. Liberati dai lacciuoli della UE – vista dai brexiteers dello European Research Group di Rees-Mogg come un’istituzione troppo centralizzata e statalista (Bourne 2016) -, il Regno Unito potrà finalmente tornare a prosperare. Ciò che si prospetta sono però accordi commerciali simili al CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) e al TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), dove la desiderata sovranità politica cede il passo alle ragioni dei grandi monopoli. Questi accordi infatti riducono gli standard ambientali e sociali e istituiscono organi di conciliazione – i disputes settlement – che possono comminare multe agli stati che riducono i profitti delle aziende. In questo contesto si iscrive il rischio, più volte denunciata dal Labour, che la NHS venga smembrata da aziende americane. Inoltre, secondo l’IFS, dal 2016 il Pil è cresciuto del 2.5–3.0% (£55–£66 miliardi) meno di quanto sarebbe cresciuto senza Brexit. Intanto i neofascisti inglesi, da Britain First all’English Defence League di Tommy Robinson, si stanno iscrivendo al partito conservatore in virtù della condivisione di valori e progetti con la nuova leadership.
Dalle elezioni il Labour di Corbyn esce pesantemente sconfitto totalizzando 10.295.912 voti contro i 11.390.099 del 2017 (perdendo 10 punti percentuali). Nonostante l’innovativa radicalità del programma – tasse su redditi più alti, sulle transazioni finanziarie e sulle imprese inquinanti per 82 miliardi, fine di molte agevolazione per le imprese, ambizioso Green New Deal, investimenti pubblici per il diritto alla casa, all’istruzione, alla salute e all’accesso alla rete. Corbyn ha già affermato che non si ripresenterà alle prossime elezioni ma al contempo non vuole lasciare campo libero ai suoi avversari interni e quindi, mantenendo la quasi militaresca presa sul partito realizzata negli ultimi anni, cerca di impedire che il Labour torni ai tempi della Terza Via di Blair. Quest’area, assieme a diversi commentatori, infatti già accusa il segretario per l’eccesso di radicalità nell’agenda economica, per l’ambiguità sulla Brexit – che pure non ha premiato così radicalemnte i Lib-dem – e per la questione dell’antisemitismo, in parte strumentalizzato, in parte reale. L’antisemitismo a sinistra è stato colpevolmente sottovalutato dalla dirigenza, vittima di una sindrome da assedio che le ha impedito di riconoscere la concretezza del problema e la sofferenza patita da una fascia del suo elettorato. Se l’accusa di antisemitismo ai critici di Israele è piuttosto in voga, è pur vero che molti militanti di sinistra hanno difficoltà a distinguere tra ebrei e israeliani o tra israeliani e estremisti di destra. D’altro canto, certamente gli attacchi strumentali da parte dei quotidiani del gruppo Murdoch (The Sun, The Times, The Sunday Times) celano una forte ipocrisia dal momento che hanno sempre inferiorizzato tutte le altre minoranze del paese. Per non parlare dell’antisemitismo e del razzismo di Johnson e di molti Tories, per lo più taciuto dagli stessi media che attaccavano Corbyn.
Ad ogni modo, la leadership del Labour verrà rinnovata a fine Marzo. I due candidati più forti sono la corbyniana ministra ombra del commercio Rebecca Long Bailey e il più moderato ministro ombra per la Brexit Keir Stammer. Long Bailey, come altri commentatori, ha sottolineano che per quanto la radicalità del programma sia stata apprezzata, probabilmente questo sia stato percepito come troppo ambizioso o difficile da realizzare. Sarebbe altrimenti inspiegabile l’exploit delle elezioni del 2017 – che portarono il partito al 42% contro il 45 dei Tories-, l’enorme incremento di iscrizione al partito durante l’ascesa di Corbyn e il vasto consenso ancora goduto tra i giovani. Come spesso si sente dire, il realismo capitalista ha fatto sì che sia più facile immaginare la fine del mondo che quella del sistema economico in cui ci troviamo.
Alcuni opinionisti hanno sostenuto che se Corbyn avesse deciso di appoggiare la Brexit, gli esiti sarebbero stati diversi dal momento che i Tories hanno vinto nelle aree dove il leave prevalse. In realtà, oltre alla discutibilità in sé delle ipotesi di “Lexit” (left wing exit), probabilmente qualsiasi sbilanciamento avrebbe comportato dei costi, come si vede dalla analisi dei flussi di voti di YouGov. Il Labour ha perso l’11% dei voti a favore dei Tories – strappando solo il 5% dei flussi provenienti dai conservatori- e il 9% verso i Lib-dem, riuscendo così a ridurre sia il numero di remainers che di leavers. D’altronde, per quanto il Labour sia stato votato in maggioranza da elettori remainers, una netta scelta pro remain avrebbe sì attratto alcuni elettori ma ne avrebbe allontanati altri. Sicuramente il sistema elettorale dei collegi uninominali ha penalizzato il fronte europeista che forse avrebbero potuto fare delle alleanze contro i Tories, vero partito della Brexit. Ma troppo marcata era la distanza tra Lib-dem e Labour, in particolare sul programma economico. Così, molte delle aree del Centro-Nord e delle Midlands, il c.d. Red Wall, storicamente legata al Labour ma in via di disaffiliazione da qualche anno, hanno fatto vincere i Tories sentendosi rassicurate dalla promessa di compiere finalmente la Brexit e tornare a “decidere sulla propria vita”. Sono le aree più colpite dalla deindustrializzazione, dalla crisi del 2008 e dall’austerità. Però, che il loro declino derivi dalla partecipazione alla UE è una tesi discutibile, dato che, tra l’altro, molte di queste aree hanno ricevuto ingenti fondi europei e il loro impoverimento, peggiorato dall’austerità inaugurata dopo la crisi, ha origini antiche. Secondo Bob Jessop (2018), la perdita di questi fondi non sarà compensata da nessun “Brexit dividend”. Anzi la dipendenza dal mercato europeo per le esportazioni e per le forniture promette di rendere la situazione ancora più difficile. Inoltre, le aree più povere risentiranno maggiormente del rincaro dei prezzi dovuto alle nuove tariffe sui beni provenienti dalla UE e per il costo di gas e benzina che la svalutazione renderà più care. Certo la concorrenza con le imprese europee potrebbe aver danneggiato queste aree. Ma la UE, come scrive Balibar (2016), incarna tanto un’istituzione della globalizzazione neoliberale quanto – se ridefinita da un nuovo processo costituente – un potenziale elemento di trasformazione e regolazione della stessa. Pensare che sia più facile avere salari, servizi pubblici e diritti dentro il Regno Unito e fuori dalla UE è una illusione non giustificata e egemonizzata dall’estrema destra. Tanto lo stato inglese quanto la UE possono essere considerate forme istituzionali che perpetuano l’ordine delle cose. Ma ciò che dovrebbe guidare una politica progressista è l’ampiezza dello spazio politico all’interno della quale combatte, la possibilità di costruire coalizioni con altri movimenti. Solo un organismo democratico postnazionae potrebbe infatti affrontare la volatilità dei capitali globali e la catastrofe climatica.
Per quanto il Labour sia effettivamente stato meno votato rispetto ai Tories tra i meno abbienti, la tesi di una irrimediabile consegna della classe operaia alla reazione è fortemente mistificata
Al contrario, come spesso accade, il nazionalismo di sinistra e la necessità di riconnettersi ad una idealizzata classe operaia bianca riemergono come ipotesi politiche. Mentre Long Bailey parla di patriottismo progressista – che pur si batterebbe per i diritti dei migranti-, uno dei candidati, David Lammy – già ministro sotto Blair e Brown e dai genitori della Guyana – propone un nazionalismo civico, basato sulla condivisione dei valori, contro quello etnico della destra. Un’altra candidata, Lisa Nandy, invece rappresenta il Blue Labour, il movimento politico-culturale che sostiene posizioni conservatrici su migrazione e diritti civili, facendosi interprete del vero spirito della classe operaia inglese. Bisognerà vedere se questa ripresa del nazionalismo/patriottismo a sinistra non sia il preludio di una politica più reazionaria su immigrazione e sicurezza, temi sui quali neanche il Labour di Corbyn ha brillato per radicalità. Ad ogni modo, per quanto il Labour sia effettivamente stato meno votato rispetto ai Tories tra i meno abbienti, la tesi di una irrimediabile consegna della classe operaia alla reazione è fortemente mistificata. Anzitutto perché essa non è esclusivamente bianca, in secondo luogo perché incrociando classe e età si nota, come già detto, che il voto giovanile proletario è ampiamente per il Labour – mentre al crescere dell’età, in particolare sopra i 40, il voto va prevalentemente ai conservatori- e infine perché neanche la classe operaia bianca è irrimediabilmente contraria all’immigrazione, come mostra il British Social Attitudes Report 34 (2017).
Assieme alla società inglese, l’esperienza di Corbyn – vittima anche dell’ambiguità verso queste questioni – tramonta. Il Regno Unito lascerà così la UE per poter deregolamentare, esercitando la propria “sovranità”, la sua economia e disciplinare maggiormente la forza lavoro, migrante e non.
Riferimenti
Balibar, E. (2016), Crisi e fine dell’Europa?, Bollati Borighieri: Torino
Bhambra, G.K. (2017), Brexit, Trump, and ‘methodological whiteness’: on the misrecognition of race and class. British Journal of Sociology, 68 (S1). pp. 214-232.
Bourne, R. (2016) Hayek would have been a Brexiteer, Institute of Economic Affairs, https://iea.org.uk/blog/hayek-would-have-been-a-brexiteer
Clery, E., Curtice, J., Harding, R. (2017), British Social Attitudes 34, NatCen Social Research: London, https://www.bsa.natcen.ac.uk/media/39196/bsa34_full-report_fin.pdf
Hall, S. (1985), Authoritarian Populism: a reply, New Left Review, n.151, May June 1985
Hall, S. (2017), Selected Political Writings. The Great Moving Right Show and Other Essays, Lawrence and Wishart Limited: Londra
Jessop, B. (2018), Neoliberalization, uneven development, and Brexit: further reflections on the organic crisis of the British state and society, European Planning Studies, 26:9, 1728-1746
Nabarro, B. e Schulz, N. (2018), Recent trends to the UK economy in The IFS Green Budget C., Institute for Fiscal Studies: Londra,8 Ottobre 2019,https://www.ifs.org.uk/publications/14420
Shilliam, R. (2018), Race and the Undeserving Poor. From Abolition to Brexit, Agenda Publishing: Tyne and Wean
The Economist (2019), Special Report on Migration, 16 Novembre 2019
Townsand, L. (2019), Boris Johnson Will Be a Disaster for Working People, Tribune magazine https://tribunemag.co.uk/2019/07/the-real-boris-johnsonFacebookTwitterWhatsAppMastodonTelegramPinterestEmailShare
Questo articolo è stato pubblicato su gli asini rivista il 10 gennaio 2020.