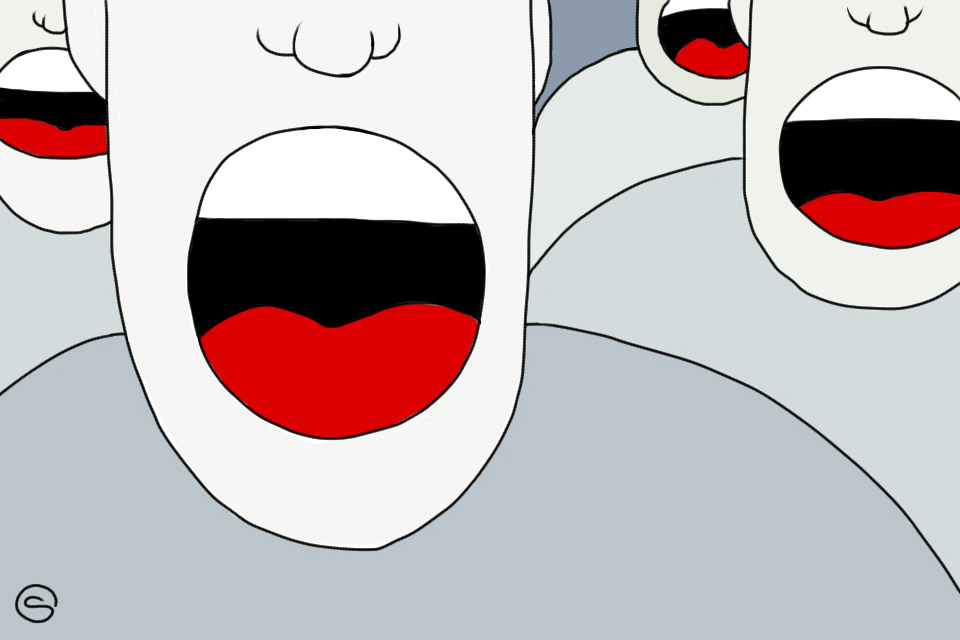di FANT PRECARIO.
1. C’era grande attesa a Genova per la tournee dei The Vaticans.
Il concerto si è tenuto al teatro ILVA. Pubblico scatenato: tra i fans più accesi ricordiamo il club delle “cervettines” in Carven vintage. Il gruppo, evidentemente in giornata di “grazia” si è rivelato all’altezza delle aspettative. Grande sezione di fiati con Marcinkus, Sindona e Gelli, ottime le percussioni di Tarcisio. Molti successi: The white flower, We want God e He was a friend of mine, e vari pezzi dall’ultimo Lp Si lavora si fatica….
Il pubblico è esploso quando il frontman White Peronist ha attaccato “Di quel lavoro l’orrendo (La) Pira”, dove il falsetto un po’ alla Brian Molko duettava con le slide del duo hawaiano Popi & lusco.
Una sola nota stonata: il gruppo di spalla, The Piddyan Assessors, è stato fermato dai cani antidroga; nei loro zaini è stato rinvenuto oppio (dei popoli).
2. «Roggi – La Pira aveva l’idea del consumo ozioso, vale a dire il disoccupato era un consumatore ozioso, che non lavorava. La Pira aveva un concetto del lavoro di tipo metafisico, teologico, nel senso che pensava che il lavoro fosse il modo in cui la creatura collabora al piano creativo del Signore: per questo la disoccupazione, il non lavorare, era un assurdo dal punto di vista teologico.
Zamagni – La Pira aveva un obiettivo: dare lavoro alla gente. Non dare lavoro ai disoccupati perché questi avessero un potere d’acquisto con cui sfamarsi: bisognava invece dare il lavoro perché il lavoro è fondativo della persona, è ciò che consente all’essere umano di essere se stesso. Ecco perché interessa a La Pira fare la battaglia per la piena occupazione, che lui chiama pieno impiego. La Pira, che economista non è, si pone il problema che non è avanzata, quanto meno civile quella società che non garantisce a tutti i suoi cittadini un lavoro, perché è attraverso il lavoro che l’essere umano conosce se stesso e conoscendo se stesso realizza se stesso» (presentazione del libro di Piero Roggi I cattolici e la piena occupazione, Meeting dell’amicizia, 25 agosto 1998).
Tralasciando il disappunto del sindacalista cattolico per il consumo ozioso, laddove sia il consumo che l’ozio sono peccato e per la pretesa “assurdità” del “non lavorare”, mi pare che quanto detto da Frank sia assai terrificante.
Se questo, detto in un sistema fordista laddove il lavoro di fabbrica era “il lavoro” e la piena occupazione unico modo di dare sussistenza al proletariato (perché i salari erano, e questo La Pira lo ignora, da fame), poteva essere anche accettato dal PCI (accomunato nell’etica lavoristica dove Stakhanov e San Giuseppe si danno la mano), il progetto, oggi – se cristallizzato nella determinazione e attualizzato nella situazione – diventa il massimo della reazione in quanto:
(i) impone (vorrebbe imporre) un progetto di lavoro subordinato in un sistema regolato dallo statuto dell’impresa (che non viene minimamente scalfito, anzi trova rinnovato vigore nel riconoscimento dell’utilità – nel senso di Taviani e Fanfani – dell’attività di impresa) forse mediato dalla figura dell’imprenditore “buono”, che resta da un lato mera prospettiva ottimistica, dall’altro ne pone la necessità;
(ii) assume ogni lavoro quale “dono divino” così legittimando anche la prestazione più umiliante (che forse è anche la più vicina al Dio degli ultimi, tanto caro a Franco);
(iii) ignora la potenza del lavoro comune, l’immediata produttività della vita, che proprio in quanto “regalata” al capitale deve essere riconosciuta in sé degna di riconoscimento (appunto il reddito minimo – e poi, perché minimo?). La vera divinità del lavoro, che conduce alla liberazione da esso, è quindi rigettata.
3. Dice qualcuno: «la pop art documenta in maniera precisa la cultura popolare americana trasformando in icone le immagini più note o simboliche tra quelle proposte dai mass-media. L’apparente indifferenza per le qualità formali dei soggetti proposti (che non è solo nella grafica ma nello stesso soggetto che non trova soggettivazione perché nato di legno), così come il procedimento di pescare tra oggetti che apparivano triviali e non estetici (e non è desiderio recuperatorio ma giustificazione dell’orrido esistente, evasione meschina dal recinto della produzione per annegare nell’esperimento ridistribuivo) ha indotto molti critici a considerare la pop art come una specie di nuovo dadaismo».
Se queste non sono cazzate, allora il populismo (senza scomodare il primo Plekhanov e il suadente Cernyesevskij) non esiste che se non come giustificazione della nostra impotenza.
Il POPulismo l’abbiamo sempre sperimentato sulla nostra pelle da quando il prete ci diceva che “le fosse ardeatine sono colpa dei partigiani“, il giornalista si doleva del fatto che “a Pomigliano non si lavora“, Arrigo Polillo rinfacciava a Coltrane di essere poco noto [una perla di molti anni dopo del primo campeggia tra la più vivida paccottiglia del III millennio: «suonò bene o suonò male, Coltrane, quel giorno? A me (e a molti altri) parve che i suoi assolo fossero alquanto sgangherati, e lo scrissi. Mal me ne incolse poi, perché quel giudizio negativo sulla prestazione di un musicista che sarebbe divenuto celeberrimo mi sarebbe stato rinfacciato per anni, anche nel corso di dibattiti pubblici. E il bello è che praticamente nessuno fra coloro che assicurano che si doveva capire subito di trovarsi di fronte a del grande jazz era presente quel giorno in teatro. Del resto, che qualcosa non funzionasse per davvero si può desumere anche dai fischi sonori che il sassofonista (ancora scarsamente famoso, e comunque agli inizi della sua seconda, straordinaria carriera) aveva raccolto a Parigi la settimana prima)».
Tutto, probabilmente, procede dal Vangelo (la mia casa sarà chiamata casa di preghiera ma voi ne fate una spelonca di ladri, un po’ come le ONG che portano per lucro i negri in Italia lordandone il sacro suolo) e da Menennio Agrippa.
POPulismo quindi, tal quale lo stalinismo, «è qualcosa che nasce dalle budella della storia, dell’accumulazione originaria […], è una cosa universale e infame quanto lo è il fascismo in Italia. […] Il gruppo dirigente però interpretava la moltitudine come cattiva e perversa: non volevano lavorare, volevano spendere, volevano solo burro», biforcazione dei sensi che porta tanto a certa musica tradizionale tesa a riscoprire chissà quali piaceri nel morire di pellagra quanto all’ebete Paul Simon che tende il braccino verso il pubblico accompagnato da ritmi di Soweto.
4. Il POPulismo nasce nel 1942 ad opera di Augusto Genina, che per il suo Bengasi vinse la coppa Mussolini (mica cazzi) al Festival di Venezia come miglior film italiano, coppa Volpi a Fosco Giacchetti, passato dai Fari nella nebbia alla sabbia del deserto. Per la cronaca, miglior film straniero fu Il grande re, commissionato direttamente dal quel Roy Lichtenstein ante litteram che fu Goebbels (e non lo dico io ma Luigi Mascheroni su “il Giornale”: «e, infine, c’è il manifesto del plebiscito per le elezioni della Camera dei fasci del 1934: un collage di Mussolini e il popolo italiano che sembra anticipare la pop art di Roy Lichtenstein». Sembra di sentire la voce di Gustave Le Bon: «Una credenza religiosa o politica si fonda sulla fede, ma senza i riti e i simboli la fede non può durare» – ma per questo ci sarà tempo dopo, per ora ritorniamo alla Libia littoria.
C’è una scena del film nella quale un anziano abile imprenditore agricolo figlio dell’impero è raggiunto nella propria adorabile magione, dove con le schiene spezzate delle faccette nere si coltivano fiori e frutti. Il vecchio è rallegrato da un cinguettante animaletto (non si poteva dire “uccello” nell’età della sobria anarchia). Sopraggiungono gli inglesi e spaccano – nell’atterrito stupore dell’agricoltore non sufficientemente tutelato dall’elmo di Scipio o dagli otto milioni di baionette – tutto: fiori, frutti e animaletto.
La pena, il cordoglio per quell’uomo esplodono nel cuore invitto dei 1000 militi presenti al festival, ma anche in noi colmi d’amarezza per la superbia del perfido cittadino d’Albione, misconoscitore di una cultura millenaria che aveva illuminato e illuminava il mondo grazie a Marconi e Meucci (altra vittima del turbocapitalismo USA).
Al di là del languore di penitenza, la scena appare intrisa di un potere immaginifico e destituente:
(i) il vecchio (canuto e bianco, anche se Petrarca si ubriacava di transalpino Châteauneuf-du-Pape, mica di Bonarda) non è più squallido depredatore di un popolo assoggettato da 30 anni ad un’occupazione violenta e tragica;
(ii) la casa smette ogni funzione abitativa, ma spinge verso la riservata sacralità della proprietà, violata come vergine dai soldati negri (e mica sarà un caso) che avanzano verso il nord;
(iii) i frutti, non furto e sfruttamento ma dono del signore che è prima di tutto “nostro” – e infatti si prega “padre nostro” mica “padre di tutti, anche dei negri”;
(iv) l’uccellino che riversava melodie all’indirizzo delle orecchie del vecchio, è usignolo romano, che nel tripudio di libertà fascista (esiste ancor oggi un partito che si chiama “Fascismo e Libertà”) neppure abbisognava di quella gabbia che inglesi, capitalismo globalizzato e negri (non dimentichiamo che Bob Marley era per il Negus, quindi, ancora più droga, più violenza, e oggettivamente musica di merda) utilizzano per vincere il ritorno della potenza imperiale.
5. Ripresi dall’incommensurabile censura che dal mondo civile si leva verso l’orrido capitale giudoplutomassonico (attuale piaga comunisteggiante dotata grazie ai denari di Soros, di un clan di menestrelli che va da Demna Gsvalia a Euronomade), incurante di tradizioni, affetti e “comunità sacre”, prima di proceder nell’analisi utilizziamo quale unguento lenitivo la dolce melassa di Nilla:
Dio del Ciel se fossi una colomba
Vorrei volar laggiù dov’è il mio amor,
Che inginocchiato a San Giusto
Prega con l’animo mesto:
Fa che il mio amore torni
Ma torni presto
Vola, colomba bianca, vola
Diglielo tu
Che tornerò
Dille che non sarà più sola
E che mai più
La lascerò
Fummo felici uniti e ci han divisi
Ci sorrideva il sole, il cielo, il mar
Noi lasciavamo il cantiere
Lieti del nostro lavoro
E il campanon din don
Ci faceva il coro
Vola, colomba bianca, vola
Diglielo tu
Che tornerò
Tutte le sere m’addormento triste
E nei miei sogni piango e invoco te
Anche il mi vecio te sogna
Pensa alle pene sofferte
Piange e nasconde il viso tra le coperte
Come diceva Peppino a Totò: e ho detto tutto. C’è di che far felice Berlinguer, Rauti, Guttuso, Merola (tanto il sindaco che il cantante), i sovranisti, il peronista in bianco, Moccia, Shel Shapiro, Marchionne, Cremaschi, i nemici di Marchisio, Orban, Ginettaccio, Clint Eastwood, Saviano, Di Canio & so on…
 Fummo felici uniti e ci han divisi: i comunisti, evidentemente. Orda di sguaiati partigiani che di libero amore facevan professione, che ti immagini orge a base di slivovitz in chiese rubate al culto e aduse all’abuso, depredate di icone (magari vendute anche quelle a Soros), lascive bolsceviche, colme di gioielli (perché fra Slavi e Zingari non fa differenza) vestite di lamé in mano a potenti eunuchi (perché il comunista o è violentatore o è checca, lo si sa) che ebbri alzano lodi a Sylvano Bussotti. In fondo Stalin aveva una mentalità asiatica, lenta e tortuosa (e ce lo dice nientepopodimeno che Antonio Giangrande). Già la prosa è eloquente di distacco, rottura d’amori, affetti ma anche del focolare, laddove la famiglia è società naturale fondata sul matrimonio (così presagendo la mirabile opera dei costituenti). Nell’immagine spicca la “falce” assurdo simbolo comunista, divisiva eviratrice di connubi indissolubili (Il “vero amore” / Per sempre uniti dal cielo / nessuno in terra, anche se vuole / può separarlo mai… l’ha detto lui!).
Fummo felici uniti e ci han divisi: i comunisti, evidentemente. Orda di sguaiati partigiani che di libero amore facevan professione, che ti immagini orge a base di slivovitz in chiese rubate al culto e aduse all’abuso, depredate di icone (magari vendute anche quelle a Soros), lascive bolsceviche, colme di gioielli (perché fra Slavi e Zingari non fa differenza) vestite di lamé in mano a potenti eunuchi (perché il comunista o è violentatore o è checca, lo si sa) che ebbri alzano lodi a Sylvano Bussotti. In fondo Stalin aveva una mentalità asiatica, lenta e tortuosa (e ce lo dice nientepopodimeno che Antonio Giangrande). Già la prosa è eloquente di distacco, rottura d’amori, affetti ma anche del focolare, laddove la famiglia è società naturale fondata sul matrimonio (così presagendo la mirabile opera dei costituenti). Nell’immagine spicca la “falce” assurdo simbolo comunista, divisiva eviratrice di connubi indissolubili (Il “vero amore” / Per sempre uniti dal cielo / nessuno in terra, anche se vuole / può separarlo mai… l’ha detto lui!).
Ecco risolto il primo dilemma: se quella era la coppia più bella del mondo, l’accozzaglia comunista è la cosa più brutta indegna. Si ribalta la verità, donando bellezza a Olindo e Rosa eretti a simbolo di comunità e suor Pagliuca a mamma modello.
Ci sorrideva il sole, il cielo, il mar: poche pretese quindi, ‘o sole, ‘o ‘mmare, una casettina in periferia, una mogliettina / giovane e carina, tale e quale come te. La parsimonia italica, la voglia di ritorno alla lira, il disprezzo dell’insolvenza. Perché la famiglia è focolare, unione di spiriti che anche con lo scorbuto sono felici “in sé”, mica come quei coglioni di statunitensi cresciuti ad hamburger e birra.
Noi lasciavamo il cantiere / Lieti del nostro lavoro: ce lo aveva cantato Gilberto Mazzi, un modesto impiego, io non ho pretese / voglio lavorare per poter alfin trovar tutta la tranquillità! Perché come ci insegna Camusso la sola dignità è nel lavoro. E Papa Frankie lo ha ripetuto a Genova: non reddito per tutti ma lavoro per tutti! E ha proseguito: A volte si pensa che un lavoratore lavora bene solo perché è pagato, questa è una grave disistima del lavoro e del lavoratore perché nega la dignità del lavoro che inizia proprio nel lavorare bene per dignità, per onore (anche Warhol si vestiva di bianco…).
Ricordiamoci di questa fotina di Marilyn che ci dona il Sommo (non il Chiovenda): lavorare per soldi è segno di disistima di sé. Tirare le cinghie è invece segno di bontà divina assunta nel corpo schifoso di un sindacato puzzone che applaudiva [ndr, nota mia]. E poi, “lavorare bene per dignità”? e di che? di chi? È dignitoso passare trent’anni in un alto forno a sputare sangue sempre più denso per la polvere che si è ammassata nei polmoni. E come si fa a lavorare bene se è un lavoro di merda, che ti spruzza eau de inedia per otto ore, in un ambiente ostile e malsano, circondato da capetti orridi che paiono imitazioni mal riuscite di Baricco?
E il campanon din don/ci faceva il coro: eccheccazzo, ciondolanti dei centri sociali, dopo otto ore di lavoro ai cantieri di Monfalcone, cosa c’è di meglio nell’essere cullati dallo scampanare di un allievo di mons. Tiso? Che poi le campane sono anche quelle “tubolari” di Mike Olfield, estremo tentativo di risollevare il rock morente ante-punk con una miscela oleosa che il Castrol TT era acqua sorgiva. Campana, campanile, gruppetti di vecchie megere e kulaki assiepati per rovistare nelle vite dei devianti, anticamera della commissione McCarthy o dell’OVRA. Trionfo dell’ignoranza elevata a sistema di produzione, dove la merce, riprodotta da mani abili e cervelli corrosi, disvela la propria natura di germe nazistoide.
5. Il POPulismo è il “tan tatan tatan tatan” della pubblicità del Mulino Bianco che evoca Cayenne che risale la strada bianca toscana verso la villa solare della moglie tanto casta quanto maliarda, è ricordare soltanto i preti vittima del fascismo e non i partigiani (come faceva Veltroni), ricordare i “ragazzi di Salò”, perché poi sennò si passa al “so’ regazzi” e “quelli del Circeo” diventa un telefilm tipo “i ragazzi del muretto”.
Il POPulismo sono i telefilm sui carabinieri e sui parroci ma anche sulle vite sventurate delle ragazze belle ricche e dannate, che si drogano perché uno ha postato la foto delle loro gengive sul Facebook, le litanie sul Bio che parti per mangiare sano e bevi merda ma la paghi 100 euro.
Il POPulismo è Kayne, Paperoga, il Commissario Derrick, Franco Battiato e la sua verbosa supponenza che ci ricorda ogni giorno che l’organo in chiesa lo suona solo lui (e chissenefotte, tanto in chiesa non ci vado), Fabiofazio l’edificatore dell’inutilità in una sola trasmissione, che ti dimostra di essere intervistatore inflessibile chiedendo a Renzi se è meglio la manica della camicia “su o giù” (minchia fateci caso, torniamo sempre a Peron, che era amicissimo di Licio Gelli), i film francesi dove le case sono sempre con la boiserie e minimo sono di 300 metri quadrati, il taglio di capelli di Ferruccio De Bortoli, la mano flaccida di Calabresi, Ferrero e il commissariamento della Sampdoria.
6. Per concludere: il POPulismo ha tanti amici, tanti padroni e come rivoli torrentizi si fonde un un grande fiume in piena per travolgere un solo unico nemico – il comunismo.
E fa bene, perché solo il comunismo costituisce antidoto definitivo contro la famiglia gabbia di padri violenti, madri possessive e figlio coglioni, la religione (per cui ogni libertà si fa peccato), lo stato inventore di norme infami e repressive ma anche allevatore di assassini e disadattati, la musica di merda che ci imprigiona in finti ritmi e melodie puzzolenti, che tracimano rinuncia ad esistere, i libri del cazzo… contro la vita che a tutt’oggi ci appartiene e vince.
Per essere ancora più chiari: se si dovesse dare un nome al POPulismo, quello dovrebbe essere il pelato degli interni: l’ideatore del SOCIALISMO DECOROSO, riciclo perduto della perduta socialdemocrazia, grande conoscitore di stilemi, novello Cary Grant del Daspo, Lord Brummell non pentito, inventore del dandismo poliziesco, eroe dei quartieri degradati che in lui vedono un nuovo supereroe nato dalla fantasia di Mr Dixan, mezzo Mastro Lindo, mezzo Visinski. Magari confonde un po’ la Res Publica con il bidè (tanto utilizza il Lysoform per scrivere i suoi provvedimenti), ma tant’è…
Franco è morto, Ante Pavelic è morto pure lui, e anche gli amici di Cossiga non sembrano passarsela tanto bene.