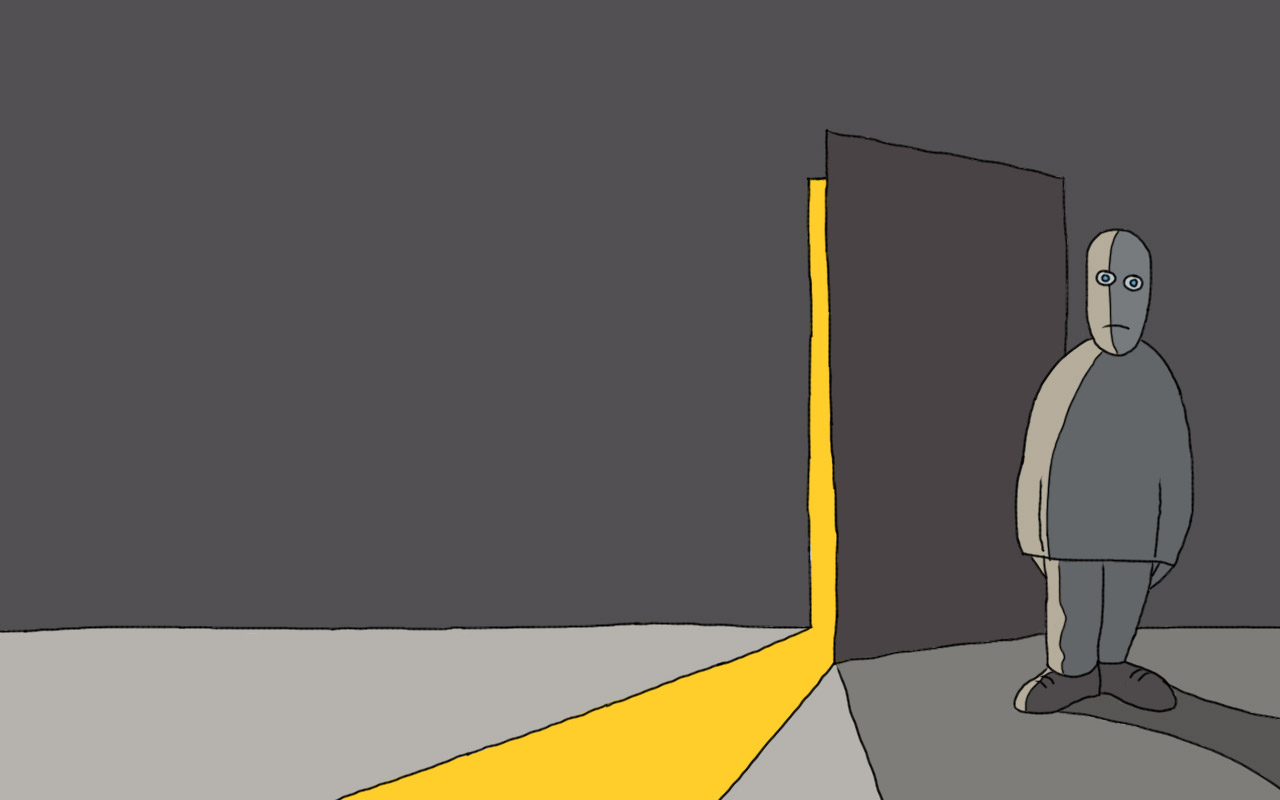Di ANNA GUERINI
L’obiettivo di questo intervento non è proporre chiavi di lettura definitive e dogmatiche, ma sollevare alcuni problemi, a partire, però, da alcuni punti che credo debbano essere tenuti saldi, anche perché permettono di ridefinire i problemi stessi. Partirò con alcune premesse teoriche, relative al femminismo, poi entro nel vivo della tematizzazione della prospettiva femminista rispetto alla guerra, in particolare rispetto alla Palestina, e poi chiudo con alcune considerazioni e problemi rispetto al lavoro di ricerca e a quello che possiamo definire “privilegio epistemico”.
Femminismo e valorizzazione
Si dice che ci siano molti femminismi. Per me femminismo è decostruzione e sovversione della riproduzione sociale del capitale, a partire da una critica basata su elementi precisi. È una politica di posizionamento, una politica di classe, dove “classe” è il nome di un soggetto che si dà nell’antagonismo, anche nei confronti della politica dei blocchi che il regime di guerra impone. Credo che sia particolarmente importante affermarlo oggi, soprattutto se si chiarisce quali siano i blocchi, che non sono solo geopolitici, ma anche concettuali. Femminismo è una politica di sovversione della riproduzione sociale perché è qualcosa di più di una politica delle identità.
Non intendo sostenere che identificare le soggettività subalterne e riconoscerle, o riconoscersi, come tali non sia determinante; tuttavia, se queste identità non articolano una politica di sovversione, il loro riconoscimento rischia di tradursi in nuovi processi in riduzione ad uno, o a molti uno, e di produrre o ulteriore subordinazione, o una riorganizzazione della subordinazione. La politica di classe assume come obiettivi polemici i nessi che collegano strutturalmente e funzionalmente quelle condizioni subalterne.
Nello specifico, il femminismo che convoco è quello che ha prodotto e continua a produrre una critica complessiva dell’ordine sociale, che non si limita alla determinante e sempre più necessaria denuncia della violenza sulle donne e di genere nelle sue varie forme, ma analizza la funzione costitutiva di quella violenza, tanto rispetto alla nazione e alla retorica dei nazionalismi, e quindi anche dei colonialismi, quanto rispetto alla subordinazione e gerarchizzazione su cui si fonda la riproduzione del capitale.
Affronto brevemente questo secondo tema, per poi tornare alla nazione. I movimenti veneti degli anni Settanta hanno prodotto un avanzamento di analisi e di discorso irrinunciabile proprio rispetto alla riflessione sulla riproduzione sociale. Mi riferisco alla critica femminista dell’economia politica elaborata, a partire da Marx, da Maria Rosa Dalla Costa, Alisa Del Re, Selma James, Silvia Federici e molte altre, all’interno del movimento internazionale per il salario contro il lavoro domestico[1]. Possiamo parlare di “un internazionalismo femminista”, con la definizione proposta da Veronica Gago, che la riflette sull’orizzonte aperto da Ni Una Menos[2].
Non mi soffermo sulla polemica di quel movimento con Marx; mi limito a rilevare gli elementi principali di analisi critica che ha sviluppato. Posto che, per autovalorizzarsi, il capitale sfrutta una forza lavoro che si deve riprodurre, il regime del lavoro salariato si fonda sulla divisione sessuale del lavoro sociale, che attribuisce alle donne un doppio carico di lavoro, quello di cura, e quello salariato. Con una precisazione: negli ultimi decenni, è aumentato significativamente il numero di donne bianche nel mercato del lavoro salariato – con tutte le differenze che pure rimangono rispetto alla forza lavoro maschile in termini di retribuzione, precariato, rischio di licenziamento, demansionamento ecc.
Questo fenomeno va di pari passo con l’attribuzione di buona parte del lavoro riproduttivo alle donne – ma anche agli uomini – migranti, in condizioni di sfruttamento note (ricatto per i permessi di soggiorno, lavoro nero e grigio, caporalato), accentuate dalla recente estensione del circuito delle piattaforme al mercato del lavoro di cura. Esiste, quindi, un differenziale di sfruttamento, contro cui, però, non si rivendica il diritto ad essere sfruttate quanto gli uomini, o di sfruttare quanto gli uomini, ma il rovesciamento delle condizioni di sfruttamento.
Questa critica femminista dell’economia politica non sia limita ad aggiungere un problema a quello, considerato principale, del lavoro salariato, ma mette in luce l’esistenza di un altro “segreto laboratorio”, non solo della produzione ma della riproduzione del capitale, che ha come simbolo e luogo le case, ma che viaggia sulle catene globali della cura. L’analisi dei modi di funzionamento del dominio patriarcale e razzista è imprescindibile per identificare, analizzare e combattere questo differenziale di sfruttamento, rispetto al quale gli strumenti della contestazione dello sfruttamento lavorativo si rivelano necessari ma non sufficienti.
È ora possibile tornare alla politica delle identità: razzismo e patriarcato possono essere due fattori alternativi o sovrapposti di identificazione di soggetti vulnerabili e maggiormente sfruttabili, e lo sono. Ma limitarsi a questo, e orientare prospettiva politica nell’ottica del risarcimento, ad esempio in termini giuridici, per quanto importante e utile, significa arrestarsi sulla linea della politica delle identità – almeno finche non saremo in grado di elaborare una politica del diritto radicalmente altra, che rimane da pensare.
È bene tenere un occhio all’immediato e l’altro all’infinito, e quindi interrogare complessivamente le trasformazioni in cui siamo immerse. L’accumulazione di capitale proietta globalmente la sua capacità di sussumere e organizzare modi di produzione molto differenti entro una serie di “operazioni”[3]: estrattivismo, di minerali e di dati; logistica, di merci, di persone, di idee; produzione industriale “semplice”, che non è sparita, e finanziarizzazione. Sono operazioni che, riorganizzando flussi, consentono al capitale di rispondere alla sua crisi. L’effetto, che osserviamo almeno da un paio di decenni, è una ridefinizione non solo della funzione degli Stati, ma anche di quella degli imperi e delle organizzazioni internazionali variamente intese.
Dentro questo quadro, mi pare rilevante capire in che modo patriarcato e razzismo agiscano congiuntamente nell’organizzare questi flussi di merci, dati, persone; in che modo definiscano le gerarchie che legano persone e merci con l’obiettivo di estrarre valore; e, soprattutto, che funzione avranno nella riorganizzazione di questi flussi nella fase di “ricostruzione” post-bellica, quando si saranno chiusi, si spera il prima possibile, almeno due fronti di guerra (Ucraina e Palestina), e che funzione hanno avuto e hanno ora nel determinare i fronti stessi.
Non per puro interesse analitico, ma perché sono i movimenti forse più rilevanti degli ultimi anni a indicarci gli snodi nevralgici di una lotta che può andare nella direzione della sovversione: le donne in Iran e il confederalismo in Rojava. Sono due esempi che non cito a caso, così come non ho citato a caso Maria Rosa Dalla Costa e Alisa Del Re, che con molti colleghi e compagni hanno praticato un modo di stare in università e di concepire la ricerca che va in una direzione opposta a quella che è ormai eletta a canone.
Per riassumere: la donna migrante non è più rilevante politicamente della donna bianca o dell’uomo migrante “solo” perché tre volte marginalizzata, ma perché occupa una posizione specifica all’interno della struttura della riproduzione sociale, perché incarna un punto di vista a partire dal quale ne rende visibile l’articolazione complessiva. È la posizione del margine, con bell hooks, che ci permette di seguire e ricostruire le catene del valore[4]. Assumere quello sguardo, quella prospettiva, è la sfida, critica e politica, per evitare le insidie di una politica dell’identità e della loro somma, e articolare un nuovo internazionalismo[5].
Riappropriarsi della rivoluzione
Sotto questo aspetto, ci vengono in aiuto tre documenti che non possiamo ignorare: il comunicato delle donne iraniane del movimento Jina di alcuni mesi fa[6], l’intervista all’attivista del Comitato Nesvan[7],– e il comunicato dell’Unione delle Comunità del Kurdistan[8]. Parto da quest’ultimo, che è stato preceduto nel 2023 da un opuscolo dal titolo Opportunità e pericoli della terza guerra mondiale[9], nel quale, di fronte alla Guerra in Ucraina, si ribadiva la necessità di guardare ai conflitti intrasistemici nelle potenze statali e a quelli che riorganizzano i flussi transnazionali del valore, a partire dai movimenti che ne decostruiscono la logica. Tra questi, il femminismo, che, con le parole di Abdullah Öcalan, è ribellione contro la più antica forma di colonizzazione – motivo per cui non c’è liberazione senza liberazione delle donne[10].
Il comunicato delle Comunità curde è del 17 ottobre 2023, condanna ovviamente l’aggressione del popolo palestinese, ma prende anche le distanze dall’attacco del 7 ottobre. Non si può certo accusare il movimento curdo di occidentalismo o di simpatie coloniali, o rimproverargli un rifiuto della rivoluzione armata, visto che la fa quotidianamente sotto le bombe di Edrogan. Il quale accoglie i leader di Hamas e, parallelamente, è finanziato dall’Unione Europea per tenere fuori dai confini i migranti siriani e afgani. La critica curda non si limita all’attestazione di un problema geopolitico, ma ci interroga politicamente in forza della sua chiarezza: «la mentalità statalista è la radice dei problemi della società e dell’umanità», perché non ha fatto altro che «aumentare i conflitti, soprattutto in Medio Oriente in seguito all’instaurazione dello Stato-nazione sviluppato dalla modernità capitalista».
Il movimento rivoluzionario pone, con toni che forse possono urtare, il problema della prospettiva futura, chiedendosi quali siano gli equilibri in gioco, non solo dal punto di vista geopolitico, ma nell’ottica di una democratizzazione rivoluzionaria del medio-oriente, che è stata a lungo al centro della prospettiva palestinese, per poi indebolirsi dopo gli accordi di Oslo[11].
La conferma viene dal primo testo delle donne iraniane, la cui lotta muove dall’omicidio di Masha Hamini, donna curda, e assume come proprie le parole d’ordine della rivoluzione curda: «nell’ultimo anno, siamo state in grado di riappropriarci della “rivoluzione” allontanandola dal discorso “rivoluzionario” corrotto e patriarcale della Repubblica islamica. Abbiamo reclamato la “rivoluzione”, l’abbiamo incarnata nella profondità delle nostre voci collettive e l’abbiamo ridefinita attraverso i nostri valori e desideri femministi».
Decifrare la rivoluzione significa, di fronte alla lotta palestinese «riconoscere la lotta per la liberazione della Palestina come parte del discorso femminista e anticoloniale», ma anche «non […] allinearsi alle narrazioni costruite dalla Repubblica Islamica, perché la lotta palestinese per la libertà non inizia né è definita dalla Repubblica islamica». L’obiettivo è «liberarci dalle catene della Repubblica islamica e dalle forze nazionaliste e di estrema destra», per tracciare «un percorso verso una vera solidarietà femminista transnazionale con le nostre care compagne in Palestina».
Anche in questo caso, e l’abbiamo visto negli ultimi mesi, vale una considerazione geopolitica: l’Iran ha un peso fondamentale negli equilibri tra Israele e Palestina, e il fatto che la morte di Raisi sia stata salutata come la morte di un martire dai leader di Hamas è indicativo. Anche qui, bisogna andare oltre la geopolitica.
Le donne iraniane sottolineano la necessità di vigilare sull’uso delle parole, e di risignificare i concetti che veicolano: una vigilanza che, nel caso di “rivoluzione”, ma vale anche per “resistenza”, richiede uno sforzo specifico e duplice, che passa per la concreta opposizione alle forme di dominio che cercano di appropriarsene, magari riscrivendo la storia delle lotte.
Per questo la critica all’ “asse della resistenza” è al centro dell’intervista a un’attivista del Comitato Rivoluzionario Nesvan, gruppo marxista di donne iraniane, che, nell’esprimere un fermo supporto al popolo palestinese e alla sua lotta di liberazione, sottolinea la difficoltà – ma anche la necessità – di assumere un posizionamento critico rispetto a «tutti i governi corrotti», quelli che fanno parte dell’ “asse della resistenza”, «che si oppongono ai movimenti di liberazione e ai movimenti di base nel loro contesto», che fanno parte di quell’asse, che si richiamano alla legge della terra e del sangue, e che non hanno a cuore i popoli, ma i territori e le loro risorse.
Quello che emerge da questi testi – e vale lo stesso per quello delle donne russe contro la guerra in Ucraina –, è che i concetti di “popolo”, “stato” e “nazione” producono e mettono gerarchicamente a valore le differenze. Questo non significa liquidare in toto le rivendicazioni che si iscrivono nella grammatica del popolo e della nazione: le lotte anti e decoloniali hanno dato delle indicazioni in merito, che però devono essere calate nel contesto della loro formulazione, e prestando attenzione alle interpretazioni, ad esempio, di Franz Fanon come teorico del nazionalismo e apologo della violenza tout-court.
Fintanto che ci si richiama alla logica del popolo e della nazione, che procede per unificazioni rappresentative e per identificazioni – individuale o su scala maggiore –, il rischio concreto è di cancellare le stratificazioni e le resistenze interne. Non si tratta di contestare il diritto del popolo palestinese a riconoscersi in identità – un’identità sistematicamente negata da Israele –, ma di interrogare i modi e i soggetti che stanno ridefinendo questa identità, in particolare nella striscia di Gaza.
L’aspirazione e la pratica anti-statalista del movimento curdo mi pare indicativa in questo senso, perché si realizza non solo nella democrazia radicale, ma anche nella convivenza tra popoli, culture, religioni, oltre ogni confine nazionale, contro ogni nazionalismo sciovinista. In quel caso l’unica unità, mai definitiva, sempre costituente, si concretizza nel progetto rivoluzionario, nella sua capacità di fare i conti con le contraddizioni, tenendo fermi i suoi pilastri, in primis la liberazione delle donne, che non viene dopo, ma è fondamento.
La logica della guerra
Lungi dal pretendere una semplice trasposizione dai movimenti curdo e iraniano alla situazione palestinese, credo tuttavia che questi documenti e prese di posizione siano imprescindibili, nella misura in cui ci danno un’indicazione di metodo e ci aiutano a orientarci nell’identificazione dei problemi entro il regime di guerra. Il femminismo ha messo in luce in modo esemplare la genealogia e gli effetti della dicotomia tra privato e pubblico, suggerendoci di andare oltre per interrogare e pensare una riproduzione radicalmente altra di forme di vita.
Da questo punto di vista, una prospettiva femminista ci aiuta a tenere a mente che la guerra è basata su una logica di contrapposizione che obbliga allo schieramento rispetto a dimensioni statali, nazionali, utili tendenzialmente alla rideterminazione di fronti interni ed esterni, in cui a perdere sono sempre le stesse persone e a vincere sempre i processi di valorizzazione.
Il femminismo ci aiuta a rifiutare la logica di guerra, non solo perché sottolinea che le donne sono esposte a una violenza specifica e determinata in tutti i conflitti, ma perché mostra la funzione costitutiva di quella violenza, ricordandoci, ad esempio, che il simbolico femminile è un’arma di guerra. Mentre la partecipazione delle donne alle forze armate viene eletta a emblema dell’eguaglianza di genere, in Ucraina come in Israele, in Russia l’aborto è sotto attacco, con proposte di legge per vietarlo, elaborate a partire dai documenti della Chiesa ortodossa che esaltano la maternità come valore nazionale.
A Gaza, nel frattempo, stiamo assistendo ad un attacco frontale alla riproduzione, tanto che si parla di “genocidio riproduttivo”. Il colonialismo israeliano, d’altronde, è da sempre caratterizzato da una violenza specifica contro le donne palestinesi, che dipinge come oggetto di una violenza maschile solo islamica per giustificare le sue invasioni. Parallelamente, la fratellanza musulmana ha definito un modello di “donna islamica”, diventato tema di discussione tra le donne palestinesi, sulla spinta, ad esempio, della rilettura dei testi sacri[12].
Non si può negare il fatto che Hamas, mentre ricostruiva la struttura di welfare della striscia di Gaza (asili nido, ospedali) riempiendo uno spazio politico lasciato vacante da gruppi laici e socialisti[13], comprimeva le spinte laiche, i movimenti femministi, quelli studenteschi; che, mentre accoglieva la nascita del comitato femminile all’interno del Partito della salvezza, nel 2021 decideva che le donne non sposate possono viaggiare solo se accompagnate da un parente maschio, dal marito se sposate.
Violenze e legittimizzazioni epistemiche
A partire da questo quadro, credo si possano formulare alcuni problemi in forma interrogativa, compreso quello, non indifferente, della “legittimazione epistemica” e della “residualità” di chi lavora e studia in università[14]. Lo faccio ponendo due domande, che secondo me obbligano a discutere l’altro corno problematico della politica delle identità, il concetto di privilegio.
1) Avanzare una critica ad Hamas significa promuovere un ragionamento coloniale, occidentale, islamofobo? 2) In che modo si può articolare una riflessione in merito senza finire per rafforzare, paradossalmente, proprio un discorso coloniale che, dipingendo le donne palestinesi come vittime dell’Islam, rischia di tradursi in sostegno della colonizzazione israeliana?
Queste due domande nascondono due impliciti, entrambi problematici, perché rischiano di chiuderci in una prospettiva antinomica: o si considerano le donne palestinesi assumendo una prospettiva coloniale, che le vede vittime dell’Islam, oppure, all’opposto, si nega la doppia oppressione a cui le palestinesi resistono.
Per rispondere a queste domande e fare i conti con questi due impliciti, bisogna, a mio modo di vedere, interrogare la questione proprio seguendo le connessioni stabilite dai movimenti, assumerne il quadro epistemico, e tenendo conto dei flussi di valorizzazione, andando oltre la prospettiva geopolitica.
Il tutto partendo da un dato: non sto chiedendo alle donne palestinesi di agire in questa direzione, visto che hanno il problema di sopravvivere alla violenza genocida israeliana. Tuttavia – ed è questo il punto –, non si può nemmeno fare finta che non l’abbiano fatto nel passato, anche recentissimo. Penso in particolare al movimento Tal’at, che ha sviluppato una prospettiva femminista per la liberazione della Palestina, ricordando che l’aumentata violenza maschile all’interno della società palestinese ha anche una genesi coloniale. «Israele ha lavorato strategicamente per schiacciare e frammentare i palestinesi socialmente, politicamente ed economicamente.
L’eliminazione dell’azione collettiva delle comunità palestinesi va di pari passo con il rafforzamento delle strutture patriarcali delle unità di parentela»[15], che Israele usa a suo vantaggio, perché la denuncia della violenza domestica alle autorità israeliane rinforza l’idea che la violenza sia caratteristica della società palestinese[16].
Se si tiene conto di questo tipo di analisi, che sottolinea il rapporto tra dominio maschile e dominio coloniale, e riconosce l’esistenza di entrambi, senza negare l’uno e l’altro, si può, credo, avanzare un’ipotesi apparentemente paradossale e in parte provocatoria: se rimaniamo ferme a uno o all’altro implicito – se, ad esempio, mettiamo sotto il tappeto decenni di lotta femminista in Palestina[17], non rischiamo di riprodurre un’immagine orientalista delle donne palestinesi vittime?
Non possiamo dimenticare le lotte precedenti al 7 ottobre, contro la dominazione coloniale e la sua violenza, ma anche in contrapposizione con un impianto politico che ha modificato gli assetti categoriali e sociali di una popolazione tendenzialmente laica, come quella palestinese, e che, dal punto di vista delle politiche di governo, come ha ricordato Siyâvash Shahabi,agisce come una «borghesia reazionaria»[18].
Contraddizioni e privilegi. Rompere il regime di blocchi concettuali
A questo punto, credo che il problema si possa formulare in questi termini: si possono avanzare questi ragionamenti e interrogativi, e nel frattempo sostenere la liberazione del popolo palestinese? A mio modo di vedere sì: possiamo e dobbiamo chiedere il cessate il fuoco immediato a Gaza, denunciare le innumerevoli violazioni del diritto internazionale commesse da Israele negli ultimi 75 anni, mettere in discussione il paradigma sionista e sostenere il movimento di liberazione in Palestina.
Parallelamente, credo sia legittimo interrogarsi sulle prospettive future, tenendo conto della situazione politica nei territori occupati – il che significa mettere a tema il fallimento delle politiche di Fatah, dell’ANP, e di Hamas –, ma anche degli effetti che avranno le politiche di alleanze che vanno configurandosi e consolidandosi. Ricordando, parallelamente, che se la liberazione dovesse tradursi nella supremazia di un gruppo sugli altri sarebbe una liberazione per pochi, come insegna l’esempio iraniano.
Detto altrimenti, bisogna valutare quali contraddizioni si aprono, capire se sono davvero contraddizioni e decidere cosa ne facciamo. Possiamo nasconderle? Chi deve nasconderle ora sono le palestinesi e i palestinesi sotto le bombe israeliane. Cosa accade se noi, da una posizione che negli ultimi anni abbiamo definito di “privilegio”, facciamo lo stesso, magari considerando ogni popolo “arabo” (ma vale anche per il popolo israeliano) come un blocco unico, operazione epistemica tipicamente orientalista e coloniale?
Credo da questo punto di vista, si possa tenere a mente l’analisi proposta da Edward Said quasi vent’anni fa. Il 21 marzo 1996, l’intellettuale palestinese sottolineava che un dibattito risucchiato nella polarità noi/loro (che va di pari passo con civile/incivile) avrebbe finito per rafforzare i tratti nazionalisti e identitari, validando a contrario la «dichiarazione di guerra globale» formulata da Huntington con le sue tesi sullo “scontro di civiltà”[19].
Mi pare un’indicazione significativa, perché mette in luce i pericoli di una rigida politica delle identità: richiama costantemente l’importanza di una prospettiva storica di lunga durata, che ricostruisca il contesto (tema centrale anche nel dopo 7 ottobre), in quel caso della nascita di Hamas, per sgombrare il campo da letture unilaterali, incapaci di fare i conti con le responsabilità dell’occidente, ma pronte a ricondurre tutto, appunto, alla logica noi/loro. Parallelamente, e proprio in nome di questa critica, Said mette in guardia dal rovescio interno di questa prospettiva, che tende a consolidare processi di identificazione reazionari, che con quella logica sono del tutto compatibili.
Qui riemerge il tema centrale del punto di vista, della prospettiva: cosa significa produrre un’analisi femminista del sionismo come hanno fatto, tra le altre, le attiviste di Tal’at? Cosa ha significato e cosa significa ora, per le donne palestinesi che vivono e resistono in e a una doppia oppressione, coloniale e patriarcale, immaginare e lottare per una liberazione femminista della Palestina? Cosa succederebbe se quella prospettiva venisse meno? Chi ne farebbe le spese?
In questo momento, credo che per evitare approcci da femminismo coloniale, o coerenti con cosiddetto femminismo sionista – per il quale «femminismo significa dare alle donne lo stesso diritto di uomini nel gestire il capitalismo, con il suo sfruttamento, l’occupazione e il razzismo»[20] –, sia utile riconoscere i molteplici modi in cui le donne e gli uomini palestinesi resistono all’invasione e alla violenza israeliana, come hanno sempre fatto, ed essere disponibili nel momento in cui volessero rivendicare, tramite la loro liberazione, la possibilità di una forma di vita diversa all’interno e per la società palestinese libera.
Chiudo con una breve considerazione sull’università, sul lavoro di ricerca e sulle lotte che, tessendo rapporti transnazionali, si sviluppano nel contesto universitario. Come sottolineato da Michele Lancione, smilitarizzare l’università significa inchiestare e opporsi al diretto rapporto istituzionale tra gli atenei, i dipartimenti e i complessi tecnologico-militari come Leonardo o Frontex, pretendere la chiusura degli accordi di committenza mascherati da accordi di ricerca, e che le cordate con gli apparati della difesa vengano cancellate dai pilastri per i finanziamenti europei alla ricerca.
Vuol dire anche, a mio modo di vedere, produrre un discorso critico che rifiuti la logica e il linguaggio di guerra, i blocchi concettuali e identitari, che si riconosca la capacità di convalidare epistemicamente l’opposizione alla guerra nella sua complessità. Bisogna muovere da ciò che si sta già dando, non per automatismo, ma perché le lotte di questi mesi, nei campus e nelle università, hanno prodotto spostamenti e prese di posizione. Perché queste ultime non si trasformino in schieramenti monolitici, e a loro volta identitari, è necessario assumere collettivamente la complessità come punto di partenza, interrogandoci costantemente sugli effetti dei discorsi che “produciamo” nelle università.
Questo articolo è stato pubblicato su globalproject l’8 giugno 2024.
[1] Cfr. M. Dalla Costa, Donne e sovversione sociale. Un metodo per il futuro (1975), OmbreCorte, 2021; S. Federici, Salario contro il lavoro domestico, Napoli, 1976.
[2] V. Gago, La potenza femminista. O il desiderio di cambiare tutto, Capovolte, Alessandria, 2022.
[3] Sulle “operazioni” del capitale, S. Mezzadra, B. Neilson, Operazioni del capitale. Capitalismo contemporaneo tra sfruttamento ed estrazione, Manifestolibri, Roma, 2021.
[4] bell hooks, Elogio del margine, Tamu, Napoli, 2022.
[5] Rispetto a nuove prospettive internazionaliste, Sandro Mezzadra e Brett Neilson, Per un nuovo internazionalismo. Considerazioni preliminari, Euronomade 7 Aprile 2024
[6] Jin, Jiyan, Azadî come nella Palestina libera, Connessioni Precarie
[7] Nasvan: Un comitato segreto rivoluzionario per le donne iraniane, Connessioni Precarie
[8] Risolvere la questione palestinese, Globalproject 17 ottobre 2023
[9] Academy for Democratic Modernity, Opportunità e pericoli della terza guerra mondiale, Gennaio 2023.
[10] cfr. Istituto Andrea Wolf, Jin Jiyan Azadi. La rivoluzione delle donne in Kurdistan, Tamu, Napoli, 2022.
[11] Su questi aspetti Tommaso Baldo, Quale liberazione per la Palestina?, Globalproject 29 maggio 2024
[12] Cfr. I. Jad, Islamist Women of Hamas: Between Feminism and Nationalism, REMMM, 128, pp. 137-165.
[13] Cfr. P. Caridi, Hamas. Dalla resistenza al regime, Feltrinelli, Milano, 2023. Sui diritti delle donne palestinesi in West Bank, cfr. M. Hattab & M. Abualrob, Under the Veil: Women’s economic and marriage Rights in Palestine, in «Humanities and Social Science Communications»,10/2023.
[14]Uso le espressioni richiamando il dibattito tra Gennaro Avallone, Valentina Ripa, Michele Lancione e Giso Amendola.
[15] Hala Marshood e Riya Alsanah, Tal’at: a feminist movement that is redefining liberation and reimagining Palestine, Mondoweiss 25 Febbraio 2020. Sul ruolo di Tal’at.
[16] The birds shall return: Imagining Palestinian feminist futurities, Briatpatch Magazine 4 Maggio 2022
[17] Cecilia Dalla Negra, L’8 Marzo e il movimento femminista palestinese, Orient XXI 8 Marzo 2021
[18] Francesco Brusa, La lotta palestinese vista dall’Iran e i rischi dell’islam politico, Dinamopress 4 Dicembre 2023
[19] E. Said, La campagna contro il «terrore islamico». 21 marzo 1996, in Fine del processo di pace. Palestina/Israele dopo Oslo, Feltrinelli, 2002.
[20] Con la definizione di R. Abdulhadi, S. Adely, A.Y. Davis, S. James, Confronting apartheid has everything to do with feminism, Mondoweiss 21 Marzo 2017.