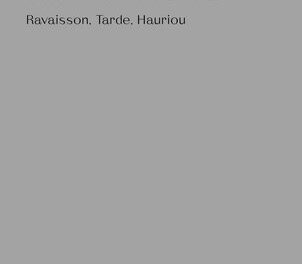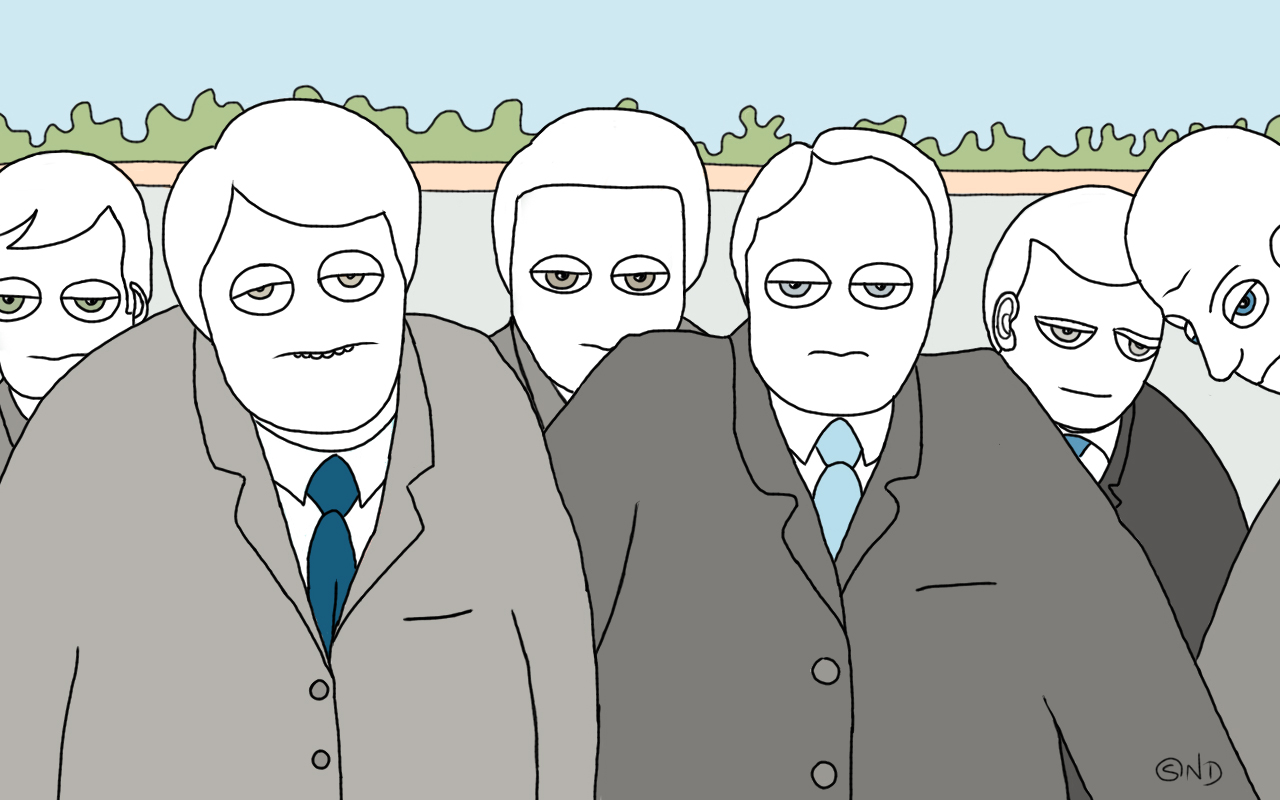di FANT PRECARIO.
Dopo quella di Crown of creation dei Jefferson Airplane [qui], prosegue la serie di recensioni di dischi del ’68, preannunciata dal testo-manifesto Il ’68 è la prosecuzione della legge del valore con altri mezzi [qui].
****
IL POVERO YORICK
presenta
“La musica del ‘68” – Cinquant’anni di plusgodimento acefalo
****
Vol. 2: SMALL FACES, OGDENS’ NUT GONE FLAKE – 24 MAGGIO 1968
1966: sulle facce dei Beatles, con la peluria, affiora l’intellettualismo; i Rolling Stones hanno intrapreso la via del satanismo “cortese”. Allora, se siete ultras del tamburo, spaccate tutto con gli Who; ma, se siete come la maggior parte di tutti i ragazzini del primo e del secondo mondo (questi ultimi ancora ebbri di disgelo e CZ), allora… allora Small Faces!
Nel 1966 (e non solo nel campo musicale) esistevano moltitudini di alternative e di argomenti. La situazione che la produzione musicale contrabbandava però era tale da lasciarli muovere confinati all’interno delle categorie esistenti. La critica e la sospensione delle categorie date appariva impensabile e invece…
 La partenza è al fulmicotone: ⇒ Sha La La La Lee è operazione quasi architettata a tavolino ma i ragazzi riescono a vivificarla con sapido tepore di rivolta; ⇒ All or nothing è un temporale d’agosto, potenza operaia assurda dove Marriot e Lane sono tanto la Zarina quanto Rasputin: confusione nelle vene, nel cervello rhythm & blues; ⇒ Itchycoo Park esce sempre d’agosto, ma del 1967: commistione di voci e stili, il flanger come cartografia di luoghi di sogno ed ebbrezza, ma pur sempre cartolina di una banlieue liberata. Tanto per dire (o forse no), il retro è ⇒ I’m only dreaming, ballatona struggente che consola i fans degli scarafaggi ormai ridotti ad anime di gomma. Qui è tutto concretissimo, Castrol TT annusato a mezza voce, vestiti ordinati e musica “da negri”.
La partenza è al fulmicotone: ⇒ Sha La La La Lee è operazione quasi architettata a tavolino ma i ragazzi riescono a vivificarla con sapido tepore di rivolta; ⇒ All or nothing è un temporale d’agosto, potenza operaia assurda dove Marriot e Lane sono tanto la Zarina quanto Rasputin: confusione nelle vene, nel cervello rhythm & blues; ⇒ Itchycoo Park esce sempre d’agosto, ma del 1967: commistione di voci e stili, il flanger come cartografia di luoghi di sogno ed ebbrezza, ma pur sempre cartolina di una banlieue liberata. Tanto per dire (o forse no), il retro è ⇒ I’m only dreaming, ballatona struggente che consola i fans degli scarafaggi ormai ridotti ad anime di gomma. Qui è tutto concretissimo, Castrol TT annusato a mezza voce, vestiti ordinati e musica “da negri”.
Se c’è qualcosa che nasce perfetto ed insuscettibile di mutazioni questo è il mod.
C’è purezza, e non solo nello stile. È il senso del meticciato: distillare la vita e farla gorgogliare nel sibilo di Vespe e Lambrette. In fondo, anche l’abbigliamento è una presa di distanza ferma e sicura dalla fabbrica cui la vita aveva destinato quei ragazzi. La rottura non è solo generazionale, ma ontologica. I mods si creano dispiegandosi nel ballo, dimenticando la guerra e la ricostruzione. Anche la scelta motoristica allontana dall’officina: non più pistoni bollenti o grasso. Il mezzo che aveva portato le coppiette italiane al mare o sullo Stelvio ad aspettare Coppi, conduce la giovane e degenere comitiva sul lido di Brigthon (dove non faceva paura tanto il rocker di turno quanto il rischio di rivedersi anni dopo nell’immagine orrenda del pungiglione quadrifonico, ancora dopo patetico inglese nella New York reaganiana).
Il mod quale hortus conclusus, rivoluzione ciondolante, singolarità completa e duttilmente ingegnata a sopravvivere al canto del cigno dell’industria britannica (e mondiale).
Ma se mod è anzitutto musica, timbro vocale e sezione ritmica jazzy, se l’eleganza, pure sobria, è orpello vivificante, come lo si coniuga con il putiferio del maggio? Ebbene, anche a Brigthon, come a Parigi, sotto i sampietrini c’era la spiaggia, ma il mod non correva il rischio di trovarsi a Saint Tropez come i Pink Floyd o Jagger in luna di miele. Non c’era bisogno di sacrificarsi per la rivoluzione come avrebbe fatto il fegato di Joe Cocker. Era il rantolo di vita degli irrilevanti della storia (riavvolgendo la storia con le parole di Brzezinski).
Il ’68 per il mod non è stravolgimento di costumi, non si tratta di rompere con il passato, perché il mod è presente eterno e perfetto.
I gravami affastellati sulle spalle dell’operaio, tanto sotto le spoglie di fucile che di libretto da sventolare rallentano i movimenti nel grigio del corteo leninista (che ti ritrovi cinquant’anni dopo a essere Staino).
I fiori nei capelli dissolvono, nel vezzo, la beat generation (che già Monterey sembrava un incontro scapoli/ammogliati).
E il mod? Il mod, che già dovrebbe essere tronfio dell’esito della propria rivoluzione di febbraio, risponde secco, e il 24 maggio dell’anno della revolution stacca il biglietto dell’eternità. Un disco, 12 traccie, 6 sul lato A e 1 (ma sono 6) sul lato B.
Mi piace consumare. Se non consumi ti consumi (come avrebbe detto nel fuoco di un’altra rivolta Poly Styrene.
Chiariamolo subito: si tratta di musicisti fantastici, un frontman insuperato, un suono perfetto tanto nei tempi che nelle melodie.
Nell’anno delle canzoni che si dilatano e diventano orge strumentali per seminaristi in (poco) calore, portando fior di batteristi a sfidare il suono del martello pneumatico e chitarristi decorosi a confondere il gesto con il progetto, il mod punta sulla precisione del proprio essere mod (che non è autoreferenzialità ma consapevolezza di autodeterminazione svincolata da ogni valutazione in termini di scambio) e declina la meglio gioventù (che è di ognuno per quella che vive) in termini chiari “perfetti”.
Perché è di perfezione che deve parlare.
Per il mod la più urgente espressione di libertà è la distruzione degli idoli, soprattutto quando questi sostengono di rappresentare la libertà. La spinta gentile del disco verso il bordo, l’estremo, è la soluzione. Loro, che idoli già sono, negano lo status e alla fabbrica delle note, che si installa stabile in ogni raduno, rispondono con l’esodo.
In fondo, l’(auto)epurazione rafforza il beat.
A Godzilla risponde la piccola fiammiferaia, che stavolta non sbaglia il colpo e incendia tante piccole piazze popolate di piccoli geni in lambretta; si rompe il circuito dello scambio. Per un attimo la periferia è centro, il centro è dissolto nell’economia dello spreco e della perdita.
Ogni movimento produce naturalmente rumore, il rumore è richiamo diretto all’azione e porta a prendere una decisione assoluta. Quel disco fu la decisione.
Il primo solco reca il titolo del disco. Un giro ripetuto come un vento che dolce sventra le credenze della “buona armonizzazione”. Pacato ma con rigore. Due minuti e ventisei di aforismi recitati da un’orchestrina ricavata dal pieno come il mozzo di una BSA Victor. La strada è gettata e se – gettati sul lastrico dalla perfida Maggie – la resurrection si darà con gli Stone Roses, sarà anche nel ricordo di quel dipanarsi di note nel giugno dell’anno del maggio.
Afterglow: 3minuti e 31 secondi di prospettiva hard in un mondo ancora non rappreso nelle dita di Leon Russell. Prospettiva di un hard ancora lontano (non troppo lontano, purtroppo) nella totalità del vincolo.
L’universale, qui, non passa.
Avvio acustico che verrà copiato da miliardi di magliari, coro che custodisce il canto maliardo. Il piano. Love is all around me, everywhere.
Sembra una minchiata e invece ci credi.
La voce ti accarezza, poi esplode, vince ogni resistenza con la batteria che rende felici tutti i Jack depistati. Poi, tutto si placa e il suono castiga ogni velleità di proseguire nella sapida espressione per lasciarti sudato in attesa della successiva canzone.
Altri due minuti e trentaquattro cullando come onda nel cielo di palazzone di periferia, vivo di facce non ancora disperse.
Rene è post-beatlica cinque anni prima degli ABBA, dà il tempo della Waterloo dei fab, costretti, nemmeno un anno dopo a day in a life, a rincorrere il treno della creatività operaia. Potrebbe aggirarsi l’ispettore Closeau nel giardinetto antistante il palazzone di cui sopra, ma potrebbe essere anche Guida, il fascista questor, subito irriso dal coretto che annega nella ripetizione mai ripetitiva, ossessione di esserci ancora.
Esserci ancora, appena in tempo per Son of a baker. Poco più di tre minuti che registrano la stupidità della piega che ha preso “l’anno degli studenti”. L’attacco potrebbe essere violento e invece è soltanto concentrato di potenza. La chitarra si aggira tortuosa ma pacata in contrasto alla voce che cadenza il ritmo dell’eresia beat. In forma strepitosa, i ragazzi potrebbero fare i bavosi e smontare e rimontare riff per ore e ore. No, proprio la comprensione del momento rende la canzone esempio di specificità che ammutolisce. Nessun effetto: l’assolo di chitarra è di una manciata di secondi, ma vale l’opera omnia dei discepoli di Clapton tutti, la batteria frulla canonica ma tempestosa, il basso resta, non travalica il proprio ruolo ma è un ruolo infinito.
Marriott è l’Hoffmansthal della chitarra. Prima ancora di suonare è già musica.
Accattatevi le camicie di Hendrix, il pitone di Page, l’agonia di Jeff Beck. E morite.
Il superamento in Son of a baker si dà nella progressione, il capitale resta al palo: nessuna gara, nessun determinismo nell’affermazione di diversità – soltanto coscienza dell’essere già dopo. Nessun bisogno del socialismo nella rivoluzione gentile di Marriott: incide il proprio Che fare senza indicare quale tra le due tattiche della socialdemocrazia sia corretta.
Perché il beat tuba con il centro sinistra e da questo è tradito. La storia si ripeterà. Ogni mod, anche posticcio, anche meraviglioso, avrà il suo Rumour o il suo Blair.
Ogdens’ nut gone flake no, perchè noi la dialettica / non l’imparammo da Hegel. / Con il fragore delle battaglie / irrompeva nel verso / quando / sotto i proiettili / dinanzi a noi fuggivano i borghesi / come una volta noi davanti a loro. E poi la dialettica ci faceva cagare, e la rivoluzione non era come il paradiso, non poteva attenderne i tempi.
Non c’è Nep in quei suoni. Nessuno ci ordinerà di arricchirsi. L’ispezione operaia e contadina è riorganizzata in piena autonomia, anzi si auto-organizza in brevi fulmini di unguento per mani che, perlomeno, non avrebbero mai conosciuto il tornio.
La catena non è spezzata, semplicemente non esiste più. Svanita, nel canto e nella progressione dinastica della classe operaia, per poco – purtroppo – non più tale.
Lazy Sunday da la misura del cambio. Ti canterò una canzone senza parole e senza melodia: è un pigro pomeriggio domenicale, latitano la messa, il meritato riposo, il terrore di ritornare al lavoro il lunedì.
In barba ai situazionisti, la noia non era più controrivoluzionaria, era riapprensione della propria atemporalità.
Non ci sono più fabbriche, padroni, polizia: solo un palazzone di periferia, nel quale siamo seduti come in un arcobaleno.
Resta l’accento cockney volutamente eccessivo, dimostrazione ulteriore della vittoria definitiva sul capitale.
La Side B è un’unica traccia che assembla sei motivetti (e non in senso riduttivo, ma per la dolce compressione che esercitano sui sensi e nelle pulsioni che si fanno rarefatte) attraverso una voce narrante quieta: “Are you all sitting comftybold two square on your botty? Then I’ll begin…“.
Chiamiamola suite o concept album o come vi pare.
Prima di Tommy, prima di Arthur, prima di tutte le cialtronate prog.
La storia di Happiness Stan fluttua nell’appartamento con mobili in formica e ti accorgi che non c’è più uno spazio disponibile per il lavoro.
La semplicità ricostruttiva si pone nell’inutilità del compromesso pop, tanto la purezza (altrimenti) pop distilla il pur elaborato tappeto sonoro che si stende dal divano al televisore. Ovviamente si tratta di un appartamento dilatato nella comprensione psichedelica del momento, ma resta un appartamento, lontano dalla falsa democrazia dello spazio aperto, laddove se ti è permesso di apparire è per ciò che non sei.
Il tono di una calligrafia perfetta che si estinguerà non appena finito il disco. Era un’opera che non fu messa in scena per i frequentatori abituali dei teatri o dei festival, ma per tutti quelli che non potevano permettersi tali rappresentazioni. E quando tutto si dissolse il paradosso ci colse. Esplusa la vita, restarono i morti che ancora ci opprimono. Espluso il mod, restò la codardia del pop. E allora teniamoci Bono e Salvini.
Ma, fratello non temere!
Continuando a parafrasare il poeta, ma il mod par che dorma ma sta sospesa in aria l’immensa proletaria sua cultura, e dopo cinquant’anni, ancora, in questa estate di cittadini esasperati che ci spiegano la loro nozione di spesa, in lontanza, Happiness Stan (forse per questo, Happy) ricomincia a raccontare la propria storia di autonomia e leggiadra demolizione dell’inutile ampollosa esistenza del capitale.
Controindicazioni:
«Non è necessario immaginare la fine del mondo nel fuoco o nel ghiaccio; ci sono due altre possibilità: una sono le scartoffie, l’altra è la nostalgia» (Frank Zappa).