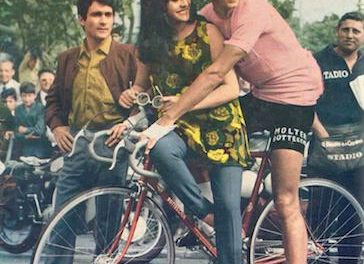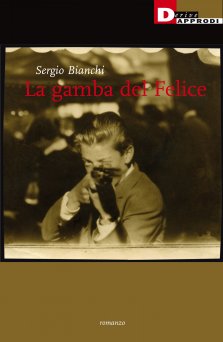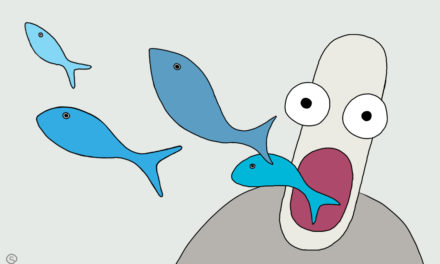di FRANCESCO FESTA.
La scuola di classe: pedagogia radicale, coscienza critica e pratica politica. Rileggendo don Milani e Paulo Freire
Nel 1967 don Lorenzo Milani e i ragazzi della scuola di Barbiana pubblicano Lettera a una professoressa1. Don Milani dedica la sua vita al mondo del lavoro nelle fabbriche e nelle campagne del Mugello, dove da “maestro di strada” (come si direbbe oggi) a Barbiana, a metà degli anni Cinquanta, tenta di dare ai poveri, ai «montanari», la possibilità di accedere alla cultura, agli strumenti per emanciparsi dalla miseria delle campagne.
La Lettera nasce quando due ragazzi della scuola di Barbiana vengono bocciati agli esami per il diploma per diventare maestri. Essa lancia un j’accuse contro le contraddizioni della scuola e contro l’ipocrisia della società italiana. La «scuola italiana» è «un ospedale che cura i sani e respinge i malati»: non s’impegna a recuperare e aiutare i ragazzi in difficoltà, ma valorizza chi già ha un «retroterra familiare positivo»2. La «scuola italiana è di classe»: riproduce le stesse disuguaglianze economiche e culturali presenti nella società.
Segnalato da Girolamo De Michele, don Milani e Gianni Rodari vengono accusati di essere artefici di «una presunta distruzione della scuola pubblica». Tra i detrattori vi sono l’editorialista Sergio Romano e l’ex ministro Gelmini, che non potrebbero non avere un’idea selettiva della scuola! In realtà, «la scuola pre-Sessantotto», in cui è intervenuto don Milani, «generava una società analfabeta»: il 63% degli italiani non comprendeva un testo in prosa; invece, delle fasce medio-alte, vi riusciva appena l’1.9%. Vale a dire che questa porzione di istruiti, che «aveva superato una selezione neanche darwiniana, ma malthusiana»3, era in possesso di strumenti linguistici e culturali. Per la verità, quando nel 1962 venne abolito il sistema che costringeva i ragazzi e le loro famiglie a scegliere alla fine delle elementari se continuare a studiare per proseguire alla scuola media superiore o seguire l’avviamento al lavoro, solo una piccola parte continuavano a studiare: coloro in possesso dei mezzi economici e culturali.
La Lettera ha dunque fatto luce sull’essenza della società borghese e sui suoi apparati, quali strutture delle gerarchie di classe. Del resto, la stessa Costituzione del ’48, fondata sul lavoro e sulla rendita, nulla in pratica può opporre alle differenze sociali e alla ricchezza della borghesia proprietaria. Ciò nondimeno don Milani ne rivendicava l’adozione, sperimentando quella che con La pedagogia degli oppressi di Paulo Freire, libro uscito nello stesso anno della Lettera, possiamo chiamare «educazione problematizzante» o anche superamento della «contraddizione educatore/educando» (egemonia/subalternità)4.
La stagione della solidarietà e la «controrivoluzione neoliberista»
 Con don Milani la scuola incominciò a cambiare. I «montanari» di Barbiana inaugurarono la stagione della solidarietà, cortocircuitando l’ethos borghese. Nel frattempo, la Lettera attraversava le lotte sociali degli anni Sessanta e Settanta. Mentre le classi subalterne curvavano la barra dei diritti ed eguaglianza sociale, riconquistando una parte, seppur piccola, di quella ricchezza sociale e operaia prodotta durante l’Età d’oro del capitalismo sotto forma salariale e di welfare.
Con don Milani la scuola incominciò a cambiare. I «montanari» di Barbiana inaugurarono la stagione della solidarietà, cortocircuitando l’ethos borghese. Nel frattempo, la Lettera attraversava le lotte sociali degli anni Sessanta e Settanta. Mentre le classi subalterne curvavano la barra dei diritti ed eguaglianza sociale, riconquistando una parte, seppur piccola, di quella ricchezza sociale e operaia prodotta durante l’Età d’oro del capitalismo sotto forma salariale e di welfare.
In tale fervore, la scuola venne concepita come apparato ed esperienza in grado di praticare una «rottura epistemologica» nel potere politico. La scuola venne intesa quale spazio di realizzazione della laicità e dell’accessibilità a tutti ai servizi, indistintamente dalle condizioni economica e culturale. Oltremodo la scuola italiana rifletteva il processo di nation building, di costruzione della «comunità immaginata»5: un paese che, senza soluzione di continuità, aveva attraversato guerre civili, colonizzazione interna, identità posticce e passatismi fascisti.
Le trasformazioni s’interruppero negli anni Ottanta con la «controrivoluzione neoliberista», giunta in Italia nei Novanta. Nuove forme di accumulazione originaria, finanziarizzazione del debito pubblico, inclusione differenziale delle classi subalterne, tanto nel pubblico quanto nel privato: alcuni passaggi che enucleano la dichiarazione del plurimiliardario Warren Buffett: «noi ricchi abbiamo vinto la lotta di classe». David Harvey l’ha definita «distruzione creativa»: distruzione dei rapporti salariali, delle relazioni sociali, degli stili di vita e di pensiero, delle attività riproduttive, degli atteggiamenti affettivi, per convertire il mondo alla nuova ratio neoliberalista, all’individualismo borghese6, che ha restaurato la scuola classista e selettiva, ri-significandola della sua funzione primaria: apparato che riproduce la classe dirigente. Il ciclo di riforme in Italia inizia alla fine degli anni Ottanta (la famosa Legge 168 del 1989-92, del ministro Ruberti, che si scontrò col movimento della Pantera) per concludersi con la Riforma Gelmini.
L’idealismo e lo storicismo nella scuola italiana
La Lettera prende di mira anche il modello d’insegnamento della scuola italiana. Il modello neopositivistico le cui basi sono la selezione di classe e il darwinismo sociale: l’idea che vi siano uomini in grado di civilizzare e di dirigere l’umanità.
Infatti, la scuola del dopoguerra andava modellandosi sull’idealismo e sullo storicismo, a stretto legame con la Riforma fascista di Giovanni Gentile che assieme a Benedetto Croce aveva animato il dibattito filosofico nel primo quarto del Novecento. Entrambi erano modelli borghesi di organizzazione culturale, in cui l’esclusione era struttura della società e le differenze definivano ruoli e funzioni in base alla prosperità e alla cultura. Infatti, sia don Milani, sia Pier Paolo Pasolini puntavano il dito contro questi modelli, quali incubatori di esclusione sociale, poiché l’appartenenza alle classi subalterne ne determina l’esclusione dall’accesso a quelle risorse che conducono ad accumulare un capitale culturale sufficiente per ricoprire determinati ruoli nella società.
Tale discorso è affatto attuale, anzitutto all’interno della pedagogia neoliberista. Capitale umano e individuo come impresa di sé (self made man); «società modellizzata sulla ratio imprenditoriale» (efficienza, economicità, efficacia7) e volta al proprio superamento: sono alcuni capisaldi neoliberisti che fanno eco alle nozioni storiciste di «missione civilizzatrice» e «spirito del mondo», vale a dire all’idea che il governo spetti a uomini di cultura, a chi abbia frequentato determinate classi. Così «Pierino del dottore» torna al posto di comando.
Nel neoliberismo il rapporto sociale è intenso fra aspirazioni e condotte personali, da una parte, e dall’altra rappresentazione e comportamenti pubblici. L’impresa è il modello, la tecnica del sé sono la prestazione e la concorrenza. Sicché lo spazio pubblico è occupato dalla concorrenza e la reattività, mentre il godimento è la prestazione sociale. La rappresentazione in pubblico è l’accumulazione di immagine e gradimento (capitale sociale). Da qui l’emulazione dei modelli manageriali e televisivi, grondanti machismo, e il desiderio dei subalterni di avvicinarsi ai modelli egemonici, ove Pasolini ha situato la tragedia per cui i proletari «iniziano a vergognarsi di esserlo»; ciò che Freire chiama «processo di prescrizione», ossia «l’introiezione dei valori degli oppressori». In tal senso, la premonizione di Guy Debord è ormai l’architrave della fabbrica del soggetto neoliberista: «l’intera vita delle società si annuncia come un immenso accumulo di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione»8.
Una coscienza critica per un umanesimo democratico
Vale la pena di interpellare quale sia – e se esista – una funzione critica della scuola. Senza dubbio il tema della «rottura epistemologica» acquista una sua centralità nei processi di soggettivazione e nei percorsi pedagogici. Quale sarebbe lo statuto epistemologico di una pedagogia di questo tipo, che decostruisca la ratio neoliberista e che disinneschi i dispositivi individualistici e imprenditoriali? Per dirla con Edward Said: come produrre una «coscienza critica», «una ricerca incessante di alternative» alla staticità delle idee, all’arroganza del pensiero dominante, al lavoro degli intellettuali che non mettono in dubbio dogmi e autorità, come insegnare a praticare un «umanesimo democratico», aperto a tutte le istanze politiche, sociali e culturali: un processo ininterrotto di (auto)critica e di liberazione dallo sguardo delle classi dominanti?9
Formuliamo delle ipotesi a partire da alcune esperienze concrete.
Nella storia delle classi subalterne esiste una vasta letteratura, per lo più sociologica, in cui si mette in luce il processo di progressiva perdita di autostima del subalterno, che sia disoccupato, contadino, “lavoratore informale” o precario, e la riduzione della sua speranza nel futuro, se non fosse solitamente per l’intervento provvidenziale della figura del «galantuomo», del Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, che ne interrompe il precipitare verso la morte. A fronte di questa letteratura vi è una lunga tradizione di storie minori. Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, L’uva puttanella e Contadini del Sud di Rocco Scotellaro, La terra del rimorso di Ernesto de Martino, Autobiografie della leggera di Danilo Montaldi, Il Mondo dei Vinti di Nuto Revelli, Inchiesta a Palermo di Danilo Dolci, Ragazzi di vita, Una vita violenta e i documentari di Pasolini, sono alcuni esempi in cui i subalterni prendono parola. Fra questi è Ci dicevano analfabeti di Fabrizia Ramondino sui Disoccupati organizzati di Napoli. Un libro che non ha come scopo quello di condurre un’analisi della condizione dei disoccupati negli anni Settanta, né di dare una valutazione politica del loro movimento, al contrario di altri libri sull’argomento, il suo interesse è rivolto al modo di pensare, alla vita, ai valori e alle forme espressive dei subalterni. «Credevasi che fossimo analfabeti»: questa convinzione diffusa dal potere e dalle istituzioni è denunciata da un disoccupato. In effetti, il potere delle classi egemoni si fonda sulla convinzione che la sovranità del parlare e del guardare spetti a chi ne detenga gli strumenti linguistici e culturali. Chi detiene tale sovranità ha anche il primato di organizzare la concettualità filosofica e politica, l’insegnamento, le gerarchie dei saperi e l’organizzazione della cultura. Invece, don Milani ci ha insegnato che i poveri, i figli di proletari hanno «una lingua, un modo di fare, una concezione del mondo che hanno la stessa dignità di quella degli istruiti. Con la differenza che i poveri sanno dell’esistenza degli istruiti, questi ultimi non concepiscono l’esistenza di un mondo “altro”».10
Gramsci dedica riflessioni significative sull’«organizzazione della cultura», quale campo strategico della classe borghese poiché dà a essa «omogeneità» e «consapevolezza» indispensabili per esercitare le «funzioni non solo nel campo economico, ma anche in quello sociale e politico», tanto che «l’imprenditore crea con sé il tecnico dell’industria, lo scienziato dell’economia politica, l’organizzatore di una nuova cultura, di un nuovo diritto, ecc.»11. Ebbene, queste figure esercitano uno sguardo profondo sul mondo, un canone culturale per tutti i campi del sapere. Dunque, lo storicismo è lo sguardo della classe borghese europea, lo sguardo che ha istruito il canone culturale occidentale e le frontiere della cittadinanza. Ciò che non appartiene a questo canone è posto ai margini, è alterità senza possibilità di parola. Rompere lo sguardo vuol dire prendere parola, equipaggiarsi di strumenti culturali atti ad affermare politicamente l’esistenza di un mondo “altro” e di una cultura subalterna; vuol dire promuovere una «coscienza critica» e ricercare alternative all’arroganza del canone occidentale, eurocentrico e borghese.
Ad esempio pensiamo a Frantz Fanon e William E.B. Du Bois che dai margini dell’eurocentrismo, lungo la linea del colore, hanno incarnato i laceranti dilemmi del «come ci si sente a essere un problema? Come ci si sente a essere guardati?»12. Dall’Europa e dall’America, figli della diaspora, hanno ripercorso il processo di costruzione di identità anomala, la formazione di una «doppia coscienza», la condizione di una soggettività costretta a «guardarsi sempre attraverso gli occhi degli altri»13, a subire l’analisi essenzializzante dello sguardo “normale”. Ebbene, i figli delle classi subalterne, se non costretti a guardarsi con gli occhi degli altri, hanno certo dismesso i panni della propria cultura nel tentativo di eguagliare i tratti, i comportamenti e gli stili di vita della cultura borghese. Uno sforzo di emulazione da parte subalterna che, in realtà, è la cattura dei desideri da parte delle classi egemoni. Questo fenomeno emulativo registra l’accumulo di modelli e stili di vita come forme di rappresentazione e condizione di esistenza per le stesse classi subalterne. Del resto, il rappresentare è un formidabile dispositivo di cattura della cultura borghese, poiché esercita un doppio potere: rendere presente ciò che è assente e di costituire legittimità di questa presenza esibendo qualificazioni e giustificazioni. Una pedagogia radicale occorre che sveli i processi di emulazione e i meccanismi culturali; che pratichi la riappropriazione della cultura popolare quale disinnesco dei dispositivi della rappresentazione; che metta fine al flusso di sguardi essenzializzanti, il cui sottrarsi diventa invece l’attivazione della cattura dei desideri tramite modelli e stili di vita inappropriati.
Davide Bifolco e il fenomeno Gomorra
 Nei seguenti esempi abbiamo due tipi di narrazioni essenzializzanti e di formazioni discorsive che abusano di letture antropologiche, trasformando concetti e schemi analitici (usati per la ricerca, in contesti molto rigorosi) in concetti realistici, come se si riferissero a realtà effettive. L’analisi volge a favore di una sola opzione, le altre vengono destituite o catturate nell’economia del discorso dominante.
Nei seguenti esempi abbiamo due tipi di narrazioni essenzializzanti e di formazioni discorsive che abusano di letture antropologiche, trasformando concetti e schemi analitici (usati per la ricerca, in contesti molto rigorosi) in concetti realistici, come se si riferissero a realtà effettive. L’analisi volge a favore di una sola opzione, le altre vengono destituite o catturate nell’economia del discorso dominante.
Il primo esempio è un articolo del Corriere della Sera dell’8 settembre 2014, a firma dello storico meridionalista Paolo Macry14, uscito dopo l’uccisione del diciassettenne Davide Bifolco, nel rione Traiano, alla periferia di Napoli, per mano di un poliziotto dopo un breve inseguimento per un mancato fermo a un posto di blocco.
Liquidata in poche battute la vicenda della morte, Macry sbotta in seguito con rappresentazioni essenzializzanti sulle periferie attraverso uno schema definito: da una parte la legge, dall’altra l’anomia. Tertium non datur: oltre non vi è interpretazione. Non vi sono ipotesi contrapposte, ma l’una e l’altra partecipano della correità: l’anomalia di una periferia preda della criminalità serve a ricucire un potere istituzionale corrivo con la morte del diciassettenne. Diversamente anche la funzione discorsiva dell’articolo perderebbe la sua incisività.
A Napoli esistono i ghetti – scrive Macry – nella Parigi di Victor Hugo o nella Londra di Charles Dickens il confine di classe […] è lungamente il confine di razza, a Napoli è il confine della legalità. Scampia, Forcella, il Rione Berlingieri, il Rione Luzzatti, costituiscono aree economicamente degradate e urbanisticamente fatiscenti, ma sono anche il luogo di una contrapposizione dei cittadini allo Stato […] È qui che si nascondono i latitanti, che la gente cerca di resistere con la forza agli arresti della polizia, che i conflitti tra interessi vengono risolti da una giustizia privata e cruenta e le guerre tra bande armate avvengono alla luce del sole […] Sono insomma ghetti perché riflettono un contesto infernale ma anche perché, in qualche modo, si sentono essi stessi ghetti […] territori separati dal resto del tessuto urbano, soggetti a codici speciali, abituati a proprie gerarchie di potere, fidelizzati con ricompense di varia natura dalle organizzazioni criminali.
Nelle periferie, dunque, i canoni istituzionali mutano differentemente che in altre parti della metropoli: le tecnologie di governo assumono caratteri straordinari (extra legem); il monopolio della forza adotta una condizione di eccezionalità permanente. D’altronde, lo stesso Macry ammette l’esistenza di una dislocazione dei confini della cittadinanza, di un’asimmetrica di poteri a seconda degli spazi della metropoli, utilizzando una serie di cliché. Da una parte, un classico dell’orientalismo sul Mezzogiorno: l’allusione all’inferno, già immagine pittoresca utilizzata da Croce, Un paradiso abitato da diavoli, a sua volta ripresa da una raffigurazione settecentesca. Dall’altra, una concezione tipica della letteratura sulle classi subalterne e le classi pericolose, allorché afferma che «la reazione della gente del Rione Traiano, l’assalto alle auto delle forze dell’ordine, le dichiarazioni di amici e passanti, il corteo aggressivo segnalano un fenomeno che, pure in momenti di forte e comprensibile emotività, non andrebbe sottovalutato»: con Eric Hobsbawm sappiamo che le rivolte e le sollevazione dei subalterni appaiono come «forme primitive di rivolta sociale», «forme prepolitiche che ancora non sono riuscite a trovare un linguaggio», che non sono state integrate nelle forme politiche e istituzionali borghesi15. Ne consegue che le manifestazioni in certi quartieri di Napoli sono dirette o corrive alle organizzazioni politico-criminali.
Il secondo esempio è la fiction Gomorra. Un successo mondiale tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Sia la fiction che il libro si reggono su frusti stereotipi e frame storici neopositivistici, descrizioni morali di una popolazione preda inguaribile dei suoi incubi atavici. I napoletani appaiono come passionali, indisciplinati, ribelli, individualisti e, soprattutto, inabili alla formazione di una cultura razionale, civica, ordinata e privi di senso dello stato. Il contesto sociale risulta sottosviluppato a causa del clientelismo, delle relazioni gerarchiche e patriarcali, e su tali condotte pubbliche s’innervano le varie forme di manifestazione del crimine organizzato e dell’illegalità diffusa. All’interno di questo frame, i camorristi vengono rappresentati come una enorme macchina che fagocita immagini, merci, droga, prestigio e godimento sociale. Per di più, in Gomorra viene riabilitata una carrella di luoghi comuni, annidatasi nel senso comune, grazie all’uso delle presunte verità prodotte dal meccanismo della rappresentazione. Assumono la dimensione realistica proprio quelle immagini cristallizzate nel tempo, sostenute da concetti scientifici utilizzati in ambiti processuali come verità giudiziarie. D’altro canto, come ha notato Foucault, «la misura delle grandezze e delle molteplicità» dei saperi o delle informazioni diviene «istituzione di un ordine» quando designa un «campo di verità», uno «spazio in cui interagiscono due tipi»: da una parte, il bene, la parte sviluppata, e dall’altra il male, l’arretrato. Tanto nella narrativa quanto nella sceneggiatura di Gomorra, questa dicotomia diventa pericolo incombente, senza distinzione territoriale: il degrado meridionale, anziché eccezione, diviene una mostruosa raffigurazione di una linea di tendenza ormai generalizzata a livello nazionale e globale, in un incedere senza soluzione di continuità, dove tutto è criminalità, fagocitato dalle condotte illegali e indolenti dei napoletani. È una rappresentazione intrisa di superficialità e banalità, il cui scopo è quello della denuncia e dello smascheramento, ma privo del “parlar franco”, privo di chi siano i responsabili politici di tale stato di cose.
A dire il vero, la fiction Gomorra ha sortito un effetto contrario: una sorta di colonizzazione dell’immaginario, suscitando nelle classi subalterne un fenomeno emulativo. Ciò che è violentemente reale viene spettacolarizzato e desiderato. L’accumulazione di immagini e di modelli è condizione di prestigio e di un godimento. Infatti, Gomorra pare riscuota un certo successo tra i figli delle classi subalterne, ormai è un vero cult, più incisivo di Scarface di Oliver Stone o de Il Camorrista di Giuseppe Tornatore.
La pedagogia degli oppressi
Una pedagogia radicale deve svelare il senso di queste narrazioni, decostruendo i dispositivi ideologici e le formazioni discorsive che si celano dietro eccellenti operazioni editoriali, utili alla gioia del pubblico pagante e alla società dello spettacolo.
Don Milani insegnava «a esseri umani in carne e ossa», con un «vissuto, un’affettività, una storia, dei bisogni»16. Ebbene, varrebbe la pena di educare all’esercizio della critica attraverso una strategia didattica che tenga conto delle condizioni materiali e del vissuto dei nuovi poveri, dell’offensiva ideologica delle narrazioni tossiche e delle fiction mainstream, della complessità linguistica delle classi subalterne. Occorrerebbe utilizzare una strategia che analizzi i saperi in campo, come l’economia politica criminale, cui i nostri scrittori e anche alcune associazioni che alla fiction hanno compartecipato si guardano bene dall’adoperare. Basterebbe chiedersi se l’immoralità e l’illegalità non siano consustanziali al neoliberismo, a un sistema di accumulazione che si regge su soggettività individualiste, concorrenti e imprenditoriali, prive di regole e leggi se non quelle del profitto e dell’autorità. Occorrerebbe svegliare le coscienze per riscoprire un’umanità emancipata dai beni e dalle rappresentazioni: prendere coscienza del «processo di prescrizione e di disumanizzazione», dell’introiezione di valori esterni, non appartenenti alla propria classe, ma alla classe degli «oppressori», dove la «percezione di cambiamento è intesa nello svoltare da oppresso in oppressore». Sarebbe un tentativo di decolonizzare l’immaginario, di portare alla luce la dimensione materiale delle rappresentazioni, delle formazioni discorsive ormai sedimentate nel senso comune. Sarebbe un modo di rispondere alla domanda su come ci si sente a essere guardati dall’esterno senza dover per forza far proprio quello sguardo ed emulare modelli di vita esterni. Sarebbe un modo per porre fine all’auto-rassegnazione e all’auto-assolvimento dinanzi alle rappresentazioni esterne, dacché lo sguardo non è più esterno. Sarebbe un modo affinché i nuovi poveri non si percepiscano come mancanti di qualcosa.
Dopotutto, la domanda cui rispondere per praticare una pedagogia degli oppressi è sempre la stessa: perché il figlio di poveri o di precari di oggi non dovrebbe adoperare la violenza, lo strumento più immediato a sua disposizione, per concorrere con i figli di ricchi pur di godere degli stessi beni all’interno della società dello spettacolo?
questo testo viene pubblicato in contemporanea con Deco[K]now
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1990 (1967). ↩
Esemplificando questo genere di allievi con il personaggio di «Pierino del dottore», Pierino, figlio del dottore, che sa già leggere quando arriva alle elementari. ↩
G. De Michele, L’obbedienza non è più una virtù. Che cosa significa “educare”?, qui. ↩
P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011 (1967). ↩
B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma 1996. ↩
D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano 2007, p. 11. ↩
C. Laval, P. Dardot, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, Derive Approdi, Roma 2014, p. 419. ↩
G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini Castoldi, Milano 2008. ↩
E. Said, Teoria in viaggio, in Post-orientalismo. Said e gli studi postcoloniali, a cura di M. Mellino, Meltemi, Roma 2009. ↩
G. De Michele, op. cit.. ↩
A. Gramsci, Per la Storia degli intellettuali, Quaderno 12, in Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975 (1947), p. 1513. ↩
S. Mezzadra, Questione di sguardi. Du Bois e Fanon, in M. Mellino (a cura di), Fanon postcoloniale. I Dannati della terra oggi, ombre corte, Verona 2013, pp. 189-90. ↩
W.E.B. Du Bois, Sulla linea del colore. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo, a cura di S. Mezzadra, Il Mulino, Bologna 2010, p. 116. ↩
I ghetti di Napoli e le responsabilità della politica, qui. ↩
E. Hobsbawm, I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, Einaudi, Torino 1966. ↩
G. De Michele, op. cit.. ↩