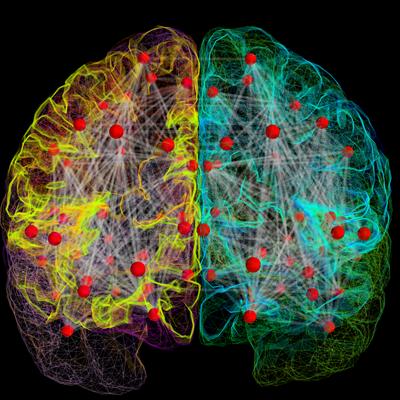di SANDRO MEZZADRA e BRETT NEILSON[1]
(pubblicato in “Alternative per il socialismo”, luglio-agosto-settembre 2023. N°69, dedicato a Le conseguenze della guerra, che ringraziamo per la disponibilità)
1. In questione è per noi ancora una volta il capitalismo. La “distruzione creativa” ne caratterizza e ne sospinge lo sviluppo, diceva Schumpeter. Ma già Marx aveva inscritto il capitalismo, nei Grundrisse, nel segno della “rivoluzione permanente”. Nella crisi dei primi anni Settanta del secolo scorso questa rivoluzione ha assunto un ritmo nuovo, tra finanziarizzazione, “rivoluzione logistica”, nuove geografie produttive, trasformazione dello Stato e di modelli sociali consolidati in molte parti del mondo. Cominciava a delinearsi quella che, dopo la fine dell’Unione Sovietica, si sarebbe chiamata globalizzazione. Il pensiero critico e rivoluzionario ha tentato di afferrare queste trasformazioni e di fissarle in un concetto, spesso focalizzandosi su quel che il capitalismo non è più (“postfordismo”, ad esempio) ma tentando anche di offrire nuove definizioni, “capitalismo cognitivo” o più di recente “capitalismo delle piattaforme”, per dare soltanto due esempi. Non intendiamo qui discutere i meriti e i limiti di queste e altre formalizzazioni teoriche, che quantomeno nei casi più interessanti hanno comunque il merito di portare l’attenzione su nuove composizioni emergenti del lavoro, su una nuova figura dell’antagonismo costitutivo del rapporto di capitale. Solo, registriamo un ritardo, come se ci fosse uno scarto rispetto alla velocità e al carattere per certi aspetti proteiforme del capitalismo contemporaneo, le cui trasformazioni spiazzano continuamente i modelli, l’“esposizione” potremmo dire ancora con Marx, costringendo a riaprire la “ricerca”.[2]
Per affrontare questo “ritardo” scegliamo di collocare il nostro lavoro nella congiuntura, consapevoli del fatto che, come ha scritto Louis Althusser, prendere seriamente questo concetto comporta un azzardo (considerata la mutevolezza che caratterizza la congiuntura) e al tempo stesso richiede di “tener conto di tutte le determinazioni, di tutte le circostanze concrete esistenti, passarle in rassegna, farne il rendiconto e il confronto”.[3] Le circostanze che definiscono la congiuntura in cui si tratta di pensare il capitalismo oggi sono presto riepilogate: da una parte la pandemia da Covid-19, dall’altra parte la guerra in Ucraina. Sono due circostanze che interpellano direttamente la dimensione globale – e la possibilità, dunque, di continuare a parlare di un “capitalismo globale”. La pandemia è stata un’esperienza inaudita, del resto, proprio per via della rapidità quasi istantanea con cui si è diffusa, certo in modo ineguale, nel mondo intero. È stata, lo ha messo ad esempio in evidenza Étienne Balibar, una conferma “sensibile”, ancorché nel segno della malattia e della radicale diseguaglianza, dell’unità della “specie umana”.[4] Nella vulnerabilità di quest’ultima si è come specchiata la vulnerabilità del pianeta, nel tempo dell’antropocene e del capitalocene. Nei suoi effetti, d’altra parte, la pandemia è stata in primo luogo una crisi di mobilità, di cui hanno fatto esperienza (in modi ancora una volta del tutto diversi) popolazioni sedentarie e nomadi. La crisi di mobilità ha investito poi il mondo delle merci, con il blocco o il rallentamento delle “catene di fornitura” (supply chains). Un’esperienza globale come poche altre è così sembrata colpire il cuore della “globalizzazione”, e termini come reshoring e nearshoring si sono ampiamente diffusi, per indicare l’esigenza di una riorganizzazione della geografia della produzione nonché dei circuiti di circolazione e riproduzione.[5]
L’invasione russa dell’Ucraina si è “agganciata” da questo punto di vista alla pandemia, aggiungendo il termine friendshoring (spesso associato allo scontro tra democrazia e autocrazia) a quelli che si sono appena richiamati e aprendo nuove crepe nel sistema globale delle catene di fornitura. Settori strategici, come quello energetico e quello alimentare, ne sono risultati destabilizzati. Le sanzioni occidentali alla Russia hanno ulteriormente contribuito a frammentare lo spazio globale, con effetti non sempre controllabili da parte dei Paesi sanzionatori, come appare ad esempio chiaro per via dell’apertura di nuovi corridoi logistici per aggirarle, ma anche – seguendo l’analisi di Daniel MacDowell – per il paradossale contributo che hanno offerto ai processi in atto di “de-dollarizzazione”.[6] Più in generale, in ogni caso, l’evidente responsabilità russa nella guerra in Ucraina non può precludere non solo la ricerca di altre responsabilità ma soprattutto un’analisi rigorosa delle poste in gioco nell’attuale conflitto. Queste poste in gioco sono necessariamente globali, come dimostra non solo il diretto coinvolgimento degli Stati Uniti ma anche l’obiettivo prioritario che questi ultimi si pongono, ovvero il “contenimento” della Cina in uno scenario che viene spesso descritto nei termini di una “Nuova guerra fredda”. Torneremo più avanti su questo punto. Qui, conviene avanzare in modo diretto la nostra tesi. Mentre la lettura prevalente della pandemia e della guerra in Ucraina insiste, per dirla in breve, sulla “fine della globalizzazione”, a noi pare che in gioco sia oggi piuttosto uno scontro per il controllo degli spazi e dei processi globali. E la guerra è al centro di questo scontro: si tratta di una circostanza che occorre registrare anche dal punto di vista teorico.
2. La fine della globalizzazione è stata proclamata molte volte in questo secolo: dopo l’11 settembre, dopo l’invasione dell’Iraq nel 2003, dopo la grande crisi finanziaria del 2007/8. Si tratta di momenti chiave nella storia recente, in cui si sono prodotti dei cambiamenti la cui profondità siamo ben lungi dal negare. Ci domandiamo però come viene definita la “globalizzazione” di cui periodicamente viene dichiarata la fine. E la nostra impressione è che quel concetto continui a essere in buona misura inteso secondo le coordinate stabilite nei dibattiti degli anni Novanta, quando corrispondeva del resto – durante la Presidenza Clinton – a uno specifico progetto di globalizzazione capitalistica a guida statunitense. La globalizzazione sembrava identificarsi in un insieme di processi lineari, sospinti dalla potenza di “flussi” che avevano la meglio sui “luoghi”, governati da istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. L’egemonia statunitense era assunta come indiscussa, e poteva permettersi di organizzarsi nella cornice del multilateralismo e di guidare azioni di “polizia internazionale” per la difesa e la promozione dei “diritti umani”. Soprattutto, l’elemento chiave della globalizzazione era considerato il commercio, il grado di apertura delle economie dei singoli Paesi (tant’è vero che le trattative per l’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio erano considerate fondamentali in Occidente, salvo ripensamenti successivi). A noi pare che questo concetto di globalizzazione non sia di particolare utilità oggi, e che soprattutto debba essere superato il focus sul grado di apertura al commercio internazionale come criterio privilegiato per “misurarne” la profondità.
Evidentemente, già negli anni Novanta non mancavano analisi che mettevano in evidenza il carattere multidimensionale della globalizzazione. Si possono ad esempio ricordare a questo proposito i lavori di Ulrich Beck e molti contributi allo studio dei processi di globalizzazione “culturale”.[7] Complessivamente, tuttavia, il punto era stabilire l’importanza di dimensioni e dinamiche di cui veniva sottolineata la relativa autonomia, che sembrava oscurata dall’enfasi unilaterale sull’economia (e dal dilagare di quello che appunto Beck chiamava il “globalismo”). Il nostro punto di vista è diverso: riteniamo che la centralità analitica e concettuale del commercio nella definizione della globalizzazione non permetta di cogliere (e anzi oscuri) aspetti economici fondamentali dei processi globali e dunque della continua ridefinizione del capitalismo e del rapporto di capitale. Al concetto di “processi globali” attribuiamo in effetti una certa importanza, fin dai nostri primi lavori e in particolare dal nostro studio del rapporto tra confini territoriali e “frontiere del capitale”.[8] Al contrario della globalizzazione, che indica di per sé un sistema in cui i diversi elementi risultano integrati, i processi globali che privilegiamo nelle nostre ricerche non si combinano necessariamente e possono produrre molteplici attriti tra loro e con eterogenee condizioni politiche, normative e sociali nei luoghi in cui, come ci piace dire, “toccano terra”.[9] Grandi infrastrutture che attraversano i confini, sistemi di distribuzione dell’energia, digitalizzazione, “piattaformizzazione”, logistica, finanza, ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale sono alcuni esempi di processi globali su cui ci soffermiamo, studiandone le coordinate spaziali e gli effetti tanto economici quanto politici. Come mostra in particolare (ma non soltanto) il caso dell’intelligenza artificiale e delle nuove frontiere tecnologiche, non si tratta certo di processi esenti da restrizioni e da vere e proprie guerre commerciali. Resta il fatto che definiscono lo standard attorno a cui il capitalismo si riorganizza su scala globale, con differenze e omogeneità che uniscono e dividono al tempo stesso Paesi come gli Stati Uniti e la Cina.
È da questo punto di vista che pensiamo valga la pena di continuare a parlare di un “capitalismo globale”, per quanto se ne debba innovare il concetto rispetto agli usi più comuni. Capitalismo globale non significa un capitalismo che produce e afferma una sua omogeneità di funzionamento indipendentemente dai luoghi e dalle storie che incontra. Non indica neppure semplicemente una componente del capitalismo che si ritrova ovunque con maggiore o minore presa sull’insieme – o, per usare il linguaggio di Marx, una serie di “frazioni del capitale” diversamente posizionate rispetto al “capitale complessivo”. Capitalismo globale, nel modo in cui lo intendiamo, denota piuttosto la forza dei processi globali che abbiamo richiamato nel trainare la valorizzazione e l’accumulazione del capitale, stabilendone le condizioni e producendo un insieme di effetti che investono la stessa dimensione politica. La “variazione”, per richiamare il lavoro di Jamie Peck e Nick Theodore, è elemento costitutivo delle operazioni del capitale su questa scala globale, e produce un alto grado di eterogeneità (nella composizione del lavoro, in primo luogo) senza per questo fissarsi in specifiche formazioni capitalistiche, chiaramente distinte l’una dall’altra.[10] La nostra proposta è di assumere questa definizione di capitalismo globale come cornice generale per la discussione sulla specificità del capitalismo contemporaneo da cui siamo partiti, e al tempo stesso come criterio di “provincializzazione” dei modelli e delle teorie, sempre da mettere alla prova all’interno di diversi contesti.
3. Farsi carico della dimensione globale del capitalismo contemporaneo richiede del resto, nella turbolenta transizione che stiamo vivendo, una serie di specificazioni ulteriori. È noto che la critica marxiana dell’economia politica assume il “mercato mondiale” come criterio fondamentale per la stessa definizione del capitalismo moderno.[11] Lungi dal rappresentare un’invariante, tuttavia, il mercato mondiale – come è del resto ovvio – muta profondamente nella storia. È sotto questo profilo che ci pare di fondamentale importanza il contributo di storici, sociologi ed economisti come Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi. La “teoria del sistema mondo”, a cui sono solitamente associati, pone infatti in modo rigoroso quello che possiamo chiamare il problema dell’organizzazione politica del mercato mondiale. La prospettiva di Arrighi, in particolare, qualifica questo problema nei termini del rapporto costitutivo che il capitalismo instaura con il “territorialismo”, ovvero con un insieme di potenze territoriali (gli Stati, gli Imperi) che tendono a organizzarsi attorno a un “egemone”, da cui dipende la tenuta complessiva del sistema mondo capitalistico in una data epoca storica. È noto il quadro che ne risulta, ovvero la teoria dei “cicli egemonici” che vede succedersi in posizione apicale la Repubblica di Genova nella sua alleanza con la monarchia spagnola, l’Olanda, la Gran Bretagna e infine gli Stati Uniti.[12] Senza scendere nel dettaglio del modo in cui Arrighi intende la dinamica ciclica delle egemonie, fissiamo un punto importante: nella storia, le “transizioni egemoniche” che hanno scandito lo sviluppo e le trasformazioni del sistema mondo capitalistico si sono sempre determinate attraverso una successione di guerre più o meno devastanti (l’egemonia statunitense, in particolare, si è affermata nel Novecento sulle macerie di due guerre mondiali).
Ci sembra che sia un elemento da tenere presente anche per comprendere quelle che abbiamo in precedenza definito le poste in gioco globali della guerra in Ucraina. In questa prospettiva, è il caso di prendere molto seriamente la diagnosi, che proprio Arrighi ha cominciato a sviluppare negli anni Novanta, di una crisi dell’egemonia globale statunitense come elemento di sfondo delle turbolenze che caratterizzano l’attuale congiuntura a livello mondiale.[13] Parlare di crisi dell’egemonia globale statunitense non significa delineare scenari di “declino”, o negare la persistente potenza economica e ancor più lo strapotere militare degli Stati Uniti. Significa piuttosto assumere, come del resto fanno molti analisti vicini al Dipartimento di Stato, che la capacità di consolidare un fronte occidentale non corrisponde a un’influenza (a una capacità di egemonia) al di fuori del perimetro dell’Occidente. United West, Divided from the Rest (“un Occidente unito, diviso dal resto”) si intitola un rapporto pubblicato nel febbraio del 2023 dallo “European Council on Foreign Relations” sull’atteggiamento delle opinioni pubbliche globali sulla guerra in Ucraina a distanza di un anno dall’invasione russa.[14] È un elemento di ulteriore frammentazione dello spazio globale, anche perché il “resto” di cui qui si parla è tutt’altro che omogeneo. Tuttavia, in questa diversa percezione possiamo vedere riflessi in modo sintomatico una serie di potenti spostamenti nella distribuzione della ricchezza e del potere a livello mondiale, avviati da lungo tempo ma decisamente accelerati dalla grande crisi finanziaria del 2007/8. Un insieme di processi di integrazione regionale, il ruolo dei Paesi “emergenti” (i BRICS e la loro Nuova Banca di Sviluppo), la moltiplicazione di accordi commerciali per denominare gli scambi in valute diverse dal dollaro (quelli, ad esempio, recentemente conclusi dalla Cina con il Bangladesh e l’Argentina) non delineano certo un’organica alternativa al sistema occidentale. Ma disegnano il contorno di un nuovo mondo emergente.
Per definire questo nuovo mondo, Adam Tooze ha proposto la categoria di “multipolarismo centrifugo”.[15] Ci sembra che questa categoria colga bene sia i profondi mutamenti nella distribuzione del potere e della ricchezza di cui abbiamo parlato, sia il tratto tumultuoso e potenzialmente conflittuale della transizione in atto. Più in generale, quello di multipolarismo è un concetto analiticamente importante anche per noi. Lo utilizziamo consapevoli della sua natura controversa, che dipende tra l’altro dall’uso che ne fanno il Presidente russo Putin e intellettuali vicini al suo regime, come ad esempio Aleksandr Dugin.[16] Qui, multipolarismo è un’arma utilizzata per giustificare una politica espansionista e aggressiva, mentre i diversi “poli” sono interpretati come spazi che corrispondono a specifiche “civiltà”, i cui tratti sono definiti in termini schiettamente reazionari (con una ripresa dei lavori di Samuel Huntington sullo “scontro di civiltà”). Se risulta evidente la nostra distanza da questi usi, il modo in cui intendiamo il multipolarismo si differenzia anche dalle variazioni sul linguaggio della “polarità” che caratterizzano discipline come le relazioni internazionali e la geopolitica.[17] Qui – nell’analisi comparativa della stabilità o della propensione al conflitto di sistemi “unipolari”, “bipolari” o “multipolari” – il presupposto che non viene mai messo in discussione è che gli attori esclusivi della politica internazionale siano gli Stati, le “grandi potenze”, gli Imperi. Nella nostra prospettiva, occorre prendere radicalmente le distanze da questo presupposto per pervenire a un concetto di multipolarismo che consenta di cogliere l’insieme dei movimenti e delle sfide di fronte a cui ci troviamo nel tentativo di qualificare il significato della dimensione globale del capitalismo contemporaneo.
4. Un punto di partenza importante per noi consiste nel sottolineare che i “poli” del mondo contemporaneo non sono fissi e neppure costituiti una volta per tutte. La questione essenziale consiste nell’analisi dei processi di formazione dei poli. Si è detto di Stati, “grandi potenze”, imperi. Non neghiamo certo l’importanza di questi attori, e in particolare dei “grandi Stati”, degli Stati che possiamo definire “imperiali”, come ad esempio la Cina e l’India, gli Stati Uniti e la Russia. La loro capacità di regolazione economica (emersa ad esempio con i recenti interventi cinesi sulle grandi imprese high-tech) gioca indubbiamente un ruolo nella formazione dei poli, così come le pressioni esercitate dalla “sicurezza nazionale”. Tuttavia, il mondo multipolare non si organizza esclusivamente attorno a logiche territoriali. In misura diversa nei diversi casi, quelli che abbiamo definito processi globali tagliano trasversalmente i territori definiti in termini sovrani e decentrano il processo di formazione dei poli, rendendo “centrifugo” il multipolarismo anche in un senso diverso rispetto a quello inteso da Tooze. Sono qui attori capitalistici a giocare un ruolo fondamentale, in una prospettiva in cui la logica della valorizzazione del capitale si combina con una razionalità direttamente politica nella produzione di spazi e nel governo di popolazioni. Il rapporto tra capitale e Stato ne risulta profondamente modificato, in forme diverse ma altrettanto intense in diverse regioni del mondo. Tanto la “Belt and Road Initiative” cinese (la “nuova via della seta”) quanto le politiche di comando finanziario statunitense sulla cooperazione per lo sviluppo rappresentano terreni privilegiati per la verifica di questa ipotesi.[18] Se dunque specifici attori capitalistici, con gli “spazi operativi” che costruiscono, rappresentano un secondo essenziale “strato” del processo di formazione dei poli, occorre a nostro giudizio aggiungerne un terzo: ovvero le forme che assumono – dentro e contro quel processo – le lotte e le dinamiche sociali, che contribuiscono a promuovere, rallentare o deviare l’intero processo.
È un primo schema analitico, quello che abbiamo appena presentato. Il nostro auspicio è che contribuisca a segnalare la complessità della formazione e della stessa costituzione dei poli. Dobbiamo aggiungere a questo punto che proprio per via di questa complessità, pur prendendo seriamente la diagnosi di Arrighi a proposito della crisi dell’egemonia globale statunitense, esitiamo rispetto all’idea che quella in corso sia una transizione “egemonica” classica, destinata a concludersi con l’emergere di un nuovo “egemone”, ovvero la Cina. Il rapporto del capitalismo con il “territorialismo” è sempre stato complesso: non certo nel senso che non abbia costruito e non continui a costruire i suoi peculiari ed essenziali rapporti con il “territorio” ma perché questi rapporti seguono una logica diversa da quella moderna della sovranità e dei confini chiusi che definiscono il concetto di territorialismo. Ci sembra tuttavia che oggi questa diversità si sia intensificata fino a un punto di rottura, rendendo particolarmente difficile (per quanto non impossibile) la ricomposizione della logica dell’egemonia. È quel che riconosce, ad esempio, il generale cinese Qiao Liang, autore insieme a Wang Xiangsui alla fine degli anni Novanta di un libro ormai classico, Guerra senza limiti. Con parole semplici, Qiao Liang sottolinea che “l’appiattimento e la decentralizzazione” collegati ai processi di digitalizzazione determinano uno scarto così profondo rispetto al passato che, “da un punto di vista sia soggettivo sia oggettivo, la Cina non può diventare la nuova potenza egemonica dopo gli Stati Uniti”.[19]
Non si tratta ovviamente di assumere queste parole come rappresentative di una presunta “posizione cinese”. Esprimono tuttavia una consapevolezza della profondità della trasformazione in atto nel rapporto tra capitalismo e “territorialismo” di cui non è difficile trovare ampie tracce nel dibattito statunitense – ad empio nelle posizioni dell’autorevole geografo politico John Agnew, che ha recentemente espresso il suo scetticismo rispetto alla prospettiva di una classica transizione egemonica e ha piuttosto sottolineato il potenziale contributo della Cina alla “pluralizzazione” del sistema mondiale.[20] Questi scenari, tuttavia, possono sempre essere forzati in un senso che, in uno scenario mondiale segnato dalla guerra, non possiamo che chiamare imperialistico. Prendiamo la formula, richiamata all’inizio di questo articolo, della “Nuova guerra fredda”. Per molti motivi, ad esempio per il persistente grado di integrazione economica ma anche per lo squilibrio nei rapporti di potenza militare, è evidente che non corrisponde allo stato dei rapporti tra Stati Uniti (o Occidente) e Cina. Tuttavia, può rappresentare un’arma tanto a Washington quanto a Pechino, fino a diventare una profezia che si autoavvera. Per continuare a utilizzare i termini di Arrighi, l’imperialismo oggi non può certo essere letto in modo semplice come malattia senile del territorialismo. Vive piuttosto dell’alleanza tra potenze (o apparati) territoriali e specifici attori capitalistici, che vedono nella guerra una straordinaria occasione di profitto anche a detrimento di altri attori capitalistici. Lottare contro queste tendenze, fermare la guerra è per noi oggi un compito essenziale, che richiede niente meno che l’invenzione di un nuovo internazionalismo. Ma di questo un’altra volta.
[1] Presentiamo in questo articolo alcuni temi sviluppati più sistematicamente in un nostro nuovo libro, The Rest and the West. Capital and Power in a Multipolar World, di prossima pubblicazione per i tipi di Verso (London – New York).
[2] Il riferimento è a un passo contenuto nel poscritto alla seconda edizione del primo libro del Capitale (1873): certo, scrive Marx, “il modo di esporre (Darstellungsweise) un argomento deve distinguersi formalmente dal modo di compiere l’indagine (Forschungsweise). L’indagine deve appropriarsi del materiale nei particolari, deve analizzare le sue differenti forme di sviluppo e deve rintracciarne l’intero concatenamento. Solo dopo che è stato compiuto questo lavoro, il movimento reale può essere esposto in modo conveniente” (K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro primo, Il processo di produzione del capitale, Torino, Einaudi, 1975, p. 18).
[3] L. Althusser, Machiavelli e noi, Roma, Manifestolibri, 1999, p. 36.
[4] É. Balibar, Une monde, une santé, une espèce. Pandémie et cosmopolitique, in Id., Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine, Ecrits III, Paris La Découverte, 2022, pp. 323-362.
[5] Si veda S. Mezzadra e B. Neilson, The Capitalist Virus, in “Politics”, pubblicato online, 11 luglio 2022.
[6] Cfr. D. McDowell, Bucking the Buck: US Financial Sanctions and the International Backlash Against the Dollar, New York, Oxford University Press, 2023.
[7] Cfr. ad esempio U. Beck, Che cos’è la globalizzazione? Rischi e prospettive della società planetaria, Roma, Carocci, 1999; A. Appadurai, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Roma, Meltemi, 2001.
[8] Cfr. S. Mezzadra e B. Neilson, Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, Bologna, il Mulino, 2014.
[9] Cfr. S. Mezzadra e B. Neilson, Operazioni del capitale. Capitalismo contemporaneo tra sfruttamento ed estrazione, Roma, Manifestolibri, 2020.
[10] Si veda J. Peck e N. Theodore, Variegated Capitalism, in “Progress in Human Geography”, 31 (2007), 6: 731-772.
[11] Si veda S. Mezzadra, Into the World Market. Karl Marx and the Theoretical Foundation of Internationalism, in P. Capuzzo e A. Garland Mahler (eds), The Comintern and the Global South. Global Designs/Local Encounters, London – New York, Routledge, 2023, pp. 47-67.
[12] Cfr. G. Arrighi, Adam Smith a Pechino, Milano, Mimesis, 2021.
[13] Cfr. G. Arrighi, Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo, Milano, il Saggiatore, 1996.
[14] Si veda T. Garton Ash, I. Krastev e M. Leonard, United West, Divided from the Rest: Global Public Opinion One Year Into Russia’s War on Ukraine, European Council on Foreign Relations, Policy Brief, February 2023.
[15] A. Tooze, Shutdown: How Covid Shook the World’s Economy, New York, Viking, 2021, 294.
[16] Si veda in particolare A. Dugin, The Theory of a Multipolar World, London, Aktos, 2020.
[17] Cfr. N. Graeger et al. (eds.), Polarity in International Relations. Past, Present, and Future, Cham, Palgrave Macmillan, 2022.
[18] Cfr. ad esempio rispettivamente Ching Kwan Lee, The Specter of Global China, Chicago, IL, University of Chicago Press, 2017 e D. Gabor, The Wall Street Consensus, in “Development and Change”, 52 (2021), 3, pp. 429-459.
[19] Qiao Liang, L’arco dell’impero, Gorizia, Leg, 2021, p. 230.
[20] J. Agnew, Hidden Geopolitics. Governance in a Globalized World, London, Rowman and Littlefield, 2023, pp. 89-90.