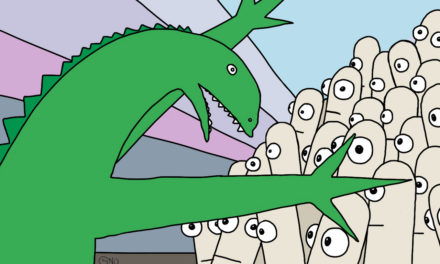Intervento di Toni Negri alla presentazione del volume Il demone della politica di Mario Tronti alla Sorbona, Parigi, 5 aprile 2019.
Di TONI NEGRI.
Debbo confessare il mio imbarazzo nel discutere questo volume di scritti di Mario Tronti, complessivo della sua vita di studioso e militante. Quando ero giovane, non troppo tuttavia, attorno alla trentina, Mario m’insegnò a leggere Marx. Assunse molte responsabilità, facendolo – ed io gliene sono ancora grato. A partire da questa lettura, mi dedicai ad una vita militante. Ma nel 1966, sei o sette anni dopo quell’incipit, consegnandoci Operai e capitale, Mario ci lasciò – non dico “mi” ma “ci”, perché nel frattempo erano divenuti tanti gli “operaisti” presenti non solo nelle università quanto, soprattutto, nelle grandi fabbriche del nord Italia. Ci disse, nel 1966, che il decennio dei Sessanta era finito prima del suo termine e con esso il tempo dell’autonomia operaia, che bisognava trovare un livello più alto per le lotte che avevamo condotto e conducevamo, che bisognava portare la lotta nel Partito comunista italiano. Non era quello che già facevamo? Gli rispondemmo. Non fummo infatti, né allora né più tardi, insensibili al problema ed al compito di sviluppare politicamente le lotte operaie. Il fatto è che il Partito non lo gradiva affatto. Nel crescendo delle lotte operaia che doveva condurci al ‘68/‘69, non capimmo dunque perché lasciare a se stessa l’autonomia delle lotte. Mario disse allora che il ‘68 ci aveva definitivamente confuso. Secondo lui, avevamo preso per un’alba quello che invece era un tramonto. Ma quale tramonto? Certo, si annunciava la fine dell’egemonia dell’operaio-massa ma potevamo confonderla con quella della lotta di classe proletaria? Nel prolungarsi durante tutti gli anni ‘70 del lungo ‘68 italiano, quella conversione di Mario non poteva convincerci. Fu allora che smisi di leggere Tronti. Quando questo volume mi arrivò, mi accorsi che ne avevo già letto solo il primo terzo, due terzi mi restavano da leggere.
Certo, anche se non lo leggevo, Tronti non era assente dal mio quotidiano. In maniera stizzosa, ad esempio, lessi in quegli anni un saggio di storia del pensiero politico moderno che Mario pubblicò allora e che, ad uno spinozista quale stavo diventando, parve parziale e non certo grato nell’esaltazione senza riserve che ivi era fatta della teoria hobbesiana del potere. Come se la storia del politico moderno non dovesse essere attraversata anche dal pensiero e dalla storia dei vinti, dalla linea della rivolta, dal sogno comunista, fino a rappresentarsi in Marx come critica dell’economia politica e potenza di soggettivazione classista. A questa figura della storia del moderno ero profondamente legato e da Operai e capitale avevo appunto appreso ad inseguire la “storia interna della classe operaia” – la storia cioè della sua progressiva soggettivazione. Facevo ciò sviluppando l’intuizione trontiana che indicava il punto nel quale la soggettivazione della forza-lavoro era maturata al punto di “contare veramente due volte dentro al sistema di capitale: una volta come forza che produce capitale, un’altra volta come forza che rifiuta di produrlo; una volta dentro il capitale, una volta contro il capitale” (Operai e capitale, p. 180). Perché allora, mi chiedevo, Mario dimentica nel lavoro storico la lotta contro il capitale ed il soggettivarsi potente del proletariato?
Poi ancora, in quegli anni, mi arrabbiai quando Cacciari ed Asor Rosa, sulla linea di Mario, attaccarono Foucault perché – dicevano – dissolveva lo Stato, oggetto e soggetto della loro concezione del politico. Fu allora che, probabilmente per la prima volta, in maniera piena, mi accorsi che il terreno politico scelto dai miei vecchi compagni era dato esclusivamente come apparato statale ed era staccato, separato radicalmente dal livello della lotta di classe. Che incredibile limitazione anche dal punto di vista offertoci da Foucault, il cui concetto di potere risonava talmente del dualismo del marxiano concetto di capitale!
Più recentemente, poi, mi domandai perplesso che cosa significasse operaismo, essendomi sentito chiamare “post-operaista”, quando invece avevo assunto come compito teorico, quello di espandere i dispositivi metodici e le intuizioni politiche del “grezzo” operaismo anni ‘60 nell’analisi della trasformazione delle composizione delle classi e della lotta di classe a livello internazionale. Ci tenevo molto, sul mercato globale del sapere, ad essere qualificato come “operaista”: non mi vergogno di dirlo e con piacere lasciavo il “post-” a chi davvero se n’era andato da un’altra parte. Ero certo “minoritario” ma, come spesso capita ai minoritari, sentivo che presto le opzioni partitiche statualiste di quelli che veramente venivano dopo gli (post-)operaisti, si sarebbero infrante nel rinascere della lotta di classe.
Tuttavia, per evitare arrabbiature sempre più frequenti, mi dissi infine: bisogna che vada a sentire di nuovo Mario. Ero in galera e Mario teneva, nel 2001, la lezione conclusiva della sua carriera accademica a Siena. Chiesi un permesso ai carcerieri e sorprendentemente me lo concessero. Rivedevo Siena dopo tanti anni di esilio, cosa non estranea alla mia richiesta di ascoltare Mario. “Politica e destino” si chiamò la lectio di Mario. Mi accorsi allora di quanto fossimo divenuti estranei. Conoscevo bene Freiheit und Schicksal (“Libertà e destino”), il testo del giovane Hegel, già tradotto ed interpretato in Italia da Luporini, che Mario assumeva come spunto del suo studio – ci avevo lavorato nella mia tesi di libera docenza. Ebbene, che cosa avveniva a quel testo fortemente repubblicano del giovane Hegel nella lettura di Mario? Egli operava uno scivolamento inaudito dalla Bestimmung hegeliana al Geschick heideggeriano, dalla determinazione etico-politica di Hegel e dal suo affidamento rivoluzionario alla Begeisterung popolare – da ciò dunque – alla decisione heideggeriana “dell’abbandono (dell’ente) nell’essere”. Ma perché questo passaggio? Come poteva giocarsi lo spostamento dall’entusiasmo hegeliano alla mortale riflessione heideggeriana? La risposta si rivelava essere fortemente metaforica. Era qui detta come presa di coscienza della definitiva crisi di un destino politico giocato interamente sull’appartenenza al Partito. Ma ora, nel 2001, non c’è più il Partito. Perché? Metaforicamente rispondeva dunque Mario a quella domanda: “Perché non c’è più popolo!” (Il demone della politica, p. 577). Era quindi caduta la “vocazione”, “il compito di organizzarci come classe dirigente, egemonicamente dominante”.
Mi chiesi allora: ma che cos’è questa mitologia egemonica che fa reagire Mario in maniera tanto drammatica e – a mio avviso – tanto disastrosa, dinnanzi al presente della lotta di classe? Ecco qui l’“enigma Tronti” – che non mi sembra impossibile da svelare: consiste nella dislocazione del “punto di vista” dal dentro/contro il capitale, al dentro al Partito con la proposta di imporne l’egemonia sullo sviluppo capitalista; nella discontinuità profonda fra il Tronti di Operai e capitale e quello dell’“autonomia del politico”. In parole povere, uno spostare dal basso all’alto la sorgente del potere e l’iniziativa della lotta di classe.
Nel 1972 era apparso in gran luce il concetto di “autonomia del politico”, in uno scritto così intitolato. Non era più il residuo di una tradizione storica, della memoria di Hobbes. Il concetto si organizza piuttosto sull’idea che bisognava finirla con il “monoteismo” marxiano, e cioè con la pretesa che critica dell’economia politica e critica della politica potessero avere la medesima sorgente. Si trattava invece, secondo Mario, di due pratiche critiche diverse. Politicamente questa duplicazione era giustificata – in maniera non del tutto paradossale – dall’idea che, negli anni ‘70, il capitalismo avesse dimostrato di essere insufficiente a sostenere lo Stato moderno, e cioè lo sviluppo capitalista nella forma dello Stato moderno. Ma se il capitalismo è in ritardo, è la politica che deve scuoterlo. Occorre sollecitare il politico a modernizzare lo Stato. Ma “politica” è oggi solo la forza della classe organizzata nel Partito. A chi dunque il compito di modernizzare lo Stato? Alla “classe operaia [che] risulta in questa chiave la sola vera razionalità dello Stato moderno” (DdP, p. 297). Qui il paradosso è pieno.
“Classe operaia come razionalità dello Stato moderno”: l’affermazione è ardua da giustificare sia nei confronti dell’operaismo “grezzo” dei primi anni ’60, sia guardando più avanti, al destino della classe come a quello dello Stato moderno. Ché, nel primo caso, la razionalità operaista aveva rappresentato l’opposto di una funzione progressiva dello sviluppo capitalista; se essa lo causava, lo faceva in quanto agente antagonista; in nessun caso come agente strumentale, tantomeno come funzione razionale. Nel secondo caso, guardando in avanti, e cioè allo sviluppo della dialettica lotta di classe/Stato, quel che si può dire è che, nei successivi decenni, essa si è esaurita nella forma metaforizzata da Tronti – nel senso che la classe, quando essa agisca come forza antagonista e propulsiva del capitale, non sarà mai più rappresentata dal Partito.
Ma torniamo a noi, al 1972. Tronti riconosce che tale autonomia del politico possa essere presa come progetto politico direttamente capitalistico. In questo caso, concede, essa risulterebbe come l’ultima delle ideologie borghesi. Tuttavia, essa può, oggi, anni ‘70, essere ancora realizzabile come rivendicazione operaia. “Lo Stato moderno risulta, a questo punto, niente meno che la moderna forma di organizzazione autonoma della classe operaia” (p. 298). Il rapporto è perfezionato una decina d’anni dopo, nell’epoca di Berlinguer, quando si comincia a parlare del “compromesso storico”. Dico perfezionato perché accompagnato da un’ulteriore sottovalutazione del ruolo rivoluzionario della classe operaia. Detto teoricamente da Mario: “La classe operaia, sulla base della lotta dentro il rapporto di produzione, può vincere solo occasionalmente; strategicamente non vince, strategicamente è classe, in ogni caso dominata; ma se non gioca semplicemente sul terreno di classe, se spariglia ed assume il terreno politico, si determinano momenti in cui il processo del dominio capitalistico può esser rovesciato”. Ecco, radicalmente compiuta, la rottura con l’operaismo anni ’60.
Nella discussione (quel testo sull’autonomia del politico è elaborato in una discussione) la tesi viene attenuata, si reintroduce talvolta il rapporto dualistico di capitale teorizzato in Operai e capitale: “Non c’è mai all’interno della società capitalista un dominio di classe univoco” (p. 305). Immagino – siamo nel ‘72 – che gli interlocutori ricordassero a Mario l’intensità delle lotte in corso. Ed ecco come Tronti reagisce: “Uno sviluppo capitalistico di questo tipo non può marciare se non elimina difronte a sé questo apparato statuale che non corrisponde più al livello attuale dello sviluppo economico capitalistico. Questa è la previsione che noi facciamo” (p. 307). Su questo Mario ha senz’altro ragione: è il momento nel quale il capitale si apre alla riorganizzazione globale della sovranità. Ma questa volta la “grande politica” gli sfugge. Assai ingenuamente infatti Tronti pensa ancora che si tratti di operazioni interne al tessuto dello Stato-nazione ed ingenuamente aggiunge: “Quando il capitale decide di spostare la sua azione su quel terreno [sott’intende ancora, evidentemente, il tema della riforma dello Stato], l’intero gioco della lotta di classe si sposta anch’esso, fatalmente su quel terreno. Secondo me, si tratta addirittura di anticipare la stessa mossa capitalista su questo terreno, affrontando il tema della strozzatura politica e quindi della riforma dell’assetto statuale prima ancora che il capitale ne prenda coscienza ed elabori un progetto di effettiva e concreta realizzazione di questa riforma. Così, il processo, io non direi di riforma ma di rivoluzione politica dello Stato capitalistico così com’è, è un progetto che la classe operaia deve anticipare” (p. 307). Ed ecco la rivendicazione dello strumento dell’autonomia del politico: “Noi troviamo un livello del movimento operaio, cioè un’organizzazione storica del movimento operaio, disponibile per un’azione di questo tipo” (p. 309). E ancora: “Noi ci troviamo difronte, per un progetto di questo tipo, a degli strumenti organizzativi che per una politica passata, per una loro struttura interna, sono disponibili per un’azione di questo tipo. È una situazione storica paradossale ma è un paradosso da utilizzare” (p. 309). Si potrebbe irridere a questo presunto “realismo politico”, ma a che scopo, quando si sia misurato, come a noi è oggi possibile, l’idealismo che lo sorreggeva?
La classe deve farsi Stato: questa è dunque l’“autonomia del politico” così come essa appare di nuovo ne Il tempo della politica del 1980. Il testo è interessante. C’è una certa autocritica a proposito della condanna del ‘68. Si rivendica ad esempio la matrice operaia del ’68, si afferma persino che prima del ’68 c’è un ciclo di lotte operaie vittorioso, a livello europeo ed internazionale, che lo preparava. Tronti esemplifica sul “caso italiano”, sull’insieme dei processi che avevano portato gli operai in lotta ad uscire dalle fabbriche. Apre persino ad una prima definizione del “sociale” come nuovo terreno della lotta di classe. Ed impreca contro l’incapacità del Partito di assorbire e/o di dialettizarsi con i nuovi movimenti: “Lentezza di riflessi, paura del nuovo, istinto di autodifesa” (vedi pp. 382-390).
Ma poi, come se niente fosse, riprende l’insistenza sul Partito come chiave di ogni processo. Quello che è letteralmente insopportabile è che tutto questo discorso si dà ormai a partire dalla cancellazione di ogni approccio critico all’economia politica e sostenendosi su un volontarismo bizzarro. “Rosenzweig indicava una prospettiva di lettura della politica moderna, von Hegel zu Bismarck. È possibile tirare oltre la linea e continuare il discorso e rimescolare le carte, von Bismarck zu Lenin? Può scandalizzarsi solo chi non ha spirito di ricerca, chi ha paura di sporcarsi le idee manovrando le pratiche del nemico, chi pensa in piccolo, per linee di coerenza ideologica e non sulla base della produttività politica di una scelta teorica” (p. 408). Può essere. Ma io vi ricordo che, dopo aver assaggiato quel passaggio attraverso Bismarck, Rosenzweig aveva concluso alla mistica Stern der Erlösung (“La stella della redenzione”). Non si offenderà Tronti perché è lo stesso cammino che egli farà.
Ci ritorneremo. Ma ora seguiamo ancora il tema dell’autonomia del politico. 1998, un altro importante documento: Politica Storia Novecento. “Si chiude la fase dell’autonomia del politico”, dichiara qui Tronti (p. 524). Perché si chiude la fase dell’autonomia del politico? Perché “la sconfitta del movimento operaio [siamo nel 1998] si mostra senza un seguito di possibile riscossa” (p. 325). Ed ecco la sequenza-fuga: “La classe operaia non è morta […] ma è morto il movimento operaio. E la lotta di classe non c’era perché c’era la classe operaia, la lotta di classe c’era perché c’era il movimento operaio” (p. 528). Dopo la subordinazione della lotta di classe all’autonomia del politico, con la fine del PCI finisce anche la lotta di classe. Come dunque volevasi dimostrare, posso aggiungere. E proporre un’ulteriore risposta alla domanda sulla fine dell’autonomia del politico: perché la linea del pensiero di Tronti va da ogni errore politico ad una trasfigurazione trascendentale di questo (dal fallimento del “Partito in fabbrica” all’idea dell’“autonomia del politico”, dalla crisi del ’68 all’affermazione della classe come Stato, dal fallimento del compromesso storico alla teologia politica) in una fuga in avanti che non ha termine.
Ci concede Tronti che restino le rivolte dei subordinati… “nel loro corso eterno” (p. 529). Come volevasi dimostrare, il discorso va ora all’eterno (vedi ancora pp. 530-534). “Il Dio che si fa uomo e l’uomo che si fa Dio non si sono alla fine incontrati… e l’XI delle tesi di Marx su Feuerbach (“Finora i filosofi si sono limitati ad interpretare il mondo, adesso è venuto il momento di cambiarlo”) va pesantemente messa in dubbio… cade il dogma della prassi”. È finito il PCI, è finita ogni politica rivoluzionaria. Ma anche progressista o riformista. Se non fosse tanto urlata, questa convinzione potrebbe darsi in una luce crepuscolare e ordinare insieme la nostalgia (quante volte richiamata) del “popolo comunista” e il senso di tempi nuovi incomprensibili. Un’aura pasoliniana.
Nello scritto Karl und Carl (pp. 549-560) ritorna il discorso sull’autonomia del politico, ma sublimato. Tronti ce lo dà come “l’ultima cosa che resta”. L’autonomia del politico, cioè, non più collegata alla storia del movimento operaio o alla sua politica ma qui finalmente data come fatto ontologico, come necessità del pensiero, della vita e della convivenza umana. Non è più un modo ma un attributo dell’essere: si potrebbe dire ironicamente. Tronti riconosce che “l’ingenua occasione dell’incontro” con Schmitt fu all’inizio, per gli operaisti che nel ‘70 entravano nel PCI, prodotta “dall’ambizione pratica di carpire a Schmitt il segreto dell’autonomia del politico per consegnarlo come arma offensiva al Partito della classe operaia” (p. 556). Ciò conferma, appunto, la nostra ipotesi precedentemente espressa. Ma bisognava, aggiunge Tronti, andare oltre la contingenza. Bisognava riconoscere che si era fatto un passaggio strategico, assumendo da Schmitt il pensiero “dell’originarietà del politico, della politica come potenza originaria” (nelle parole stesse di Schmitt). La logica non poteva essere più consequenziale. Si era costruito un nuovo monoteismo opposto a quello denunciato in Marx.
Che dire del resto di questo libro? Che spesso confonde il giudizio politico sulla realtà presente dentro risonanze spirituali, teologiche e trascendentali. Il potere si destoricizza definitivamente. Subentra intero il teologico-politico. Il senso del religioso viene assunto come tonalità di un nichilismo conseguente alla dichiarazione della fine del linguaggio politico moderno e del suo mondo – fine contemporanea all’esaurirsi XX secolo. Siamo dinnanzi ad una precipitazione catastrofica, inarrestabile. Ormai tutto è uguale, e l’unica funzione del pensiero politico non può essere che quella katekhontica: di bloccare, di disaccelerare quella precipitazione.
Mi spiace sinceramente che l’originario tentativo di Operai e capitale di riconquistare il politico attraverso la soggettivazione dell’attore proletario nella lotta di classe, termini in una triste commiserazione dell’umana “virtù”. Questa si era incrociata alla “fortuna” e così, nel Partito, potevamo non solo salvarci dalla rovina ma costruire un nuovo mondo. Ma venuta meno la “fortuna”, anche ogni “virtù” decade. Come è poco machiavellico questo destino. Nell’opera machiavellica quella “fortuna” che scompare è comunque portatrice, nella sua latenza, di nuova “virtù”. Tale è oggi la situazione. Ed un pensiero geneticamente robusto come quello di Tronti non avrebbe dovuto perdere la capacità di avvertirlo: la fine del Partito registra sì la fine di un’epoca ma segnala la nascita di nuove soggettivazioni.
Lamentare la sconfitta produce una oziosa rinnovata fuga metafisica – è invece necessario un faticoso ma positivo ripiegamento sulla critica dell’economia politica, una nuova interrogazione sulla “composizione” tecnica e politica della classe lavoratrice che, su queste contingenze, viene costituendosi in nuove figure. Come si sono modificati la forza-lavoro ed il capitale variabile nel loro rapporto al capitale fisso, dentro le trasformazioni del modo di produrre capitalista e nel passaggio dalla fase industriale a quella post-industriale? Che cos’è quell’“intellettualità” che costituisce la nuova moltitudine di lavoratori e quali le forme del suo essere produttiva? E la nuova centralità della cooperazione lavorativa, la sua aumentata intensità nel lavoro immateriale, cognitivo, in rete, ecc., questa trasversalità potente, quali conseguenze determina? Se l’“operaio sociale” diviene “lavoratore cognitivo” ed innesta sulle qualità del primo (mobilità e flessibilità) cooperazione linguistica e tecnologica, in che maniera si possono configurare il rapporto ed il salto da composizione tecnica a composizione politica del nuovo proletariato? Se è vero che all’interno di questo tumulto trasformativo la sola cosa che non si modifica, è che il capitale vive di plus-lavoro e continuamente riconfigura plus-valore e profitto al suo interno, quel rapporto tra composizione tecnica e politica è possibile, è un dispositivo latente da sviluppare ed un compito da farsi.
Quel che è certo è che l’operaismo va aggiornato, e può esserlo, quando la socializzazione produttiva e l’operare cognitivo investono l’accumulazione e la vita intera. Non a caso, nella riproduzione sociale, nella vita, i movimenti femministi divengono centrali. Non solo: il punto di vista dei “subordinati” rivela interamente la sua connessione con i movimenti di classe. Non si poteva riattualizzare qui, nelle nuove lotte di questi soggetti, quel punto di vista che aveva creato l’operaismo – quel vedere ogni sviluppo storico della lotta per la liberazione dal lavoro “dal basso”, dalla lotta di classe degli sfruttati? E quindi la capacità di dare a questo punto di vista un’intensità biopolitica ed un’estensione universale? Non accade che, dopo la fine della centralità della fabbrica, la lotta di classe riconquisti qui, interamente, la sua virtualità rivoluzionaria?
Arresto qui le domande e suggerisco quello che, a partire da quell’inchiesta sulla nuova composizione tecnica del proletariato, si può ricavare per l’ipotesi di una nuova composizione politica. Essa può darsi quando, riconoscendo l’eccedenza produttiva del lavoro cooperativo e/o cognitivo che caratterizza la nuova accumulazione, la classe lavoratrice si rivolta e si mostra capace di reggere nel tempo la rottura del rapporto di produzione, di costruire contropotere e di istituire in tal modo legittimità costituente. Qui il nome del politico si riaggancia a quello del produrre, non in senso economicista ma nel senso che le lotte hanno costruito, come libera capacità di produrre e comandare sulla vita.
Per finire. Un punto fortemente polemico nei confronti di Mario. Diversamente da quanto egli sostiene, in ogni momento nel quale articola la sua teoria del politico e/o del potere, Lenin non ha nulla a che fare con l’autonomia del politico. Perché Lenin fu, appunto, monoteista, ma in senso opposto a quello schmittiano, ricavando da Marx anche l’idea del politico che, nella materia, consisteva essenzialmente nella proiezione massificata del lavoro vivo; nella forma, nell’organizzazione di partito ricalcata sulla fabbrica operaia, sulla comunità produttiva; nel progetto, in un’impresa rivoluzionaria di costruzione del comune. Non c’è, in Lenin, modo di staccare la materia dalla forma. Il riferimento qui spesso fatto alla NEP, per mostrarci il realismo opportunista di Lenin, introduce alle politiche staliniane che seguiranno, piuttosto che al modello politico leninista, dove dominano il tema dell’estinzione dello Stato, di una transizione come fase di riappropriazione e trasformazione da parte del proletariato dei poteri dello Stato, e la volontà di creare una società senza classi. È ben vero che Tronti attenua, avanzando nella sua distruzione della tradizione comunista, quest’assegnazione di Lenin all’autonomia del politico. L’autocritica trontiana (fosse tale! Si presenta invece sempre come superiore potenza di verità) – l’autocritica sembra cambiare terreno. La mitologia dopo la teoria, l’ascesi dopo la mistica: “Il marxismo del XX secolo, nella forma del leninismo, è molto filosofia della mitologia”. Benvenuta comunque questa modificazione. Estremamente pericoloso era avanzare sull’idea di un Lenin dedito all’autonomia del politico poiché in ciò è implicito un forte accento di revisionismo storico. Dopo Lenin uguale a Bismarck, viene Lenin uguale a Hitler, idea del tutto accettabile per Schmitt – ma da noi davvero no.
Il riferimento al trascendentale politico, tipico della patologia statalista novecentesca, Ahi, quali lutti addusse agli Achei!, ha d’altronde fatto il suo tempo. Nel mondo globalizzato, ogni reminiscenza statalista è destinata a piegarsi al sovranismo, all’identitarismo, e rinnova derive fasciste, mentre la figura dello Stato impallidisce nel contesto della globalizzazione. Ben lungi dal riapparire come soggetto autonomo, lo Stato assume un ruolo subordinato nel “gioco globale del tasso di profitto”. Come dicono altri compagni tutt’ora operaisti: “Sicché si può ben concludere che lo Stato non è oggi sufficientemente potente nei confronti del capitalismo contemporaneo. Al fine di riaprire una prospettiva politica di trasformazione radicale è assolutamente necessario qualcosa d’altro, una differente sorgente di potere” (Mezzadra-Nielson, The Operations). Ecco dove la prospettiva operaista, quella che Tronti ci ha regalato e che da parecchio tempo rifiuta, può aiutarci. Se la mia lettura del volume si ferma dunque al suo primo terzo, non è detto che proprio di lì, da quel primo terzo, non si possa nuovamente procedere alla scoperta del politico marxiano.