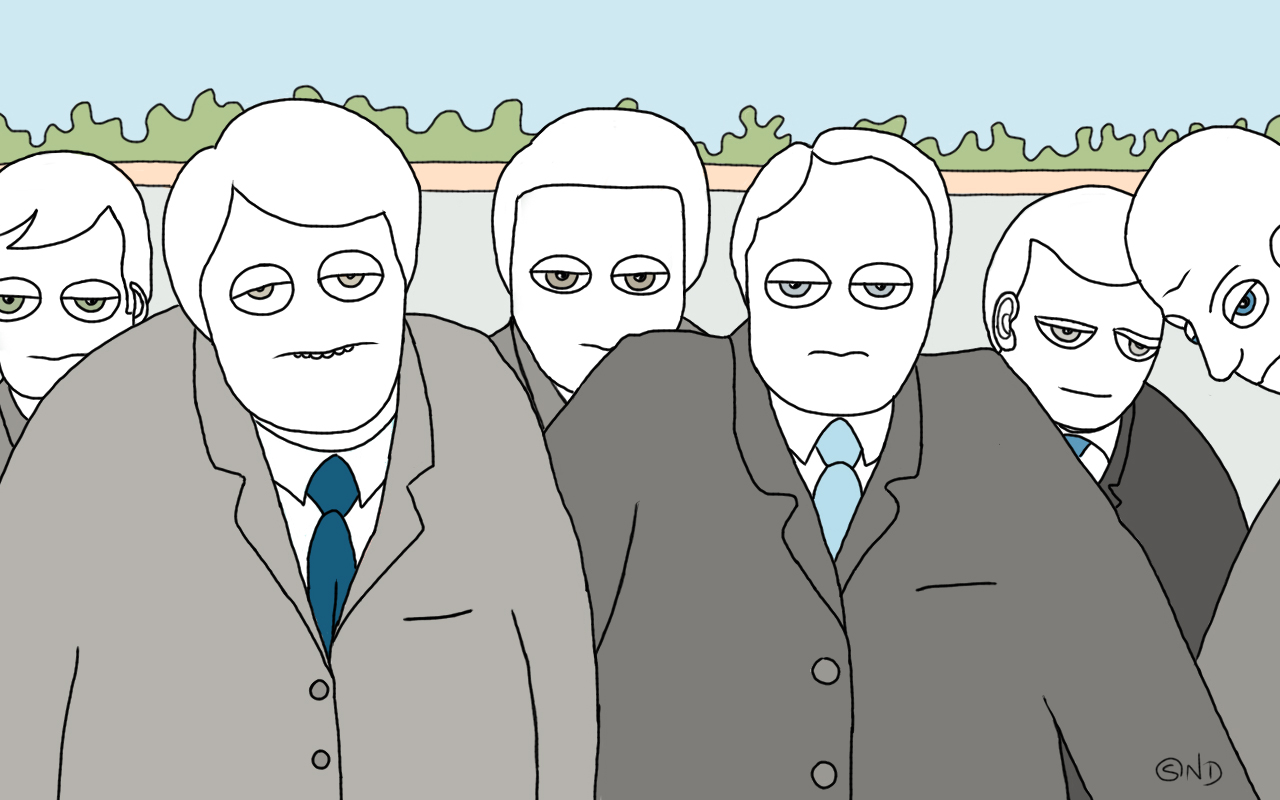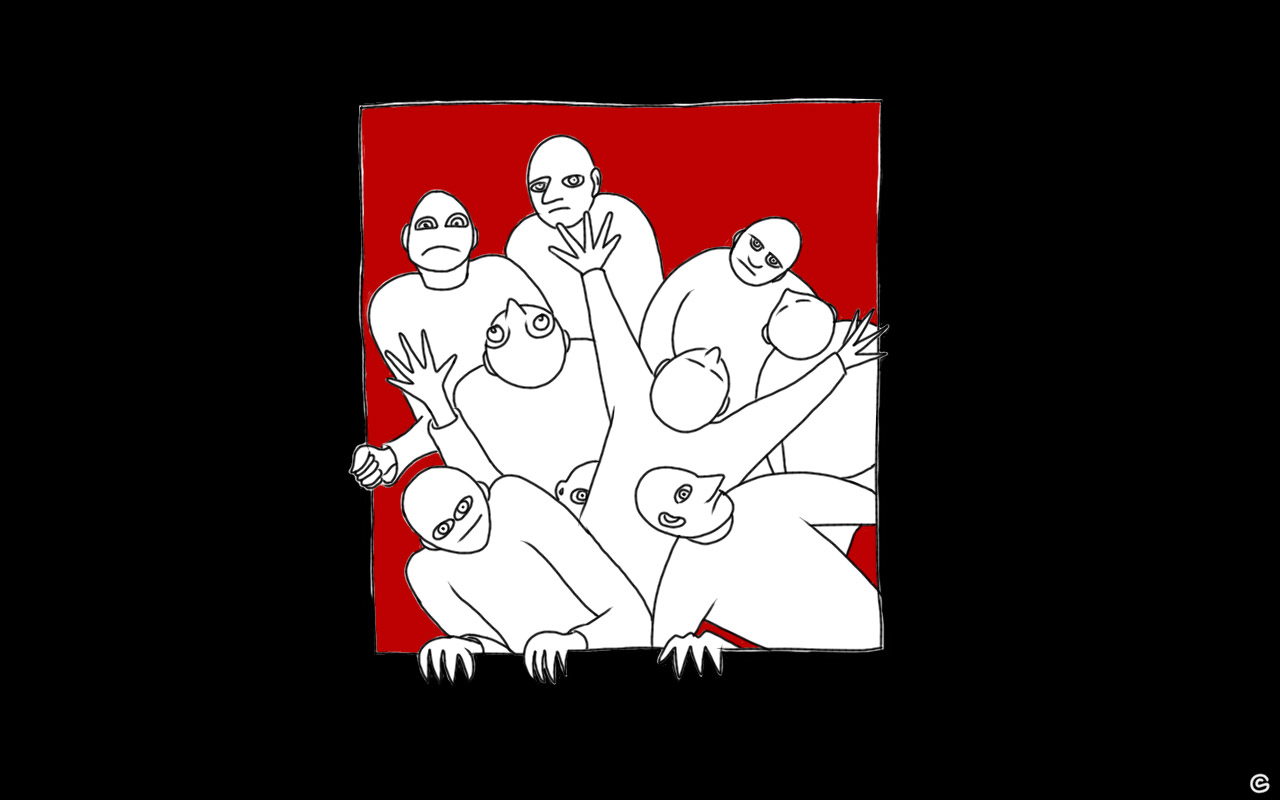di FANT PRECARIO.
1. È notizia di qualche giorno fa che la Corte d’Appello di Tolosa, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto privo di causa [(reale, e seria) perché senza fondamento economico)] il licenziamento di 191 dipendenti da parte di Molex, condannata al pagamento di “un’indennità” di 7 milioni di euro, che – ci avverte L’Humanitè – saranno corrisposti da un fondo pubblico, l’Assurance de garantie de salaires: (i) a parte l’ovvia, ma sempre efficace, considerazione che il capitale privatizza i profitti e socializza le perdite, (ii) a parte che non si hanno notizie sulla solidità patrimoniale e finanziaria della (già) datrice di lavoro e della possibilità di recupero della somma, (iii) quello che risalta è l’esiguità della somma rispetto al rilievo dato alla notizia; secondo i padroni si tratterebbe di condanna (oltreché ingiusta in quanto limitativa della libertà di impresa) esorbitante, i sindacati, tronfi d’ottusità, confermano la natura esemplare della condanna.
Abituati, quantomeno dai tempi di Lama a non credere ai sindacati (da sempre ai padroni) facciamo qualche conto. Ecco i numeri: 8 anni di lotta giudiziaria (il che la dice lunga sul potenziale scarsissimo del ricorso alle toghe, più o meno rosse), 191 esseri umani sul lastrico, 7.000.000 di euro di indennizzo. Pensando ad una debenza netta, senza considerazione di costi, prebende avvocatizie/sindacali, oneri vari, appoggiando le matita sull’orecchio come il salumaio, diciamo: fanno € 4.581 annui per ciascun lavoratore, lascio?
Più o meno il denaro che un imprenditore spende in 1 giorno per annaffiare i tartufi nel Bordeaux (riprendendo la soave lirica di Spartacus Picenus). 7 milioni sono anche l’abituale passivo che regista il fallimento di una società di piccole dimensioni, il buco che qualsiasi (nel senso di non particolarmente rilevante o non fortunosamente “amico” del ceto bancario) imprenditore lascia all’erario o alla banca di “riferimento” quando trasmigra le proprie fortune da una bad a una good company.
Dico questo per evidenziare (i) la minima rilevanza del lavoro salariato nell’attuale sistema di produzione, (ii) l’inconsistenza di qualsiasi lotta in chiave difensiva, (iii) la stupidità di fondare una repubblica sul lavoro. Lo dico, altresì, in quanto il dato chiarisce meglio di tanti studi specialistici il rivolgersi del capitale alla finanza, alla possibilità, cioè, di creare -attraverso l’indebitamento (reale) e il credito (fittizio)- denaro dal nulla.
Se (x) il parametro di valutazione del lavoro di otto anni di 191 operai è quello trionfalmente assunto dall’appello tolosano, (y) l’accesso al credito di un qualsiasi imprenditore è pressoché pari, senza che neppure abbia intrapreso alcunché, ma, unicamente steso, in uno a magistrali consulenti, una simpatica brochure, perché a) affidarsi all’economia reale che ristagna su quei livelli risibili? b) insistere sulla produzione di merce a mezzo di esseri umani singolarmente assunti? c) combattere per preservare tutto ciò? Possiamo però arrivare a una prima conclusione: un anno di vita di un operaio che vince vale meno di 5000 euro [figurarsi se perde (che è poi la maggioranza dei casi)].
2. Quando arrivò la grande crisi vi fu chi disse, con tutta probabilità a ragione, che le banche italiane erano solide e nulla avevano a temere, poiché meno legate all’incipiente finanziarizzazione (più “vecchie”, o meglio “tradizionali”, poiché legate alla funzione “tipica” di istituto di credito), e quindi meno appesantite dai derivati [la cosa poteva essere letta in vari modi, sia in chiave rassicurante (basti pensare che la Camera di Commercio, coevamente, asseriva che la Liguria era meno toccata dalla “crisi” rispetto ad altre regioni in quanto da anni ormai “in crisi”) sia in chiave di arretratezza culturale]. Sta di fatto che né la “spazzatura” iniettata nel corpo bancario né la fattispecie subprime parevano tanto incidenti sui destini delle banche tricolori.
Subito, vi fu chi lamentò uno scollamento tra finanza ed economia reale, criticando (con trent’anni di ritardo, comunque) la scelta del profitto di farsi rendita, chi invece affermò l’ormai definitiva ristrutturazione capitalistica nel senso della finanziarizzazione e la necessità di procedere ad una, eventuale, critica da quel dato ormai consolidato.
Le misure, in tutto il mondo, si sono susseguite senza sosta né risultati; si è cercato di regolamentare il mercato, di istruire il cliente, di condannare l’agire bancario anche laddove ingenerava un’ebbrezza da accesso al credito (l’ubriaco da indebitamento, che così andava a sostituire l’operaio avvinazzato che transitava direttamente dalla catena all’osteria, per poi tornare a casa e giù mazzate alla moglie, ma questo non è cambiato).
3. Vero quanto affermato da un Silvio che ormai aveva imboccato la parabola discendente, ciononostante le banche italiane sono scoppiate. Le sofferenze hanno superano ormai quota 200 miliardi di euro (i 7 milioni degli operai francesi fanno tenerezza) e non sono da addebitarsi ai “feroci” ed “esotici” derivati tantomeno alla modalità di erogazione subprime.
Le banche italiane non hanno erogato a soggetti poco affidabili, non hanno errato nella valutazione del merito creditizio, né sulla convinzione – poi venuta meno per colpa del destino cinico e baro – di un costante aumento del valore dei cespiti cauzionali. Le banche italiane hanno affidato fior di imprenditori che comunque si sono rivelati “cattivi” (pessimi, e in mala fede, ma questa è la conclusione del discorso, non l’avvio) pagatori. Non sono le banche che hanno fatto “crack” (come il pinguino innamorato) è l’impresa – in quanto tale – che si è rivelata inidonea a restituire quanto mutuato.
Il fatto è che tale inidoneità non è addebitabile al singolo imprenditore (anche perché una certa percentuale di sofferenze è fisiologica, e tale percentuale è altrettanto giustificatamente incrementata dalla crisi) ma al fatto che la frana è del capitale, laddove assunse – a schermo dell’opzione finanziaria – lo statuto dell’impresa quale fondamento delle proprie tante finte riforme (finte nel senso che non riformavano, limitandosi ad erodere i diritti di lavoratori estinti per insipienza socialdemocratica a superare la sacra trinità “produci consuma crepa”.
4. L’impresa è – attualmente – soggetto che agisce (deve agire) in perdita, questo è il dato che emerge dalle vicende più recenti. Non può darsi impresa produttiva, perché non è quello lo scopo per cui essa è stata posta all’interno di un sistema di appropriazione finanziaria.
La scelta è stata quella di distruggere il capitalismo industriale per sconfiggere il movimento operaio, anche e soprattutto attraverso la favola che potesse esistere “un’altra” impresa (fa venire in mente un po’ il vecchio adagio un altro mondo è possibile, non vi pare?), quella che, libera da lacci e laccioli potesse generare profitto. Ed allora, ecco un proliferare di uomini/impresa, PMI fai da te, start up di ogni livello e grado, tutte unite nella certezza della passività gestionale.
Perché è dal tracollo dell’impresa che si genera la rendita, non il profitto dal successo commerciale. E in questo le banche hanno fatto la loro parte; istruite le “pratiche” con dovizia di particolari, ossequiose delle istruzioni della Banca d’Italia e della BCE, ligie a tutte le basilee, hanno erogato denari per favolose operazioni (il più delle volte immobiliari, e per questo maggiormente garantite, direbbero i manuali) finite nel nulla della produzione di cose inutili (come i mirabili condomini che affliggono la nostra costa, o i futuristici centri commerciali, che altrove s’iniziano a dismettere).
L’impresa deve fallire e le banche debbono erogare (the show must go on, per dirla con i Queen, ma anche e prima con Leo Sayer), pur coscienti della circostanza, per fallire a loro volta, o essere salvate da altri, destinati pur essi a fallire; come Atlante, la banca, perdendosi, regge il mondo dell’impresa-cialtrona, giustificazione del capitale-cialtrone che trae denaro (e consenso, non lo si dimentichi) non dalla produzione ma dalla distruzione di vita che sta dietro ad ogni fallimento.
5. Siamo giunti al nodo irrisolto. Il lavoro salariato (non più e non solo, ma anche coattivo, gratuito, implorato, exposizzato) non serve a nulla, come non serve a nulla la produzione di merci, laddove svincolata dalla possibilità di succhiare la vita del lavoratore. La rendita è espropriazione di qualcosa che trascende le mille ore sprecate al tornio o al pc, le mille ore servono solo a giustificare la nostra permanenza al tornio o al pc. Senza la suggestione del lavoro, senza la scusa della produzione, cadrebbe il nostro asservimento e quindi la capacità del capitale di imporre la tortura ai nostri corpi e alle nostre menti.
Ma se questo è vero, appare spuntata anche l’arma difensivista, la determinazione di tutelare il lavoro, perché la tutela, come le necessità di deregulation sono due le facce della stessa medaglia mortifera. Fare 8 anni di causa [e chissà quante ore di sciopero, assemblee, convegni, sindacalisti con il pugno alzato (e le brache abbassate, per essere fini)] per meno di € 5000?
Rispettare una costituzione che si fonda proprio sulla governance del lavoro ridotto a simulacro? Ma anche, perché assentire una modifica costituzionale che liberi l’impresa (e lo stato che da privato agisce quale impresa e da pubblico-monolite costituisce ulteriore elemento di spoliazione della ricchezza delle moltitudini)?
6. Il problema (o la soluzione) è che il lavoro non serve, non serve l’impresa, non serve il capitale, e soprattutto non serve la finanza, in quanto moltiplicatore, si ma di morte. Per riprodurre questo mondo di merda, probabilmente (e vado a memoria) basterebbero poche ore di lavoro la settimana. Ma perché, da quando diciamo questa cosa (e sono decenni) si lavora sempre di più, in modo sempre più crudele, dietro retribuzioni sempre più simboliche?
Perché il fine del carrozzone che va avanti da sé è appunto alimentare se stesso attraverso la captazione dell’attività che le singolarità producono in comune. Il lavoro è il momento di interruzione (cortocircuito) della circolazione della vita in comune, interruzione che consente al capitale di appropriarsi di un’energia altrimenti incommensurabile e al contempo giustificazione di quell’interruzione. Senza la costituzionalizzazione del lavoro e quindi del sacrificio, dello sfruttamento, il flusso di attività non troverebbe ostacolo né potrebbe essere catturato.
L’asservimento non è più dato dal lavorare alla catena, ma dal fatto che non ci si può alzare dalla sedia, distraendo pulsioni e atti al farsi moltitudine (farsi moltitudine quale unico ostacolo alla prosecuzione dell’attuale ordine che a sua volta ostacola il processo di soggettivazione).
7. Ma se il lavoro è truffa, anche l’impresa è tale, risultando involucro di raso rosa per la richiesta di denaro e verso l’indebitamento certo e diretto al fallimento (tutto l’attuale interesse del legislatore a recuperare le attività persistenti nella crisi d’impresa va letto in questo senso).
Anche lo stato, infine, è truffa. Meglio, come il lavoro e l’impresa, sogno (incubo). Il sogno perverso di uno stato nazione espressione di una sovranità che non esiste più e che si srotola in coercizioni alla libera disponibilità delle vite e nell’apprensione di ricchezza, attraverso il mito del “salvataggio”.
Lo stato di emergenza (permanente ed emergente sotto ogni aspetto, si tratti di migranti, banche, immondizia, traffico) già mirabilmente sfruttato dalla famiglia Bush, è ora risolto nel proprio correlativo: “il salvataggio.” E’ evidente che chi si trova in emergenza deve essere salvato, e per salvare occorre abbandonare ogni prudenza, dimenticare il fantomatico stato di diritto (se ed in quanto mai esistito), porre mano al portafogli, tutti contenti e UNITI in una rinnovata solidarietà nazionale.
Il nulla a forma di manganello che si libra su occupanti e migranti si staglia ora – nella versione del “salvataggio” – quale candido scettro che l’imprenditore, per altro verso nega; meglio dovrebbe negare, se proprio a questo scettro, lercio e maleodorante non dovesse la propria stessa esistenza, anch’essa, invero assente, perché volta a supportare uno sfruttamento che la presuppone ma non la crea.
8. Dicevo, non può darsi impresa produttiva, non può darsi lavoro produttivo; ciò in quanto, non è quello lo scopo cui mira il capitale. Lavoro e impresa (vista da sempre, come coordinamento – anche – del lavoro) recano la tara dello sfruttamento e, ora, dell’apprensione delle forme di vita, che si darebbero altrimenti, libere e produttive (queste sì). Se si deve parlare di potere costituente e di costituzione futura, pertanto dovrà procedersi dal NON LAVORO e dalla negazione dello STATUTO DELL’IMPRESA, così privando il capitale dei suoi principali mezzi di captazione.