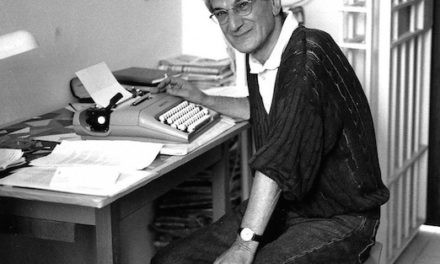di TIZIANA VILLANI.
Presentazione di UBALDO FADINI.
Questo libro di Tiziana Villani, → Ecologia politica. Nuove cartografie dei territori e potenza di vita (Manifestolibri, 2013), mi colpisce per la grande generosità che lo anima, nel senso che non rinvia, magari in modo cifrato, a dei saperi di riserva, da utilizzare con parsimonia e cautela iper-accademica, per così dire, ma esprime direttamente e liberamente il senso di un percorso nel quale la riflessione filosofica, l’analisi multidisciplinare dell’urbano, l’indagine ecologica e politica si coniugano con effetti felicemente produttivi e di forte stimolo teorico.
Per restare a tale livello di franchezza, va subito restituita l’idea-chiave del libro, quella che emerge da una batteria di sondaggi critici che riguardano la dimensione dell’ecologia critica (da Guattari a Gorz), la tonalità anche decisamente esistenziale, oltre che politica, delle territorializzazioni del divenire urbano (da Lefebvre a Virilio), la rischiosa cartografia della smaterializzazione contemporanea, con i suoi spostamenti di valore, di affettività, dentro lo spazio urbano, la lettura di segno ecosofico delle metamorfosi complessive degli assetti e delle configurazioni della soggettività odierna: tale idea è quella appunto di un soggetto – irriducibilmente “vivo”, macchinicamente registrato, tecno-mutante, de-scritto sul piano corporeo a partire dalla sua attuale iscrizione all’interno delle logiche di articolazione della “megamacchina sociale” – che esiste nel momento in cui è costitutivamente associato ad un “ambiente”, ad un “contesto”… a me piacerebbe dire però così: ad un “mondo”.
Sono molte le tradizioni di ricerca che si potrebbero prendere in considerazione, per supportare al meglio tale sforzo di indagine: alcune indubbiamente legate a certa filosofia francese, soprattutto nel momento in cui questa oscilla, con effetti anche fortemente critici, tra la rivisitazione del virtualismo/virtuosismo bergsoniano e l’attenzione ossessiva, di marca fenomenologica, alle trasformazioni dei terreni dell’esperienza, oppure ad una sensibilità di tipo “sistemico” (tra l’antropologia, la sociologia, l’urbanistica, nelle loro “coloriture” più politiche). Villani le ha ben presenti, in particolare laddove tenta una ricognizione a proposito dei caratteri specifici del saccheggio perpetrato ai danni di quell’insieme di fatti, linguaggi, movimenti, stili di vita che ribadisce la sua intima socialità rispetto alle paradossali provocazioni “nichiliste” di un rilancio continuo di avvenire di potere. È proprio nei riguardi di quest’ultimo, di una tensione estrema (estremistica) dei fattori di riequilibrio (pur scontato nella sua provvisorietà di fondo) dei rapporti di dominio dati, che la ricerca di Villani si dispone in modo parziale, “di parte”, ricercando condizioni di creatività indomabile (e di conseguente pensiero critico) nella nostra “stagione all’inferno”, quella che cioè si sviluppa, spesso selvaggiamente, all’interno del territorio post-metropolitano, con il suo sacrosanto richiedere nuovi diritti di esistenza. Di una esistenza che si vuole felice e che proprio perché è associata ad un ambiente (è anch’essa ambiente) pretende di coltivare relazioni di simpatia e di generosità, di proporsi come una realtà viva composta di relazioni e dunque costitutivamente aperta, nella sua parzialità, ben disposta a fare “redazione”, a delinearsi in forma “gruppale”, per così dire (o “gruppuscolare”…). Il carattere vivo di tutto questo dipende in definitiva dalla capacità di avere delle idee, di riuscire a vedere diversamente le cose, visionarle a partire da orizzonti differenti, con i loro carichi e emotivi e affettivi.
Troppa filosofia in questa mia lettura? Può essere, ma l’eccesso va giustificato nel senso (un senso tra gli innumerevoli altri… sia ben chiaro) di riconoscere nel libro di Villani, nel quale la filosofia è opportunamente restituita alla sua essenziale minorità, la presenza di uno sforzo di analisi che va a cogliere con infinita pazienza i segnali di una colorazione della realtà, di una sua effettuazione, certo difficile, sotto la veste della espressione variegata – a livello mentale, sociale, ambientale: ecosofico – dei potenziali di crescita, di maturazione, di una intelligenza produttiva politicamente avvertita. E in quest’ottica non posso fare a meno di ricordare, come fa profittevolmente Villani, la tenacia deleuziana nel sottolineare l’importanza di progettare nuovi spazi di soddisfazione, altre istituzioni rispetto a quelle date in modalità mortifere, per tali potenzialità, quelle che stimolano a fuggire tutti gli inviti alla rassegnazione, ad accettare il primato della cattiva coscienza, del senso di colpa e di tutto ciò che sembra confermare il vincolo a fare della nostra vita il terreno di esercizio di poteri “tristi”, di quei dispositivi di “pseudo”/supplenza che vogliono separarci da ciò che possiamo “fare”, che possiamo tentare di “fare”.
Estratti da Ecologia politica
Dalla Premessa: Che cos’è l’ecosofia?
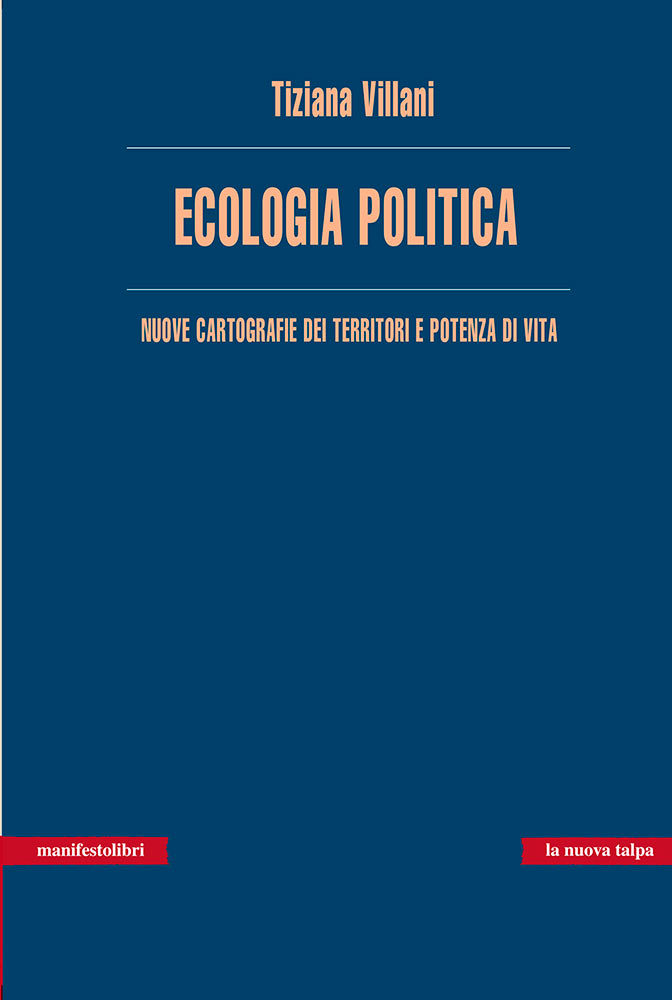 L’ecosofia è la buona pratica atta a risanare le soggettività e gli ambienti laddove le scelte tecnocratiche di ogni sorta e con ogni mezzo avevano invece prodotto “malattia”. L’ecosofia critica, infatti, è una fuoriuscita radicale dal modello sociale, economico e culturale dominante, modello disegnato su configurazioni attualmente permeate da quel modello, poiché implicate nella sfera dei poteri e del dominio piuttosto che sulle relazioni altre, capaci di sperimentare forme di soddisfazione non immediatamente mercificate. Il piano ecosofico è per sua natura relazionale, ambientale e in divenire, è in sostanza il vivente chiamato in partecipazione e articolazione tra impronte diverse.
L’ecosofia è la buona pratica atta a risanare le soggettività e gli ambienti laddove le scelte tecnocratiche di ogni sorta e con ogni mezzo avevano invece prodotto “malattia”. L’ecosofia critica, infatti, è una fuoriuscita radicale dal modello sociale, economico e culturale dominante, modello disegnato su configurazioni attualmente permeate da quel modello, poiché implicate nella sfera dei poteri e del dominio piuttosto che sulle relazioni altre, capaci di sperimentare forme di soddisfazione non immediatamente mercificate. Il piano ecosofico è per sua natura relazionale, ambientale e in divenire, è in sostanza il vivente chiamato in partecipazione e articolazione tra impronte diverse.
La nuova polis necessita di un discorso politico che tenga conto delle mutazioni antropologiche, economico-sociali intercorse. Non si tratta di rivendicare tanto dei diritti quanto di mettere in pratica forme di uso di tutti quei beni che sono necessari al vivere e all’abitare. Il meccanismo di privatizzazione è giunto a un punto perverso.
Con Foucault è allora bene ribadire che la creazione dello spazio pubblico avviene attraverso l’esercizio di un “vero dire”, azione politica questa, che sottrae l’egemonia al discorso anestetizzante della mediatizzazione diffusa. “Dire la verità” è un “passaggio all’atto”.
Ecosofia critica
Riferendosi al “biocapitalismo” e richiamando segnatamente le analisi di A. Gorz dedicate all’“ecologia politica”, U. Fadini pone la questione dell’attuale dominio sul vivente, sottolineando come: «C’è in definitiva un percorso di critica del capitalismo che conduce all’ecologia politica, a una sorta di teoria critica dei bisogni umani, che permette di approfondire e rendere ancora più incisiva la critica stessa: anche in questo senso va colta l’importanza di una esigenza etica di emancipazione del soggetto che rinvia a una imprescindibile critica teorica e pratica del capitalismo, di cui l’ecologia politica rappresenta la componente decisiva, quella più direttamente collegabile con un protagonismo della dimensione della vita, propria dell’età post-fordista, capace di con-tenere al proprio interno la stessa straordinaria dinamicità tecnologica (soprattutto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».1
Ogni riflessione sulla decrescita deve così partire dalla critica dei bisogni umani giocata contro il “biopotere” di un capitalismo nichilista.
L’insieme dei meccanismi di quella che Gorz indicava come la “mega-macchina sociale”2 propone un andamento all’apparenza caotico e ricco di lacerazioni che permette però, a una lettura più attenta, di cogliere alcune verità utili a comprendere le scelte che si vanno compiendo e che di primo acchito toccano un aspetto fondamentale delle società odierne. Le grandi migrazioni di massa con la conseguente trasformazione del lavoro, dell’abitare e del produrre relazioni hanno modificato l’idea stessa dell’abitare, i suoi fini e i suoi modi d’uso. Il tempo dell’approdo sembra essere scaduto al pari del tempo del nomadismo, basti per questo pensare a due problemi sui quali occorrerebbe soffermarsi: la persecuzione delle ultime popolazioni nomadi e il rigetto degli irregolari, clandestini, come pure ormai, dei rifugiati politici.
La città come spazio dell’ospitalità ha ceduto il posto all’iper-polis tecnocratica che seleziona il vivente, umano e non, in funzione delle sue mutevoli necessità d’uso.
Tuttavia il rapporto tra l’uomo e l’abitare non disegna uno spazio neutro, quanto una dimensione essenziale della conflittualità che gli uomini ingaggiano tra di loro. Secondo P. Sloterdijk “Dove si ergono case, lì va deciso cosa deve esserne degli uomini che le abitano. Nei fatti e attraverso i fatti viene deciso a quali costruttori di case debba andare il predominio. Nella radura si mostra per quale posta in gioco gli uomini combattano, non appena si rivelano come esseri che costruiscono città e fondano regni”.3
I territori urbani dell’oggi, diffusi e spesso degradati, non offrono che a minoranze compatibili, e solo per un tempo a scadenza, possibilità di riscatto, lo spazio è sempre più guerreggiato.
La privatizzazione di risorse fondamentali come l’acqua, l’inquinamento di un bene altrettanto vitale come l’aria, lo sfruttamento delle terre attraverso le produzioni delle multinazionali agroalimentari procedono nel percorso di espropriazione dell’ecosistema in cui sino a ora si è declinato il vivente.4
Si potrebbe obiettare da più parti che in fondo in tutto questo non vi è nulla di nuovo, che il capitalismo nel suo percorso si è mosso sempre con finalità similari, eppure alcune novità appaiono invece ineludibili e attengono la velocità e la violenza attraverso le quali questa fase si sta attuando.
La ‘fine dell’utopia’,5 il cinico disprezzo che si riserva anche alla più timida rappresentazione del futuro sono l’indicatore più valido per comprendere il nichilismo vincente che, cancellando il passato e annullando il futuro, dilata virtualmente un presente senza progetto e ammutolito nel miraggio del consumo come unica religione, questa sì, capace di consolazione. Una consolazione coatta che deprime ogni potenza di vita e incanala il desiderio verso blocchi di disagio e paura, veri dispositivi per l’addomesticamento di massa.
È impossibile trascurare il continuo aumento delle patologie connesse all’insicurezza, alla precarietà, alla tensione di un sociale che si avverte come inadeguato o forse più decisamente come piano di una selezione sempre più forte e svincolata da ogni patto di solidarietà.
I territori dell’incertezza sono sia territori esistenziali, sia spazi di un abitare, in cui la spinta compulsiva alla privatizzazione viene intenzionalmente scambiata con la mercificazione della domanda di sicurezza. I pochi contro i molti. Riaprire la considerazione dei territori come espressione delle soggettivazioni che devono trovare e creare ambienti di accoglienza, può voler dire riprendere alcune delle analisi di F. Guattari a proposito dei Flussi: «Tra l’ambito dei Flussi e quello dei Territori esistenziali, si instaura un lisciatura territorializzata, altrimenti qualificata come “grasping”, della manifestazione o della “messa in essere”. A causa di questa lisciatura, una sorta di omogeneizzazione esistenziale – il caso in scadenza indicizzato di intenzionalità – opera in maniera immanente alle “sperimentazioni”, modulari (sensibile ed anche cognitive, memoriali, affettive, immaginarie, ecc.)».6 Affinché la tensione a sperimentare possa realizzarsi bisogna attivare un processo di ripensamento di tutti quei dispositivi della regolamentazione e della paura che gestiscono il diffondersi della credenza che gli orizzonti di sperimentazione semplicemente non esistono se non si correlano agli scenari di un modello capitalistico che nella tarda modernità non maschera nemmeno più il suo volto ultraliberista.
L’annoso dibattito sulla questione del clima, il sostanziale fallimento del vertice di Copenhagen,7 indicano come gli interessi dell’iper-polis siano volti all’imperio di questo presente dilatato, in cui pare sprofondata ogni temporalità, anche a fronte di genocidi, cancellazione di specie, aggravamento irrimediabile della questione ambientale. Insomma il vivente appare pronto a essere sacrificato alla violenza di una tecnocrazia che intende auto-perpetuarsi come sola élite in grado di accaparrarsi l’esistere.
A fronte di quanto detto l’urbano continuano a diffondersi, ma se abbiamo ben colto la portata del processo prima descritto, appare chiaro come questa più che essere una scelta, sia la sola possibilità di fuga e sottrazione ancora praticabile da parte di chi si è trovato a essere obbligato ad abbandonare i propri luoghi di provenienza. Sono proprio i tragitti della fuga a raccontarcene la verità. Gli esodi non hanno più luoghi d’approdo che non siano i centri di concentrazione delle “non persone”,8 in attesa di ottenere un’autorizzazione alla vita. Nelle città gli spazi fatiscenti, diroccati sono cinti da mura, che nulla possono contro la crescente marginalizzazione di popolazioni senza futuro. La “securizzazione” dei quartieri tenta così faticosamente di separare i “salvati” dai “sommersi”.9
A questi movimenti materiali che stanno trasformano l’urbano diffuso su scala planetaria, fa riscontro una condizione mutata del tempo e dello spazio che descrivono la città delle reti, sovranazionale, integrata a livello planetario, i cui flussi e apparati decisionali non necessitano di luoghi specifici, quanto di tecnologie sempre più avanzate, che sono però volte a incentivare il ciclo merce-consumo-merce e a soddisfare una nuova gerarchizzazione dei territori spogliati da ogni vocazione pubblica.
È questa l’iper-polis tecnocratica in cui si consuma la divaricazione totale tra le condizioni materiali di vita e i poteri gestionali. I movimenti dell’esodo sono percorsi costrittivi, perché sono l’esito di strategie economico-finanziarie e militari che spostano, delocalizzano, territorializzano i popoli in una perimetrazione convulsa dei territori, che ha tutta l’aria di una nuova e violenta colonizzazione della vita nell’ambito dell’intero ecosistema terrestre.10
La colonizzazione delle esistenze spesso però non è letta in tutta la sua brutalità, grazie a un sistema della comunicazione che dirama ossessivamente e in modo monotono alcuni predicati: la nostalgia identitaria, laddove le identità vengono cancellate senza farsi troppi problemi, l’eternizzazione della vita biologicamente modificata, nel mentre malattie endemiche e fame cancellano milioni di vite senza che nessuno se ne senta scalfito, l’agio di un consumo opulento e praticamente illimitato, mentre spreco alimentare e settori dell’industria agro-industriale inquinano e si accaparrano le terre e le risorse.11
In questa schizofrenia possiamo leggere il percorso di uno stravolgimento di senso in cui il linguaggio, consegnato al sistema delle comunicazioni e delle tecno-burocrazie, ha perso la sua capacità di interrogazione e di resistenza, sprofondandoci in una crisi di senso e dunque di progetto senza precedenti. Non stiamo assistendo semplicemente al declino del modello occidentale di sviluppo, piuttosto alla recrudescenza di un paradigma antropocentrico, questo sì di matrice occidentale, giunto al punto crisi di un’autoreferenzialità nichilista. Lo scenario in cui si declinano questi eventi è proprio l’urbano schizoide che si dilata, si riconfigura, si “densifica”,12 si ristruttura, si degrada a fronte di gerarchie direzionali che possono benissimo trascurare questa dimensione, costruendo per sé luoghi separati e mirabolanti in un posto qualunque del globo. È davvero fuorviante voler parlare nell’oggi di un naturale perduto, se non si riesce a considerare la portata di tutte queste trasformazioni in costante successione. Il selvaggio, il biologico, la lentezza contro la velocità, il “genuino” contro il modificato restano slogan insensati se non si pone il problema della verità degli accadimenti in corso. A tutto questo non si può rispondere con piccoli escamotage di sottrazione, ma attraverso una rivoluzione culturale che sposti l’attenzione dall’antropocentrismo funesto a un’ecologia sociale che riconsideri la felicità del vivente.
La trasformazione dei territori: il vivente, il non-vivente e il macchinico
Esiste ancora la possibilità di ritrovare il “naturale perduto”? Più precisamente, siamo ancora in grado di procurarci riparo, cibo al di fuori dei modelli economici attraverso i quali abbiamo sviluppato l’arte tecnica del rapporto con l’ambiente? E del presunto ambiente originario e “incontaminato” che cosa ne è stato?
Questi spazi perduti costituiscono un mito, la celebrazione “museificata” di una condizione immemore. Al pari delle lingue che si vanno cancellando, dei popoli senza più memoria e racconto, questi spazi non sono che deboli testimoni virtuali di un mondo archetipico, turisticizzato, in cui usi antichi disegnano solo tracce di folklore.
Le “terre desolate” appaiono come spazi dell’abbandono, della nostalgia, di un primigenio perduto.13
Il massiccio spostamento, indotto direttamente o indirettamente, di milioni di esuli che vagano alla ricerca di luoghi possibili da abitare, ha assunto dimensioni enormi. Questo esilio è senza ritorno. Ciò che si abbandona non è solo il proprio luogo di origine, ma la propria verità costituita da relazioni, occupazioni, abitudini, temporalità, lingua, mentalità, valori. E non si tratta di scelta, ma di sopravvivenza, di libertà dal bisogno e dalla paura. Scrive H. M. Enzensberger: «Gli inevitabili conflitti provocati da una migrazione di massa, si sono inaspriti solo da quando la disoccupazione nei paesi di accoglienza è diventata cronica. Nelle fasi di piena occupazione, che probabilmente non torneranno più, furono reclutati milioni di immigrati come manodopera. Negli Stati Uniti giunsero quasi dieci milioni di immigrati dal Messico, in Francia tre milioni dal Maghreb, nella (allora nda) Repubblica Federale tedesca cinque milioni, di cui quasi due milioni di turchi. Questa migrazione, non solo fu tollerata, ma salutata con grande enfasi. Il clima mutò radicalmente solo quando, in una fase di crescente prosperità, la disoccupazione strutturale cominciò a crescere. Da allora le opportunità degli immigrati sul mercato del lavoro sono calate drasticamente. Molti sono destinati a vivere con i sussidi statali. Altri, di fronte a barriere burocratiche quasi invalicabili, devono vivere in condizioni di illegalità. Le uniche prospettive che rimangono loro sono il lavoro nero e la criminalità. Il pregiudizio diventa in tal modo una self-fulfilling prophecy».14
Da allora gli esodi non si sono arrestati, anzi il movimento di fuga si è fatto sempre più disperato e ha iniziato a incrociarsi con l’ampliamento delle condizioni di vita precarie che attraversano quelle che un tempo erano le economie dominanti.
Si fugge ben sapendo che anche ciò che ci si lascia alle spalle non resterà immutato, sapendo dunque che nulla sarà mai più com’è stato. Si fugge verso l’urbano, nella convinzione che questa sia l’unica condizione in grado di garantire le possibilità e le attese di futuro. Il mondo perduto diventa così il selvaggio da cui siamo stati strappati. È un selvaggio che si inscrive nel mito, nel sentimento della perdita, nell’essere gettati in un contesto di attesa e forse di speranza.
 La ricerca di un’etica ecosofica, nella direzione indicata da Arne Naess, pur presentando alcuni elementi di interesse individua nel mondo “non umano” il piano su cui si esercita un’interferenza eccessiva dell’umano. Nella Piattaforma del movimento dell’ecologia profonda, l’autore richiama un’interpretazione del mondo selvaggio che appartiene a una “ecosfera” in cui «La battaglia per preservare e allargare le aree della vita selvatica deve continuare, mettendo in risalto la funzione ecologica generale svolta da queste aree (per esempio: la biosfera necessita di vaste aree di wilderness perché possa continuare il processo di speciazione di animali e piante). Le attuali aree protette e le riserve di caccia non sono sufficienti per garantire la speciazione dei grandi uccelli e dei mammiferi».15
La ricerca di un’etica ecosofica, nella direzione indicata da Arne Naess, pur presentando alcuni elementi di interesse individua nel mondo “non umano” il piano su cui si esercita un’interferenza eccessiva dell’umano. Nella Piattaforma del movimento dell’ecologia profonda, l’autore richiama un’interpretazione del mondo selvaggio che appartiene a una “ecosfera” in cui «La battaglia per preservare e allargare le aree della vita selvatica deve continuare, mettendo in risalto la funzione ecologica generale svolta da queste aree (per esempio: la biosfera necessita di vaste aree di wilderness perché possa continuare il processo di speciazione di animali e piante). Le attuali aree protette e le riserve di caccia non sono sufficienti per garantire la speciazione dei grandi uccelli e dei mammiferi».15
Il “selvaggio” così inteso è chiamato a curare la ferita della civiltà, dell’interferenza umana, riproponendo il mondo della Natura Madre. Tuttavia, questo mondo non può che essere inevitabilmente privo di speranza, l’ambiente dell’uomo inadeguato a sopravvivere da solo, il mondo della paura e della necessità da cui l’umanità, non ha mai cessato di cercare di strapparsi. Ek-stasi, questa tendenza a superare l’ambiente originario, a riformularlo è la speciazione che non attiene solo l’umano, quanto l’ambiente intero nella sua accezione di dimensione relazionale, performativa e mutante.16
Allora, è lo strappo il motivo di interesse, ossia quel movimento tecno-antropologico proprio dell’umano, che seppur in tutte le sue contraddizioni, non ha mai smesso di tendere verso la “potenza di vita”.
Lo strappo, è ravvisabile nel processo che contraddistingue, come si è a più riprese sottolineato, la rivoluzione urbana del Terzo Millennio. Siamo creature del bisogno, ma siamo anche straordinariamente capaci di inventare nuove prospettive. Forse è allora il caso di andare oltre, di attraversare questa metamorfosi ampliando le possibilità di potenza in essa contenute.
Mi sembra dunque opportuno precisare che il concetto di potenza, e ancor più di potenza di vita, deve ancora una volta inteso nell’accezione spinoziana e non certo “futurista”, del termine. Una potenza che si confronta con la necessità ponendo dunque il problema della libertà: “Si dice libera quella cosa, che esiste per sola necessità della sua natura, e si determina ad agire da sé sola, mentre necessaria, o piuttosto coatta, quella che è determinata da altro a esistere ed operare secondo una certa e determinata ragione”.17
In un mondo modificato e in continuo mutamento attraversiamo questa metamorfosi che riguarda non solo la nostra specie, poiché solo un antropocentrismo ostinato potrebbe continuare a difendere questa posizione, ma il mondo-ambiente che siamo.
Concentrati in spazi assediati da ogni sorta di attività rovesciamo la densificazione spaziale nel virtuale, in questa rete intensa e articolata di comunicazioni, informazioni, territori virtuali, immaginati ed edificati, luoghi di scambio, di produzione e di relazione.
La nostra sensorialità bombardata, da un eccesso di stimoli, diventa sorda, indistinta, afasica, cieca. Il troppo vedere ci impedisce di guardare e scoprire. Il primato del vedere, il linguaggio della visione producono uno slittamento di significato: riconosciamo solo quello che siamo abituati a vedere, mentre l’ampiezza della visione e il gioco della memoria, le creazioni cerebrali sono chiamate a precipitare in luoghi oscuri che faticano a esprimersi. L’immaginario diviene un esercizio secondario del “visuale” codificato.
Lo spazio si riduce, il qui e ora modifica irreversibilmente i modi di vita, diventiamo esiliati nel nostro stesso errare.
U. Fadini, Corpo vivo, conoscenza e autonomia. Letture per far sì che la paura non mangi l’anima, di prossima pubblicazione. ↩
Le ultime analisi di André Gorz si sono concentrate sui temi della trasformazione del lavoro, in relazione ai processi di finanziarizzazione, sempre più autonomi dalla produzione materiale. In riferimento al dibattito sulla decrescita, Gorz pone un interrogativo che ci pare non trascurabile: «La decrescita dell’economia fondata sul valore di scambio è già avvenuta e si accentuerà. Il problema consiste nel sapere se prenderà l forma di una crisi catastrofica subita o quella di una scelta di società auto-organizzata, che fondi un’economia e una civiltà oltre il salariato e i rapporti mercificati i cui germi saranno stati seminati e i loro strumenti forgiati da delle sperimentazioni sociali convincenti», Ecologica, Paris, Galilée 2008, p. 114. ↩
P. Sloterdijk, Regole per il parco umano. Una replica alla lettera di Heidegger sull’umanismo, in “Aut aut”, n. 301-302, gennaio-aprile 2001, p. 128. ↩
In proposito vale la pena di soffermarsi sulla bella analisi di Carlo Vercellone, Rendita, in Lessico marxiano, Manifestolibri, Roma 2009. ↩
Cf. Th. Paquot, L’Utopie, ou l’ideal piegé, 1996, tr. it., di D. Rudelli, Mimesis, Milano 2002. ↩
F. Guattari, Cartographies schizoanalytiques, Galilèe, Paris 1989, p. 149. ↩
Il sostanziale fallimento del vertice di Copenhagen sul clima del 2009 non ha saputo rispondere alla crescente sperequazione tra paesi ricchi e poveri, ma anche al degrado di intere aree divenute discariche contaminanti nei cosiddetti paesi del Nord del mondo. Il problema dei cambiamenti climatici necessita di una più complessiva riflessione e ripensamento sui modelli di sviluppo imperanti. ↩
L’esperienza dei campi di sterminio può servire come chiave di lettura per i moderni processi di espropriazione della vita. Vedi in proposito: P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986. ↩
Cf. A. Dal Lago, Non persone, Feltrinelli, Milano 1999. ↩
È nota l’analisi di S. Latouche che analizza l’attuale crisi alla luce dei processi post-coloniali e indica nella decrescita un nuovo orizzonte politico. Vedi ad esempio: Le pari de la décroissance, 2006, (tr. it. di T. Sitzia, Feltrinelli, Milano 2007); Petit traité de la décroissance sereine, 2007, (tr. it., di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino 2008). ↩
Il rapporto sulla fame del mondo della FAO del 1996, che ipotizzava per il 2015 una sostanziale diminuzione delle persone che soffrono la fame è sconfessato da tutti gli indicatori che parlano di un incremento sempre più sensibile delle geografie della fame a fronte delle geografie dello spreco. Vale anche in questo caso l’invito a pensare in chiave ecologico-sociale non tanto dal punto di vista delle politiche demografiche, quanto della distribuzione delle risorse e del diverso uso delle stesse. ↩
Il consumo di spazio come indicatore economico sempre più rilevante nelle aree urbane soggette a processi di densificazione che spesso non sono altro che il risultato di strategie speculative tese ad immobilizzare i capitali in strutture di nessuna utilità. ↩
Di particolare importanza ci sembrano in proposito le immagini tratte da Eliot: «Nell’ora violetta, quando gli occhi e la schiena Si levano dallo scrittoio, quando il motore umano attende Come un tassì che pulsa nell’attesa, Io Tiresia, benché cieco, pulsando fra due vite, Vecchio con avvizzite mammelle di donna, posso vedere Nell’ora violetta, nell’ora della sera che contende Il ritorno, e il navigante dal mare riconduce al porto». Th. S. Eliot, La Terra desolata, Rizzoli, Milano 2006. ↩
H. M. Enzensberger, Die große Wanderung, 1992, tr. it. di P. Sorge La grande migrazione, Einaudi, Torino 1993, pp. 41-42. ↩
A. Naess, Okology, samfunn og livstill, 1976, tr. it. di E. Recchia Ecosofia. Ecologia, società e stili di vita, Red edizioni, Como 1994, p. 33. ↩
Il movimento dell’ek-stasi assume in Sloterdijk una radicalizzazione dell’esserci heideggeriano, la propensione dell’umano verso un costante movimento di autoproduzione chiama in causa la “meraviglia dell’essere esposti”, del “divenire uomo” che si accompagna al “divenire del mondo”. Sloterdijk P., Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, tr. it. di A. Caligaris e S. Corsara Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger, Bompiani, Milano 2004. ↩
B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, Bollati-Boringhieri, Torino 1992, Parte I, def. VII, p. 6. ↩