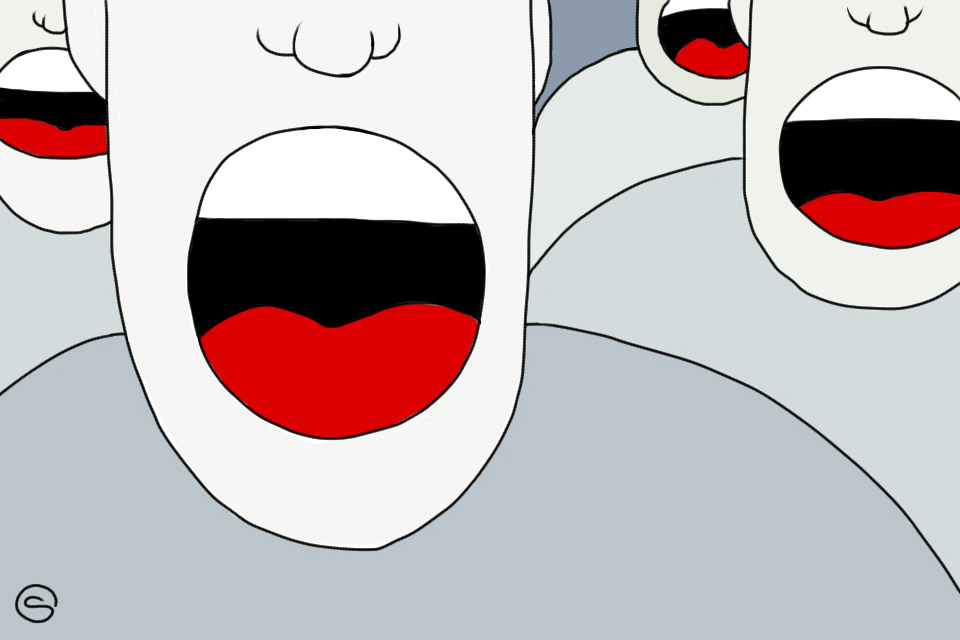Di FRANCESCO RAPARELLI
Nel suo libro più bello e importante, Shock Economy, Naomi Klein racconta nel dettaglio le “avventure” di Jeffrey Sachs, giovane e brillante economista di Harvard che, dalla Bolivia alla Russia e passando per la Polonia, a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo svolge un ruolo di consulenza decisivo per l’esportazione dell’economia di mercato e l’affermazione del Washington Consensus. In particolare, fu Sachs a sollecitare e sostenere la terapia shock che, di colpo di Stato in colpo di Stato (1991, 1993), Eltsin impose in Russia. Terapia che, come noto, vide in Yegor Gaidar il protagonista politico decisivo al fianco di Eltsin, e che avanzò inarrestabile attraverso la svendita delle aziende pubbliche sovietiche (petrolio, nickel, gas, armi), la formazione dei famigerati «oligarchi» (che divennero tali acquistando a prezzi stracciati le ricchezze pubbliche con risorse altrettanto pubbliche), la disoccupazione di massa, un impoverimento drammatico («72 milioni di russi sotto la soglia di povertà in soli otto anni»), il drastico abbassamento delle aspettative di vita, il raddoppiamento del tasso di suicidi.
Considerate le missioni svolte nel mondo e soprattutto in Russia a favore della svolta neoliberale, dalle privatizzazioni all’affermazione dei fondi di investimento, Jeffrey Sachs non può essere certo considerato un nemico dell’Occidente, un sodale del nuovo Zar. Pure Federico Rampini, che vede insolenti sabotatori ovunque, faticherebbe a considerarlo tale. L’intervista rilasciata al Corriere della Sera (1.05) negli scorsi giorni assume dunque un’enorme rilevanza: per i suoi contenuti, ma anche perché questi mettono radicalmente in crisi gli assiomi militareschi che permeano il quotidiano di Milano dalla fuga scomposta – degli americani e non solo – da Kabul in poi. Vediamo i contenuti. A parere di Sachs, «gli Stati Uniti sono più riluttanti della Russia a una pace negoziata»; «quando Zelensky ha lanciato [a fine marzo] l’idea della neutralità, l’Amministrazione americana ha mantenuto un silenzio di tomba»; «se [gli Stati Uniti e l’Europa] vogliono processare Putin per crimini di guerra, allora devono aggiungere alla lista degli imputati George W. Bush e Richard Cheney per l’Iraq, Barack Obama per la Siria e la Libia, Joe Biden per aver sequestrato le riserve in valuta estera di Kabul, alimentando così la fame in Afghanistan». E per concludere: «per salvare l’Ucraina dobbiamo porre fine alla guerra […] abbiamo bisogno di un compromesso in cui la Russia si ritira dalla e la NATO non si allarga»; «un embargo totale su petrolio e gas probabilmente getterebbe l’Europa in una recessione».
Capita raramente che un’intervista, in poche righe, riesca a dire con chiarezza e senza fronzoli tutto ciò che c’è da dire: è questo il caso. Intervista che sarebbe stata sommersa dal rumore mediatico e dei social nell’arco di poche ore, se non fosse stato proprio il Papa a sostenere, con altre parole, concetti assai simili se non identici (3.05, nell’articolo di Luciano Fontana, sempre sul Corriere della Sera). Il Papa, in verità, ha rilasciato dichiarazioni ancora più radicali, asserendo che la guerra serve per «provare le armi»; per venderle certamente, ma anche per provarle e migliorarle, sostituirle, ecc. Ricordando con passione i lavoratori del porto di Genova che, non molto tempo fa, si sono rifiutati di scaricare una nave piena di armi dirette nello Yemen. (Sì, nello Yemen c’è una guerra atroce che va avanti dal 2015, con decine di migliaia di vittime di cui non si parla, che non interessano). Cosa significa, disertare la guerra, se non mettere in campo azioni di questo genere? Fortunatamente il Papa ha avuto il coraggio, oltre l’autorevolezza che a un Papa come Bergoglio spetta, di ricordarcelo.
Ma torniamo a Sachs. Si tratta, nel suo caso, di un’opposizione pacifista alla politica di Biden? In parte, senz’altro. Forse, però, c’è qualcosa in più. Propongo due ipotesi di lettura, tra loro ovviamente connesse. La prima: come ben chiarito in due articoli recenti, rispettivamente da Jürgen Habermas (29.4, Süddeutsche Zeitung) e da Sandro Mezzadra (2.05, EuroNomade), risulta difficile comprendere cosa significhi «vincere la guerra» contro una superpotenza che dispone di un arsenale nucleare tra i maggiori al mondo. È del tutto evidente che, dietro la formula ripetuta a ogni piè sospinto da Biden e Johnson, occorre leggere l’intenzione di prolungare la guerra in Europa quanto più possibile. Per indebolire Putin? Senz’altro, ma anche per «guadagnare tempo» rispetto allo scontro che conta, quello che nei prossimi anni si svolgerà nel Pacifico. Mentre si guadagna tempo, si vendono armi, si indebolisce l’Europa a trazione franco-tedesca – tanto dal punto di vista economico che da quello politico – e la si sottomette più di prima alla NATO, vengono riconfigurate le catene dell’approvvigionamento energetico, in generale le catene del valore secondo il «paradigma Yellen» del friend-shoring, presentato dalla Segretaria al Tesoro USA all’Atlantic Council di Washington. Se le cose stanno così, quale certezza abbiamo che l’escalation nucleare da minaccia russa non si traduca in realtà? E quanto sapranno resistere, le democrazie liberali europee, alla catastrofe economica che, dal carovita alla disoccupazione, si somma allo shock imposto dalla pandemia? Fare del tutto per evitare la soluzione diplomatica significa, né più né meno, esporre l’Europa in particolare e il mondo tutto all’apocalisse.
A mio avviso, però, il realismo politico di Sachs vuole spingerci a riflettere anche sui limiti del friend-shoring, della «ri-globalizzazione selettiva» di cui tanto si parla da qualche settimana. La globalizzazione economica, ovvero la piena affermazione del mercato mondiale, non è un fenomeno reversibile. Davvero pensiamo che le delocalizzazioni e le supply chain possano essere sostituite nell’arco di pochi mesi, riposizionando imprese e approvvigionamenti soltanto in terre amiche? Le difficoltà europee sulle sanzioni, il tentativo americano di rafforzare il dialogo con l’India, la cautela della Cina, che parla esplicitamente della necessità di una rinnovata governance multilaterale, ci dicono che tra globalizzazione e guerra, la guerra in corso che rischia quotidianamente di allargarsi all’intero pianeta, vi è una opposizione forse insanabile. Il limite è indubbiamente la questione nucleare, ma vi è qualcosa in più: far saltare in aria la divisione internazionale del lavoro vorrebbe dire, soprattutto per l’Occidente, far germogliare un nuovo patto sociale, relativo al lavoro e ai salari, al welfare, alla sostenibilità ambientale. Pare evidente che le imprese non siano disponibili a trattare, mentre l’aumento dei tassi di interesse (della Fed in particolare), nonostante la recessione prossima, alimenterà la «tempesta perfetta». Il rischio, in prospettiva, è la proliferazione di zone economiche speciali alternative a quelle cinesi e dell’Est Asia, come d’altronde già succede da anni nell’Europa dell’Est e in alcuni Stati americani. Mentre l’Amministrazione Biden, da un lato stanzia 33 miliardi per l’Ucraina e per la guerra, dall’altro attacca duramente il New York Times perché ha rivelato il decisivo e diretto coinvolgimento, non solo delle armi, ma anche e soprattutto dell’intelligence americana nelle operazioni che hanno colpito e ucciso i generali russi, mentre si progetta un piano di ricostruzione dell’Ucraina da 1.500 miliardi, si tratta di far irrompere nel dibattito un ulteriore realismo politico: solo la pace può favorire la globalizzazione dei diritti, solo la globalizzazione dei diritti può agevolare la pace. Intendendo la parola diritti in senso forte, pensando al fatto che, negli Stati Uniti, l’organizzazione dei lavoratori in sindacato e lo sciopero non sono diritti costituzionali. Non è la guerra che batte l’autoritarismo, è vero invece che disuguaglianza sociale, sfruttamento selvaggio, disoccupazione e impoverimento generalizzati, formano e consolidano populismo, nuovi fascismi, torsioni autoritarie e illiberali. Putin, e quelli come lui, hanno consenso perché si presentano come uomini forti in grado di vendicare i perdenti della globalizzazione. L’economia di guerra, l’aumento dei tassi e la stagflazione, sono già incubatore di una catastrofe politica nel cuore dell’Occidente. Con l’augurio che le timide aperture diplomatiche di queste ore trovino spazio, il problema della pace diventa già da subito, e più che mai, contrastare il mercato senza regole.
Articolo pubblicato originariamente sul Riformista del 11 maggio 2022 e ripreso poi su DinamoPress. Immagine di copertina di Wikipedia.