intervista a GIOVANNI ARDUINO e LOREDANA LIPPERINI.
Morti di fama. Iperconnessi e sradicati tra le maglie del web, scritto a quattro mani da Giovanni Arduino e Loredana Lipperini nel 2013, è una potente narrazione del lato oscuro della rete e del cattivo comune che in rete si forma attraverso perversi processi di soggettivazione e assoggettamento alla mercificazione dell’identità e alle passioni tristi che sono correlate. Il povero Yorick ha intervistato i due autori di questa cartografia del virtuale.
Il povero Yorick. Per cominciare e inquadrare il vostro libro – quantomeno, secondo il nostro taglio di lettura: voi descrivete in modo analitico dei veri e propri processi di soggettivazione, di affermazione identitaria, all’interno delle pratiche della rete. Processi che sono tutt’altro che neutrali: dagli hater alle esplosioni di rancore, dal bullismo cibernetico alla creazione e attacco di identità minoritarie come bersaglio – una per tutti, la categoria dei “vecchi” contrapposta ai giovani –, voi tracciate una vera e propria cartografia delle passioni tristi sulle quali si innervano identità mutevoli contrassegnate dall’ipertrofia dell’ego: una sorta di “cattivo comune” che condivide la parte peggiore, più servile e passiva, della propria mente. Dieci anni dopo il → libro di Benasayag e Schmitt, avete scritto un L’epoca delle passioni tristi 2.0…
LL. Erano leggibili e sotto i nostri occhi, in effetti. La cosa che colpisce è che quando si parla di lato oscuro della rete si tende a sottolineare esclusivamente la molestia effettiva, plateale, lo sbuffo di rabbia razzista o sessista. Non quella apparentemente innocua del rancore, appunto: che è però quella che, dentro e fuori la rete, ci paralizza in un eterno scontento, come è proprio delle passioni tristi. La rete raccoglie quel che si è seminato per un trentennio fuori della medesima: certo, lo rende più potente. Come dice il → collettivo Ippolita, la rete non è un’entità, dunque non esiste né potrebbe mai manifestarsi un “popolo della rete”. Esiste, invece, un macrocosmo di “io” che cercano di prendere luce: senza mai connettersi davvero gli uni con gli altri.
GA. Riprendo il discorso di Loredana: “popolo della rete” è la definizione più fuorviante, subdola e priva di senso degli ultimi anni. Però serve come passepartout per articoli dei quotidiani (“il popolo della rete si arrabbia”, che sembra al massimo il titolo di un poliziottesco anni Settanta, quando invece i frequentatori del web – e non solo – sono soprattutto capaci di piccinerie inusitate) o per giustificare dubbie operazioni commerciali: “al popolo della rete piace questo, al popolo della rete piace quello, quindi è figo, è moderno, è cool”.
Il povero Yorick. L’esergo del vostro libro è un’affermazione del social media strategist Ryan Holiday: «La rabbia e l’indignazione dei fruitori sono la base per il successo di molte operazioni commerciali». L’io rancoroso diventa un brand appetibile per il mercato, ma anche l’occasione per entrare nel mercato virtuale e vendere qualunque merce – a condizione di fare del proprio Io un brand. Mentre forme ancor più raffinate di servitù (una per tutte, Amazon) si impongono con arroganza – ti diamo lavoro, che altro vuoi? – dalla produzione di merci a mezzo merci sembra si sia passati alla produzione di merci a mezzo mercificazione.
LL. E all’identificazione totale di individuo e merce, con assoluto consenso, peraltro. La grande questione che si pone è quella del disvelamento e del riconoscimento reciproco: è molto difficile rendersi conto di essere un brand, e dunque mercificati, nel momento in cui viene ripetuto che stiamo prendendo parte al più grande processo di libertà e democrazia mai concepito da mente umana. Ancor più difficile riconoscere questa stessa mercificazione negli altri: è difficile anche quando la servitù è concreta, dal momento che il magazziniere schiavizzato di Amazon usa probabilmente l’iPhone prodotto grazie alla servitù dell’operaio Foxconn, il quale, a sua volta, ordinerà oggetti su Amazon.
GA. Leggo spesso di corsi per diventare un brand. In realtà non servono. Se accedi a Facebook, giusto per fare un esempio, lo sei già. Sei un prodotto (forse poco utile) con una marca (magari scarsamente allettante o azzeccata) ma vieni comunque venduto o usato in quanto merce, anche di scambio. Quanti ne hanno la coscienza? Dall’esperienza mia e di Loredana, davvero pochi, anche se pare assurdo. Le regole dei social sono chiare fin dall’inizio: gioca con noi mentre noi giochiamo con te. O sulla tua pelle (affermazione ad alto rischio di venire additata come neoluddista).
Il povero Yorick. «Il percorso iniziato con i reality e passato per l’epopea politica dei Cinque Stelle dimostra che le persone non titolate sono il vero brand dei nostri anni. Quel che viene dalla “gente” è affidabile, sincero, profondo, non contaminato dalla professionalità. La gente è buona perché la Rete è Buona, così come era ed è Buono il Popolo» (p. 67). Questo passo sintetizza una potenziale riflessione politica (ricordo che il vostro libro è stato chiuso nel luglio 2013); e non credo sia un caso la citazione di una “lezione” del 2009 di Gian Roberto Casaleggio sul ruolo degli influencer [→ qui], o la presenza dello slogan “vinciamo noi”, poi diventato un hashtag grillino, in un tweet cyberbullistico del gennaio 2013 (p. 37). A distanza di un anno, mi sembra che questa osmosi tra il “cattivo comune” della rete e le forme di articolazione politica non sia più limitato al M5S: potete articolare meglio questi frammenti di critica politica?
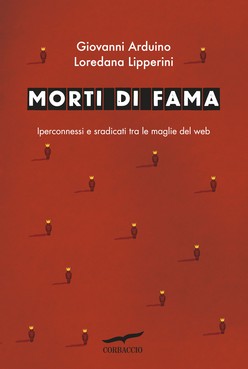 LL. La politica, in assoluto, segue le leggi del marketing: il movimento Cinque Stelle (o, per meglio dire, il fondatore effettivo che è Gian Roberto Casaleggio) ha saputo imporle con notevole tempistica, ma oggi quasi tutti seguono lo stesso principio. La rete, in particolare, crea l’illusione di verità proprio perché è portatrice delle parole del Popolo Buono: altrimenti non ci si spiegherebbe perché gli autori autopubblicati spendano decine di migliaia di euro o di dollari per recensioni fasulle, che sanno bene essere tali. Per avere, appunto, l’illusione della verità. Ma in questo gioco di specchi, secondo il quale il politico è buono se si configura come tuo riflesso, si precipita ogni progettualità verso il basso. Dunque, si resta fermi nel fondo.
LL. La politica, in assoluto, segue le leggi del marketing: il movimento Cinque Stelle (o, per meglio dire, il fondatore effettivo che è Gian Roberto Casaleggio) ha saputo imporle con notevole tempistica, ma oggi quasi tutti seguono lo stesso principio. La rete, in particolare, crea l’illusione di verità proprio perché è portatrice delle parole del Popolo Buono: altrimenti non ci si spiegherebbe perché gli autori autopubblicati spendano decine di migliaia di euro o di dollari per recensioni fasulle, che sanno bene essere tali. Per avere, appunto, l’illusione della verità. Ma in questo gioco di specchi, secondo il quale il politico è buono se si configura come tuo riflesso, si precipita ogni progettualità verso il basso. Dunque, si resta fermi nel fondo.
GA. “Il popolo della rete si arrabbia” (vedi sopra) è spesso il titolo che apre un qualsiasi articolo o introduce un qualsiasi discorso sui Cinque Stelle. A costo di ripeterlo e tanto per chiudere il cerchio, “popolo della rete” è una comoda definizione passepartout che non significa nulla. E come passepartout, come grimaldello viene utilizzata, spesso per dare un volto a emozioni primarie (odio, rabbia, paura, amore…) o a certe caratteristiche di base (cattiveria, bontà…) e per creare speranze o illusioni o babau, non certo una rappresentazione ipoteticamente fedele del reale o del virtuale (sempre che esista una netta separazione tra i due).

















