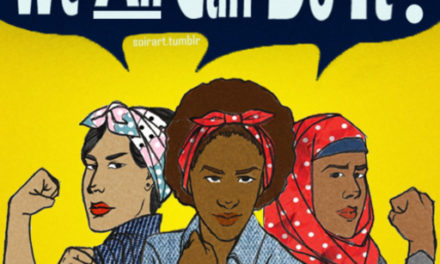Di FELICE MOMETTI.
Jake Sullivan è tra i consiglieri politici più ascoltati di Biden. Prima ancora era stato consigliere politico di Hillary Clinton e di Obama. Nel febbraio dello scorso anno ha pubblicato su «Foreign Policy», tra le riviste di punta dell’establishment democratico, un articolo dal titolo L’America ha bisogno di una nuova filosofia economica, con sottotitolo Gli Stati Uniti non possono avere una buona strategia se sbagliano la politica economica. Era il mese della seconda richiesta (fallita) di impeachment nei confronti di Trump. Le primarie democratiche non erano ancora iniziate e Trump aveva tutti i sondaggi dalla sua parte. L’articolo, che venne poco o nulla considerato, sollevava una serie di questioni che allora non era proprio al centro della riflessione teorico-politica dei think-tank del Partito Democratico. Si sosteneva che dopo quarant’anni di neoliberismo era necessaria una svolta profonda per ristrutturare l’intero modo della produzione e riproduzione sociale, che lo Stato federale doveva essere un attore decisivo negli investimenti in infrastrutture, tecnologie innovative ed istruzione, necessari per indirizzare i flussi delle catene globali del valore. Che bisognava produrre grosse quantità di «debito buono e non cattivo» (Draghi userà la stessa formula un anno dopo) e la trumpiana riduzione delle tasse ai ricchi e alle multinazionali non era altro che un’ideologia zombie. Il capitalismo autoritario cinese, per usare la terminologia di Sullivan, sta sfidando la democrazia di mercato americana come modello prevalente, mettendo a dura prova il patto tra i governi e loro popoli. La filosofia economica da adottare avrà un importante ruolo nel determinare il successo o il fallimento degli Stati Uniti nel contesto geopolitico globale.
Detto in sintesi: lo scontro è tra due modelli di capitalismo e la relazione tra valorizzazione capitalistica e riproduzione sociale, a livello nazionale, riguarda direttamente anche le strategie di politica estera, cioè l’influenza egemonica globale.
La pandemia, la George Floyd Rebellion, l’elezione di Biden hanno accelerato processi in gran parte già in atto, tanto da rivalutare le teorie di Sullivan. Con un’aggiunta: per implementare politiche sociali ed economiche di tale portata, che hanno anche una valenza geopolitica, il potere deve essere sempre più concentrato nelle mani del Presidente e dell’esecutivo in modo da bypassare o almeno esercitare una qualche forma di controllo sul Congresso e soprattutto sul Senato. Biden, in questi otto mesi di presidenza, ha emesso 63 ordini esecutivi e 37 memorandum. Un record dalla fine della Seconda guerra mondiale, dai tempi di Truman. Gli ordini esecutivi e i memorandum, che sono utilizzati come un equivalente di un ordine esecutivo, non prevedono alcuna successiva approvazione legislativa e, pur non essendo esplicitamente previsti dalla Costituzione americana, sono diventati degli strumenti senza confini normativi. Possono riguardare questioni politiche, sociali, economiche, istituzionali, di politica estera, e Biden vi ha fatto ricorso in tutti questi campi. Solo i giudici federali e la Corte Suprema hanno il potere di sospenderli o bloccarli. La competizione con il «rivale strategico» è fatta anche di decisioni rapide, di riduzione fino – in alcuni casi – all’azzeramento dei tempi della democrazia liberale. Non si può competere con il potere sconfinato di Xi Jinping e degli altri sei uomini del Comitato permanente dell’Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese, attardandosi più di tanto con le procedure istituzionali di controllo e bilanciamento dei poteri. Il capitalismo di qualsiasi forma e natura, nelle fasi in cui la crisi si combina alla riorganizzazione del suo modo di produzione, non prevede alcun tipo di democrazia. Dalla fine di marzo dello scorso anno – il momento in cui dilaga la prima ondata della pandemia negli Usa – a oggi, gli interventi in campo economico, sociale, logistico, tecnologico dello Stato federale superano gli 11 mila miliardi di dollari, dei quali 6.400 già stanziati. Un valore monetario che corrisponde a quasi il 50% del prodotto interno lordo.
Siamo di fronte al più grande intervento politico-economico della storia degli Stati Uniti.
Mentre Trump imperversava su twitter con teorie fantasiose e pericolose sul virus, suggerendo cure miracolose, un accordo tra senatori democratici e repubblicani permetteva di approvare il Cares Act. Un pacchetto di 2.200 miliardi suddivisi tra helicopter money (denaro a pioggia) a tutti i contribuenti, finanziamenti a fondo perduto, crediti di imposta e detrazioni fiscali alle imprese e alle attività commerciali, indennità di disoccupazione, borse di studio e prestiti agli studenti, una moratoria dei pignoramenti e degli sfratti. Con l’uccisione di George Floyd esplode una rivolta che, tra la fine di maggio e i primi di novembre ha mobilitato circa 26 milioni di persone, con 10.300 manifestazioni in 2.700 località degli Stati Uniti. Una sollevazione che, oltre alle dimensioni, ha mostrato alcuni tratti inediti rispetto al passato per composizione sociale e percorsi di soggettivazione. La partecipazione di significativi settori di giovani bianchi e latini, la rapida politicizzazione dei soggetti e delle forme di lotta. Quindi, più che la repressione su vasta scala diventa efficace il recupero della protesta attraverso riforme della polizia (oggi tutte sepolte negli uffici del Congresso), una qualche forma di redistribuzione della ricchezza e la cooptazione di settori di movimento nella galassia delle Ong «democratiche». Il tutto condito con appelli all’antitrumpismo. Infatti in dicembre, con Trump sconfitto alle elezioni e impegnato nella ricerca di complotti mondiali contro di lui e Biden non ancora entrato in carica, con un nuovo accordo tra senatori democratici e repubblicani viene approvato il Consolidated Appropriation Act. Un intervento economico-sociale di 2.300 miliardi di dollari. Lo schema del provvedimento ricalca in gran parte quello del precedente Cares Act con sussidi e distribuzione di denaro ma con maggiori spese militari e investimenti nelle infrastrutture della logistica. La fine ingloriosa della presidenza Trump, da molti mesi scavalcato nel potere decisionale in campo economico dal gruppo di senatori repubblicani che fa capo a Mitch McConnell, coincide con la conclusione della prima fase dei finanziamenti e degli investimenti per mantenere le condizioni della riproduzione della società durante la pandemia e dopo la rivolta dei mesi precedenti.
L’amministrazione Biden, nei primi mesi dopo l’insediamento, si muove per operare un salto qualitativo in campo politico, economico e istituzionale. Innanzitutto, si vuol ridare una credibilità politica e decisionale alla presidenza, minata dai comportamenti di Trump, e contenere il protagonismo e il potere politico dei governatori dei quattro Stati cardine della federazione: California, Texas, Florida e New York. Un protagonismo e un potere accresciuti durante la pandemia e la rivolta forzando le costituzioni dei singoli Stati rispetto alla costituzione federale. Paradossalmente, ma poi nemmeno tanto, è il governatore democratico dello stato di New York Andrew Cuomo, oggi dimissionato in quanto molestatore seriale di donne alle sue dipendenze, che si spinge più lontano nel tentare di modificare nei fatti l’architettura istituzionale dello Stato federale. Nei mesi più duri della prima ondata della pandemia diventa l’alter-ego di Trump e avvia un coordinamento politico, economico, istituzionale – nelle sue intenzioni da rafforzare progressivamente – con il Massachusetts e il Connecticut. Anche in questo caso all’insegna dell’antitrumpismo ma in realtà come una possibile anticipazione di nuovi rapporti di forza istituzionali con lo Stato federale.
Un secondo aspetto importante dell’amministrazione Biden, emerso fin dalle prime settimane, è il suo essere allo stesso tempo governo e governance.
Una struttura ibrida nel suo modo di funzionare e di prendere le decisioni, non potendo affidarsi completamente ad una maggioranza risicata, piuttosto eterogenea, alla Camera dei Rappresentanti e al solo voto di Kamala Harris per prevalere al Senato. All’esecutivo ristretto, se così possiamo definirlo ‒ formato da Biden, dal Segretario di Stato Antony Blinken, da Janet Allen, ex presidente della Federal Reserve, e dal generale Lloyd Austin, uomo del Pentagono ‒, si affiancano allo stesso livello il Consiglio Economico Nazionale con a capo Brian Deese legato a BlackRock – il fondo di investimento finanziario più grande del mondo ‒ e il Consiglio della Sicurezza Nazionale in cui Jake Sullivan ha un ruolo di primo piano. Un governo/governance nato come iniziale necessità, visti i numeri del Congresso, che nel giro di qualche mese è diventato forma e sostanza del potere politico, economico e militare. È in questa struttura di potere che si elabora il Build Back Better Plan. Un intervento da 7 mila miliardi di dollari che ha come priorità l’implementazione di tecnologie avanzate nelle infrastrutture della logistica, lo svolta green dell’industria automobilistica, la drastica riduzione dei combustibili fossili nella produzione di energia, l’ammodernamento tecnologico ed energetico del patrimonio edilizio. Ad oggi è stata approvata dal Congresso la prima tranche da 1.900 miliardi di dollari facendo leva sulla divisione del partito repubblicano al Senato. Una seconda tranche dedicata alle infrastrutture è attualmente in discussione al Senato.
Difficile prevedere se il Build Back Better Plan andrà in porto negli stessi termini in cui è stato concepito ‒ le resistenze e le rendite posizione sono molte ‒ perché non si tratta solo di una ristrutturazione dell’intero sistema della produzione sociale ma anche, implicitamente, di un diverso rapporto tra una governance esecutiva e le assemblee elettive, tra stato federale e singoli Stati. In altri termini la prefigurazione di una nuova Costituzione materiale.
Il messaggio dell’amministrazione Biden è chiaro: la transizione verso un nuovo ordine politico istituzionale dello Stato è iniziata. E il caotico ritiro dall’Afghanistan, considerato non più teatro strategico ormai da una decina di anni, insieme ai recenti discorsi di Biden sulla fine «dell’era delle grandi operazioni militari per ricostruire altri paesi» e all’accordo Aukus con Australia e Regno Unito preludono anche a una diversa collocazione degli Usa sullo scenario globale: dalla crisi della loro influenza egemonica a un’ingerenza performativa solo nei contesti valutati come strategici. Ma come in tutte le transizioni, ancor di più di queste dimensioni, l’esito non è mai scontato. Entrano in gioco i rapporti di forza tra gli Stati, nelle organizzazioni sovranazionali e l’opposizione dei movimenti politici e sociali. Un dato è certo: negli Stati Uniti si stanno ridefinendo i rapporti politici, le forme di governo, gli assetti istituzionali e i processi di valorizzazione del capitalismo contemporaneo.
Questo articolo è stato pubblicato su Connessioni Precarie il 25 settembre 2021.